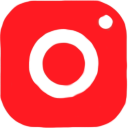TRADIZIONI
Non è vero che è solo del Nord: la polenta ha una sorella (quasi) gemella in Sicilia
Dallo studio di un gruppo di ricercatori, tra i quali Marina Castiglione dell'Università di Palermo, si è scoperto che proprio la polenta non sarebbe strettamente legata al Nord Italia

La "Frascatula", una tipica farinata siciliana
Così è, ad esempio, per la polenta.
Grazie, però, alle ricerche condotte da un gruppo di studiosi tra i quali Marina Castiglione, docente di Scienze umanistiche all’Università degli Studi di Palermo, Vito Matranga e Roberto Sottile, si è scoperto che proprio la pulenta non sarebbe strettamente legata alle regioni del Nord Italia.
«Bisogna precisare - ci ha detto la professoressa Castiglione - che il legame tra questa pietanza e una precisa zona dello Stivale è posticcio, per un fatto molto semplice.
Le polente erano una preparazione in uso a tutte le regioni romane, era un alimento latino e perciò veniva consumato da Nord a Sud, senza alcuna distinzione geografica; ne parlava già nei suoi scritti Varrone».
Queste dettagliate notizie sono state riportate nella sezione alimentare dell’Atlante Linguistico della Sicilia (ALS) progetto diretto dal professore Giovanni Ruffino, nato nel 1987, con un corso di formazione per ricercatori che, ad oggi, ha pubblicato 35 volumi dedicati agli assetti arcaici e contemporanei del repertorio linguistico della Sicilia.
Se all’inizio si pensava non vi fossero chissà quali testimonianze da reperire, i ricercatori si sono presto dovuti ricredere, scoprendo, tra le altre cose, che delle farinate siciliane, perfettamente comparabili alla polenta, se ne hanno traccia in circa 100 luoghi nell’Isola, con una variabilità di nomi considerevole (relativa al tipo di cereale, sostanzialmente utilizzato).
Con l’arrivo in Sicilia dei Romani, notoriamente "mangiatori di polenta" (puls farris), anche l’Isola conobbe il frumento e con esso il suo uso più semplice, ossia la cottura della farina in acqua insieme a verdure o legumi.
Se la polenta settentrionale ha come ingrediente principale la farina di mais, questa giunse nel Mediterraneo soltanto a partire dalla conquista delle Americhe, quindi in Sicilia si preparavano forme più arcaiche di polente, normalmente consumate con una consistenza più liquida, quasi come una zuppa.
A seconda della coltivazione del cereale, dunque, ogni preparazione acquisiva un nome specifico.
Ad Licodia Eubea, ad esempio, si chiamava patacò, tra Cerami e Troina la piciocia (che si faceva con un soffritto di ciccioli o pancetta di maiale in cui successivamente si mettevano a bollire manciate di farine miste, di ceci, cicerchie e piselli).
Nel calatino la mintarrimina (ciò aggiungi e rimescola) si preparava con la farina di frumento e i finocchietti selvatici; a San Michele di Ganzaria si consumava il chiullu, con l’aggiunta di salsa di pomodoro.
E poi a Mascalucia c’era la paparotta, consumata prevalentemente in inverno; nel “rriminuni” di Petralia Soprana si trovavano anche le noci; il pitirri era tipico della Valle del Platani.
La “pulenta” di Casalvecchio siculo, invece, si faceva con la farina di castagne; la “ciciotta” di Riesi è con farina di ceci; il “farfallu” di Adrano con farina mista di ceci e piselli.
«Un elemento lega tutte queste preparazioni - ci ha detto la professoressa Castiglione - erano piatti estremamente poveri, legati al mondo della campagna e non solo, e di facile e veloce preparazione.
Sembra che fosse la preparazione propria del periodo di Guerra e per questo, probabilmente, passata quell’epoca forse molti hanno voluto accantonare questo ricordo legato ad una grande momento di sofferenza».
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
SOCIAL E WEB
La cicogna prende "Il Volo": chi è il tenore (siciliano) che diventa presto papà
130.879 di Redazione -
CINEMA E TV
È palermitana e la vedi ancora su Rai 1: chi è la nuova attrice in "Mina Settembre"
101.385 di Redazione -
STORIA E TRADIZIONI
Lasciò marito e figli, rischiò il carcere: una nobile siciliana fece follie per D'Annunzio
77.220 di Maria Oliveri

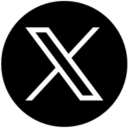



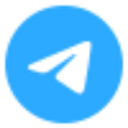


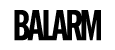





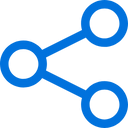
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram