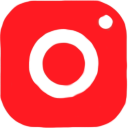STORIA E TRADIZIONI
Rituali e pozioni contro "lu medicu saputu": i rimedi della medicina popolare siciliana
Erbe e pozioni, riti e gesti, preghiere e scongiuri erano utilizzati nel vecchio mondo contadino per sconfiggere le disgrazie e le malattie che si abbattevano inesorabili

Teofilo Patini, "Pulsazioni e palpiti", 1882 ca., olio su tela, 135x176 cm, l'Aquila, Collezioni d'Arte, dettaglio
Nel vecchio mondo contadino il medico compariva invece tardi e la sua competenza era spesso messa in discussione e rimpiazzata da altre figure predominanti, la comare sperta, il barbiere, il prete o, nei casi più disperati, il mago, in grado di sovvertire le leggi della natura sfruttando entità e poteri sovrannaturali.
La stessa malattia, in effetti, non riguarda esclusivamente la sfera biologica, fisiologica dell’individuo, ma mette in scena uno stravolgimento d’ordine sociale, un sistema di credenze e gesti che trascina il malato e coloro che gli gravitano intorno in una sorta di psicodramma collettivo e condiviso.
Essa rompe l’equilibrio, già fragilissimo, della condizione umana, genera quella crisi delle certezze che destabilizza tutto e tutti e, non di rado, apparecchia il posto a tavola a un ospite indesiderato e terrifico, la morte.
Il contadino siciliano, con la sua tempra forte e vigorosa, superava ogni difficoltà e ostacolo, eccezion fatta per li disgrazii, malattie fulminanti come la polmonite e la malaria, che trascurate, mal curate, sottovalutate o trattate in modo casareccio, conducevano presto alla morte.
Si snobbavano il parere e i suggerimenti del medico, considerato spesso un professionista avido, interessato a far più soldi possibili con i malanni altrui o venuto ad ammazzare il proprio paziente, e si seguivano invece i rimedi tradizionali proposti da consiglieri e guaritori d’occasione, giunti in casa dell’infermo spontaneamente o intenzionalmente invitati: sapi cchiù lu malatu patutu, ca lu medicu saputu, si diceva!
Il primo a sminuire la malattia era il contadino stesso che non poteva e non voleva perdere preziose giornate di lavoro: chista è tinturia (‘malessere d’incubazione’), no malatia! diceva magari e se ne andava per i campi.
La casa dell’infermo si riempiva a tutte le ore del giorno e della notte di vicini, parenti, amici e compaesani, venuti a far visita a frotte, a dare aiuto, dispensare consigli medici, portare doni e frutta fresca, scacciare moschine che gli fossero ronzate intorno, somministrargli la terapia all’ora esatta e disquisire a voce alta della malattia stessa pure davanti al sofferente che sentiva tutto: del resto più lunghe, affollate e continue erano le visite, maggiore era l’affetto e soprattutto il rispetto dimostrato a chi si ammalava e alla sua famiglia.
Una lunga teoria di rimedi alternativi si dispiegava allora in soccorso del paziente: fazzoletti stretti alle tempie e scongiuri per il malditesta (nun haju nenti, testa di sceccu, picchí ti lamenti?), pozioni rinfrescanti ed erbe medicamentose (in caso di malaria si applicava per tre giorni un impacco di ortica sul polso della mano sinistra), brodo di pollo e cristalloterapia, immagini o reliquie di Santi nascoste sotto il cuscino, ramoscelli benedetti e, nei casi estremi, allorché si fosse sospettata la fattura, il coinvolgimento della magara.
Se falliva anche lei non era però colpa sua: si aveva probabilmente a che fare con un mago o una maga ben più potente!
Salomone Marino racconta un episodio vissuto in prima persona nell’agosto del 1875.
La maga Ticchi-Ticchi, chiamata per intervenire su un paziente gravemente ammalato di malaria, dopo aver osservato con attenzione il suo corpo e la stanza in cui si trovava e dopo aver chiuso gli occhi con le proprie mani, come a riflettere nella propria intimità, dichiarò che si era dinanzi a una fattura molto potente.
Preparò allora tutti gli arnesi per il rituale e dopo aver sparso agli angoli della stanza sale sciolto in acqua, tra formule incomprensibili e segni della croce letteralmente scagliati nell’aria, pose erbe secche tritate sul petto dell’ammalato e sette pezzettini di filo di lino crudu (‘grezzo’) ai suoi piedi, recitando un primo scongiuro: Vi salutu, pani e tassu (pianta conifera tossica e velenosa, con proprietà anticancerogene, detta anche “albero della morte”), / lu càudu e lu friddu ccà lu lassu (‘lascio qui il caldo e il freddo’); / allèggiu la testa, m’aggravu a li peri (‘alleggerisco la testa, m’aggravo sui piedi’), / torna e riveni la saluti arreri!
Seguirono preghiere come il Credo e l’Ave Maria mentre bruciava l’incenso e, infine, l’ultimo e più potente scongiuro, declamato sbattendo il seno nudo sul pavimento, mentre le altre donne di casa la imitavano.
Ti toccu e nun ti toccu! Ti viju e nun ti viju! / Furcu, Befurcu, Lurcu, Cataturcu (nomi probabilmente riconducibili a esseri, spiriti - comando)! / Ti curcu (‘stendo’), ti sturcu (‘ti spezzo’), t’infurcu (‘ti afforco’), / cu acqua e sali e ‘ncenzu chi la virtù àvi (di farti gran male)! / Pri li chiaghi (‘piaghe’) di Gesù, nun cci accunsentu (‘io non approvo’)! E ‘ncenzu e sali e acqua ogni mumentu! / Dintra la fossa / li luti (‘vermi della decomposizione’) e li scruzzuti vilinenti (forse altri vermi o insetti velenosi) / sutta li denti ti strùdinu (‘ti rosicchiano’) l’ossa!
Dopo sei giorni, conclude Salomone Marino, il malato miracolosamente guarì. Colui che vinceva una disgrazia, che era andato a chiddu munnu ("nell’aldilà") ed era ritornato tra i vivi, andava festeggiato come un risorto che è ccà, cu la grazia di Diu!
Quando invece il malato peggiorava, venivano evocate coincidenze che dimostravano l’inesorabile sopraggiungere della morte, dal latrato di un cane avvertito la notte prima al gufo sentito cantare o visto svolazzare sul tetto della casa.
Nel frattempo il malato sentiva tutto, a tal punto che il viatico o l’Estrema Unzione erano sicuramente il male minore rispetto ai chiacchiericci sul suo stato fatti ad alta voce da amici e parenti, ai loro sguardi rassegnati, alla loro gestualità manierosa ed eccessiva e persino alle cose che gli chiedevano prima che entrasse in agonia, ossia quali vestiti desiderasse indossare una volta morto, se il suo sàvanu (‘lenzuolo funebre’) fosse pronto o che tipo di funerale avesse gradito.
Poi arrivavano le richieste dei figli (soldi e oggetti, soprattutto arnesi di lavoro, secondo il proverbio che recita: Lu patri si nni va, la robba arresta) e l’autocelebrazione della moglie che non mancava mai di rinfacciare, davanti al numeroso “pubblico” presente, fedeltà integerrima, privazioni o percosse subite.
Se invece si fosse ammalato un bambino, intervenivano solo la madre, le donne di casa e la maga. Il medico non era per niente considerato.
Dinanzi all’inevitabile, la stessa madre provava l’ultimo rimedio, il succo del torsolo di pannocchia (l’ovu di canna), che, dopo tre giorni di somministrazione, guariva o avvelenava.
Se non avesse funzionato neanche questo, nessun pianto di disperazione, nessun rèpitu: Gloria e Paradisu! Iddu è Ancileddu in Celu: allegri e pinsati a vui!
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
STORIA E TRADIZIONI
Le 10 suore morte in un monastero: quando Camilleri scoprì un segreto dei Gattopardi
282.380 di Maria Oliveri -
SOCIAL E WEB
La cicogna prende "Il Volo": chi è il tenore (siciliano) che diventa presto papà
131.195 di Redazione -
CINEMA E TV
È palermitana e la vedi ancora su Rai 1: chi è la nuova attrice in "Mina Settembre"
101.497 di Redazione -
STORIA E TRADIZIONI
Avevano l'oro bianco, Franca Florio le rifiutò: donne e "matri" (senza nome) in Sicilia
83.204 di Susanna La Valle

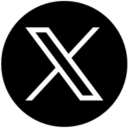



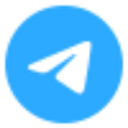


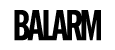





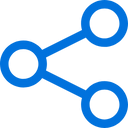
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram