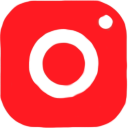STORIA E TRADIZIONI
Cosa si diceva (e cosa no) sul sesso in Sicilia: quando il solo destino era quello di sposarsi
La curiosità, soprattutto al femminile, in alcune famiglie di neanche troppo tempo fa. Dubbi e doveri che iniziavano dal ricamo della dote, a bottega dalla "maistra"

"Cosi ca a picciridda si trova quannu è ranni, i giucattuli cosi inutili sunu! Non nenti si sfasciunu, ammeci chisti su cosi ca aggiuvunu".
Era questo il consueto commento che accompagnava ogni regalo. Tutte le volte che venivano a casa amiche, parenti, vicini, dovevo mostrare con orgoglio ed entusiasmo le meraviglie che mia madre custodiva in un baule appositamente comprato per contenere sogni e speranze camuffati da biancheria e gioielli.
Ed accadeva abbastanza spesso. Secondo una anziana zia di mia madre non mettevo abbastanza gioia, nel mostrare la mia "dote" : «pari ca quasi ti siddii, ammeci a jessiri cuntenta, i genti u capisciunu! E chi ponu pinsari? Tu non sai quanti vulissunu jessiri o to posto! E quanti figghi di matri disiunu chiddu ca tu schifii! U Signuri ti castiga!»
«Tu sti cosi ci lla fari vidiri cuntenta! E poi no comu capita prima! Pi comu ti vvissaju io, a cuminciari di cosi giunnaleri a finiri chi cosi cchiù fini! E poi ti lla ricurdari cuè ca ti rialau ogni cosa, accussì chiddi ca spinnenu assai fannu bella figura e chiddi ca ficinu i misarabili fanu na mala figura! Accussì si ‘nsignunu pa prossima vota!».
Cominciavo a sentirmi già "sbagliata", perché non apprezzavo ciò che "dovevo" e perché avrei preferito una bambola al posto della tovaglia per dodici riccamente ricamata o del bracciale d’oro di venticinque grammi!
L’idea di non essere "normale" mi spaventava al punto che cercavo di fingere gioia nel mostrare tutte le belle cose che avevo per quando mi sarei sposata.
In proposito non esisteva il minimo dubbio: mi sarei sposata!
Sentivo ripetermi continuamente da tutti: «Un jonnu quannu si ranni, u Signuruzzu ti farà ‘ncuntrari un carusu beddu, bonu, ducatu, ‘ntiliggenti, travagghiaturi, ca sa fattu u suddatu e accussì ti mariti subbutu!».
Dovevo vivere solo per prepararmi raggiungere quell’unica e perfetta mèta. Ogni istante delle mie giornate serviva a rinfrescarmi la memoria.
Anche quando giocavamo io e le mie compagne, recitavamo il ruolo delle madri, affaccendate a lavare, stirare, cucinare, e visto che le bambole scarseggiavano, qualunque oggetto avvolto in una pezza, diventava un figlio da accudire a al quale ripetevamo gli insegnamenti delle nostre madri: - non ti ‘lluddari, ora ca si vistutu pulitu, annunca i genti chi ponu pinsari? Ca hai na matri lurda?
E i dialoghi fra noi "mammine" erano identici a quelli delle nostre mamme, quando conversavano: - matri mia, signora, stu figghiu mi fa biliari assai!
Possibili ca mancu finisciu di cangiallu ca subutu si fa stari na fitinzia?Non ci bastunu robbi puliti, e io sempri ca lavu, e i duluri ‘nda l’ossa mi stanu mangiannu viva! - a cu ci u dici signuruzza mia, io cu tri figghi e un maritu non aiu tempi di nenti, sempri appressu a iddi, sempri ca travagghiu e iddi su sempri ‘ nsivati! Chi ponu pinsari i genti? Ca sugnu io ca i mannu lurdi in giro picchì sugnu ‘ngrasciata!
- u sacciu, u sacciu, sulu cu non ci ha ‘ncappatu non po capiri e ni murmuria! Ma io chistu ci dicu: Spiramu a Diu ca cianu a ‘ncappari! Accussì non parrunu assai! - Biii… taddu si fici, quantu mi ni vaiu, ca ancora aiu a priparari u mangiari a me maritu, ca si na trova prontu, mi ‘mmazza!
Si ni issi, ca è giustu ca dopu ca travagghiunu tuttu u jornu, l’omini anu a truvari a mugghieri e a spisa pronta! - Mi ni vaju , picchì me maritu non si siddia sulu si non trova a spisa pronta, ma si siddia macari picchì non voli ca staiu a parrai chi vicini! - Pacenza signuruzza, ringraziamu a Diu, na vita c’è sempri peggiu!
U ‘ntirissanti è ca l’omu è travagghiaturi, e no ni fa mancari un pezzu di pani pi campari i figghi! E ca non hannu vizi! - Biii… pi chistu, ringraziu a Diu milli voti o jornu, macari ca me maritu è anticchia camurriusu, megghiu non putia truvari! Non m’ha fattu mancari mai u nicissariu ne a mia e ne e so figghi!
Quando avevo otto anni appena finita la terza elementare mia madre mi mandò dalla “maistra” per imparare l’arte del ricamo e del cucito.
"A maistra" in genere era una donna non più giovane, preferibilmente nubile che per un modesto compenso insegnava l’arte del ricamo o del cucito, ospitando nella sua casa gruppetti di ragazze, per interi pomeriggi. Religiosissima con una moralità ineccepibile, tra un orlo e uno smerlo inseriva un rosario, una novena.
Sempre vigile, attenta agli atteggiamenti delle allieve, pronta ad allontanare qualche ragazza un po’ più vivace. Essere state allontanate dalla "maistra" era motivo di disonore per la famiglia.
Dopo qualche anno di “maistra” mia madre mi mise in mano un enorme lenzuolo, da ricamare per la “dote”: «U vidi? - Mi disse – si chistu u raccami tu, comu fici io quann’era picciridda, quannu si ranni tu, ci poi diri a to figghia ca quann’eri picciridda raccamasti già un linzolu pa “doti”».
Quel lenzuolo era la base della reputazione di ogni donna, la prima responsabilità morale ed economica (la stoffa e il cotone da ricamo erano costosi). Quel lenzuolo quanto l’ho odiato! Eppure ho finto di apprezzarlo! Non potevo deludere i grandi e dimostrare a tutti che non ero "normale".
Man mano che il ricamo progrediva tra un rametto a punto erba e una foglia a punto pieno, aumentavano le lodi di tutti e la gioia di mia madre. «Vaddatila, pari ‘na fimmina ranni! Chi carusa assinnata! O jocu non ci pensa cchiù, ci piaci chiossai raccamari!».
Le donne adulte erano sempre intente ad osservarmi e pronte a consigliarmi e correggermi, tutte le volte che per distrazione commettevo qualche errore: - Figghia mia, si ti ‘bbitui accussi, poi non ti voli maritari nuddu, cu sa pigghia na fimmina svissata?
Io non riuscivo a gioire, anzi mi sentivo in colpa, spaventata e sola, perché non potevo dire a nessuno che avrei preferito giocare invece di ricamare e che non mi importava di sembrare già grande.
Così a otto anni, mi resi conto che la solitudine è non poter dire quello che si pensa,spaventata dall’idea di deludere tutti e perdere così il loro affetto. Io recitavo bene il mio ruolo di “carusa assinnata”, tutti erano contenti di me e mia madre elencava quotidianamente a chiunque i miei progressi di “fimmina avvissata”.
Nonne, zie e vicine mi elogiavano, e guardandomi con infinita tenerezza mi ripetevano una frase per me allora oscura,e che accompagnava anche i compleanni: «Figghia, chi mi hai tanta saluti, ma sa aviri nu malu distino, u signori mi ti ricogghi ora ca si ‘nnuccenti».
Solo molti anni dopo, scoprii che per “malu distino” intendevano puttana o giù di li. Non riuscivo a capire cosa significasse comportarsi bene, qualche volta ho provato a chiedere l’esatto significato, ma il massimo che ho ottenuto è stato: «A essiri ubbidienti cu to patri e to matri! Allora io ero a posto , obbedivo sempre, anche quando non ero d’accordo e quando non capivo».
I lunghi pomeriggi li trascorrevo tra ricami e racconti, a raccontare erano sempre “i fimmini ranni”. Ogni racconto conteneva un elogio o un ammonimento.
Veniva continuamente esortata la donna all’obbedienza, alla pazienza, al lavoro, alla rinuncia, al risparmio, alla rassegnazione, al saper soffrire in silenzio, al sacrificio, e naturalmente le donne che erano state capaci di questo erano considerate quasi sante, al contrario quelle che non lo erano state, che avevano “sbagliato” avevano duramente pagato, con l’unanime disprezzo e l’emarginazione.
Mi faceva paura l’idea di poter diventare oggetto di disprezzo, ma allo stesso tempo non riuscivo ad afferrare il concetto di “sbaglio” , quel male che tutti erano pronti a scorgere.
C’erano dei discorsi, ai quali non potevo partecipare, velati di grande mistero, e riservati solo alle donne sposate,discorsi che se interrotti dal mio improvviso apparire creavano grandi momenti di imbarazzo, e dopo lunghe pause di silenzio, la più furba del gruppo tirava fuori un nuovo argomento come fosse la continuazione del precedente e il discorso riprendeva, come nulla fosse successo, ma nei loro sguardi l’interrogativo drammatico: avrà sentito qualcosa entrando?
E mentre intessevano complici il loro nuovo argomento, spiavano la mia espressione, cercando di cogliere qualche segno di turbamento provocatomi da quello che avevo sentito.
Cominciai ad origliare proprio in seguito a questo loro atteggiamento di grande mistero, certamente quell’ aria grave e solenne doveva nascondere qualcosa di importante.
La mia curiosità non fu soddisfatta origliando, anzi, fu ingigantita perché tutto quello che ascoltavo potevo solo interpretarlo in base alle mia “conoscenze”, naturalmente il risultato fu più che catastrofico.
Quando origliavo, erano frequenti espressioni del tipo: - Eh nui fimmini nascemu pi soffriri! - si sapeva tuttu chiddu cavia a passari, non mi maritava! - Chista è a vuluntà di Diu, u distino di nui fimmini! - povira Angilina, quantu piniau pi aviri stu figghiu! Vi ricuddati quantu cianciu Tinuzza dopu a prima notti di nozzi?
E se qualche volta spinta dalla curiosità mi precipitavo a chiedere, magari ripetendo la loro ultima frase, ho sempre avuto risposte del tipo: «si Tinuzza chianciu assai picchì cadiu e si struppiau un pedi… -Angilina piniau assai picchi, prima u Signuruzzu non ci vuliva mannari un figghiu, poi idda u priau assai assai, e u Signori ci fici a grazia».
Naturalmente, da sempre mi era stato detto che i figli vengono solo se Dio li manda. Ma perchè prima che Dio manda i figli, le mamme hanno il pancione?
Questa domanda l’ho rivolta a tante persone, e ho avuto una grande varietà di risposte: «‘nda panza c’è chiddu ca sevvi pi fari u latti pu picciriddu - a panza è un signali di Diu, accussì a fimmina u capisci e pripara i robbi pu picciriddu! - È un signali pa cicogna accussì capisci unni avi a iri!
Un giorno mentre eravamo nei bagni della scuola la mia compagna di banco mi dice: «ma tu comu l’hai u fiorellino? e si abbasso’ le mutande - comu u to – risposi io - ieri visti a zia ca cangiava u cuginettu e iddu l’avia di nautru modu!».
Ne discutemmo a lungo, alla fine decidemmo che quella doveva essere una forma che si ha da piccolissimi, poi crescendo “cade”. Questa teoria resse fino al tragico giorno in cui vidi cambiare la figlia della comare Adelina: non c’era nessuna appendice, ed era nata da pochi giorni!
Fu tale la sorpresa che chiesi subito a comare Adelina la quale si scandalizzò quando le dissi che avevo notato la “differenza”, insieme alla mia compagna: «Ma tu sti porcherii quannu l’ha vistu?» e io rispondevo «Mi cuntau a me cumpagna di bancu!». La comare sottolineò «Chisti su cosi lurdi ca non sanu mancu a pinsari! Ognunu è comu Dio voli ca è! E a to cumpagna è na gran fitusa.
Chisti su cosi ca non si vaddunu e non si fanu vidiri! E mancu si ni parra! Tu cu sta cumpagna non ci ha parrari cchiù e ora ci u dicu a to matri mi ci dici a maestra ca ti fa cangiari cumpagna di bancu, ca chista a tia ti porta scannalu!».
Inutile dire che la confusione imperava, da tutti i discorsi che avevo colto, interpretato, avevo solo accumulato dubbi enormi, troppe cose non collimavano!
Perché devo vivere per prepararmi al matrimonio, se poi tutto è così brutto? Perché mi dicono che sarà tutto bellissimo e poi quando sono fra loro "le sposate" non fanno altro che lamentarsi e commiserarsi?
Perché tutte le volte che ero triste, per un qualunque motivo, dal ginocchio sbucciato, alla litigata con i compagni la nonna mi consolava dicendomi: «Figghia suppotta tuttu p’amuri di Diu, ca poi un jonnu sarai ricumpinsata, u Signori ti farà ‘ncuntrari un carusu… - parrunu accussi picchì su ‘mmidiusi, tu sai cuciri, sai raccamari, e si ti compotti beni u Signuri ti farà ‘ncuntrari nu bravu carusu…».
Tutto questo non mi confortava affatto, anzi mi indispettiva perché non riuscivo a condividere le ottimiste certezze della nonna che intanto continuava: «E to maritu sarà beddu comu un principi (non sapevo cosa fosse un principe) e quannu poi passi ‘nta chiazza cu iddu, tutti i to compagni morunu da ‘mmidia!».
E «quannu tu poi nesci da chiesa tutta vistuta di jancu, comu na reggina (non sapevo cosa fosse una regina) venunu tutti a taliariti, e diranno: u vidisti ca si maritau! Vadda chi beddu maritu ca capitau! Però ta cumputtari beni! Il premio finale che doveva compensare qualunque sofferenza!».
Il comportamento dei grandi contribuiva non poco a disorientarmi, quando la figlia della zia Melina, scappò con un suo corteggiatore non gradito alla famiglia, la zia per almeno due giorni gridò : «Figghia era megghiu si t’avissi cianciatu morta!».
Purtroppo dopo qualche anno, l’altra figlia morì dopo una breve malattia, e la zia per tutto il tempo gridò: «Figghia era megghiu si ti n’avissi fujutu!».
Nemmeno la mie cugine avevano azzeccato cosa fosse giusto fare! Non volevo diventare grande, avviarmi verso una esistenza gestita e condizionata dagli altri, nella quale non aveva nessun valore quello che pensavo.
Già, cosa pensavo io? Da quando mio nonno aveva comprato una grossa radio, ero affascinata dalla musica ed attratta dal tipo di donna cantata da Mina.
Ascoltando le sue canzoni (naturalmente tante cose non le capivo) immaginavo la donna libera di amare e di farsi amare, libera di restare o andare via e di vivere con gioia i sentimenti: tutte le caratteristiche della donna perduta! Tutto il contrario per il quale mi stavano preparando!
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
SOCIAL E WEB
La cicogna prende "Il Volo": chi è il tenore (siciliano) che diventa presto papà
131.416 di Redazione

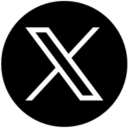



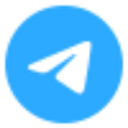


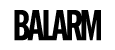





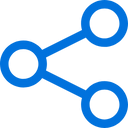
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram