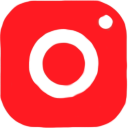Bakery, Barber Shop e Instagram: la Palermo hipster raccontata nelle fotografie
Non è soltanto questione di nomi è che sembra esserci sfuggito di mano il concetto: siamo circondati da posti che ci rimandano alla New York degli anni Cinquanta

La ragione è complessa, e no, non è perché sono una tristona comunista bastiancontraria che si lamenta di tutto e di tutti. Almeno, non solo per quello. Prima che mi possa essere mossa la critica più antica del mondo, mi sento in dovere di rassicurarvi: sì, ho esperito di persona alcune bakery palermitane, quanto ai barber shop – per ovvie ragioni di giender – ci ha pensato il mio fidanzato.
Bakery: in inglese, indica letteralmente la nostrana panetteria, quella dove si comprano il pane, le brioscine e le pizzette. Se poi ci vogliamo sentire fighi e giocare ai traduttori allora aggiungiamo che lo stesso termine corrisponde al francese boulangerie, luogo che ha la medesima funzione dei suoi omologhi detti in un’altra lingua: la vendita di pane e prodotti da forno, con possibilità alle volte di consumare in loco.
Le varie bakery che continuano a spuntare come funghi sia a Palermo che altrove sono invece luoghi arredati con cura, confortevoli, dove si prediligono i toni pastello e la carta da parati a righe, i tavoli in legno grezzo e le sedie meglio se spaiate e in stile shabby-chic, o finto-poraccio che dir si voglia.
Apri la porta ed entri praticamente nella casa di Barbie, che sembra avere molti punti in comune anche con il catalogo Ikea (sarà forse perché l’arredamento di questi locali proviene tutto da lì?).
Specialità della casa sono muffin, cupcakes, torte alla crema di burro alte tre dita, pancakes e, all’occorrenza, viene servito anche il brunch.
Praticamente svolgono le funzioni di quelli che nel mondo anglosassone vengono comunemente chiamati "cafè", coffee shop (non quelli di Amsterdam!) o tea rooms, al secolo caffetterie e sale da tè: ma si sa che in italiano suona tutto meno accattivante e anche un po’ fuori moda.
Stessa storia i barber shop. Si narra di un’epoca, neanche troppo remota, in cui il barbiere era un’istituzione poli-funzionale da cui promanava una sorta di potere sciamanico.
Era sì colui che in primo luogo sistemava barba e capelli, ma all’occorrenza il barbiere faceva anche i salassi contro l’ipertensione, ed estirpava pure i molari a vivo. Trattandosi di ambienti ad esclusiva frequentazione maschile, vi si potevano trovare appesi alle pareti calendari osé e foto di gruppo della squadra del cuore, oltre a madonne e crocifissi sincretisticamente appaiati a cornettini rossi scaccia malocchio.
Luoghi simili esistevano – ed esistono – ovviamente anche al di fuori d’Italia, ad esempio in America, dove era peraltro altamente probabile che fossero gestiti da immigrati italiani. L’unica differenza era che lì, sulla vetrina, non c’era scritto barbiere, ma barber shop. It’s traslation, babe.
Ora, invece? Molti barbieri palermitani hanno semplicemente cambiato l’insegna, inglesizzandola. I saloni di nuova apertura sono gestiti invece da hipster con le bretelle, hanno le biciclette appese al muro a mo’ di complementi d’arredo e le poltrone che – come si legge su alcune recensioni scovate in giro per l’internet, e confermate dal fidanzato – “ricordano la New York degli anni Cinquanta”. Ora voi me lo dovete spiegare cosa ci facevate a New York, dal barbiere, negli anni Cinquanta.
Volevate dire forse: “Ricordano il set di un film dell’altro ieri, ma ambientato nella New York degli anni Cinquanta”? No, perché le parole sono importanti. Ed ecco che ridivento una tristona acida.
Non è soltanto questione di nomi. È che proprio sembra esserci sfuggito di mano il concetto. E poi perché abbiamo così tanto bisogno di ipercaloriche merendeamericane in un posto che in America neanche esiste?
Perché un uomo per tagliarsi i capelli deve per forza fare un salto nella New York del secolo scorso? Io un’idea ce l’avrei, ma scriverla mi intristisce parecchio.
Forse tutto questo accade perché la realtà in cui viviamo, in fondo, non ci piace. Perché vogliamo sentirci dentro un film, vivere un’esperienza fuori dalla nostra quotidianità, ma preferiamo farlo senza muoverci da casa nostra. A questo servono i surrogati. E no, non venitemi a dire: “e allora i ristoranti cinesi, giapponesi, giamaicani???”
Quelli sono un’altra cosa, sono nella maggior parte dei casi luoghi in cui persone che hanno lasciato il proprio Paese natale cercano di preservare e portare avanti la loro cultura, di cui il cibo è da sempre una tra le espressioni più rilevanti.
Non fingono di essere ciò che non sono, ed è proprio questo che mi porta a diffidare di bakery e compagnia varia: il fatto che si tratti di luoghi inautentici e passeggeri, assemblati come una scarpiera Ikea, testimoni di una cultura che non c’è, ma che produce foto facilmente instagrammabili.
Sono luoghi che hanno il potere di farci sentire diversi, che ci autorizzano a fingerci esperti di tradizioni ed esperienze culinarie viste a malapena nelle serie tv, ma che, dopotutto, lasciano intatta la nostra sostanza di onnivori consumatori di esperienze incellofanate.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
STORIA E TRADIZIONI
Le 10 suore morte in un monastero: quando Camilleri scoprì un segreto dei Gattopardi
282.055 di Maria Oliveri -
STORIA E TRADIZIONI
Stella, moglie del "Principone": a chi si ispira la principessa di Salina del Gattopardo
191.505 di Susanna La Valle -
STORIA E TRADIZIONI
Per i cugini era un "mostro", per la madre una figlia: la storia del (vero) "Gattopardo"
181.178 di Maria Oliveri

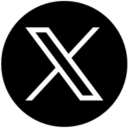



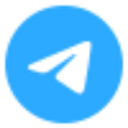


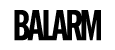





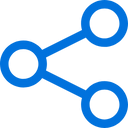
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram