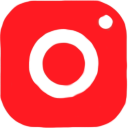MISTERI E LEGGENDE
Un urlo, poi due colpi di fucile: la storia dei Frati di Mazzarino tra estorsioni e vendette
Non ci sono fantasmi né leggende al castello di Mazzarino. C'è però un mistero più grande che avvolge questo luogo ed entra tra i vicoli del paese finendo in tribunale

I frati di Mazzarino (foto di Franz Cannizzo)
Delle quattro torri cilindriche merlate oggi ne rimane soltanto una, lugubre e imponente, che ne costituisce l’incanto maggiore. Da lì, da questa torre totalmente cava, si apre lo scorcio più suggestivo sul paese, in una luce senza uguali e nel vento dell’isola che porta gli effluvi della campagna circostante il cui profilo scivola fino all’Etna.
Non ci sono fantasmi né misteri al castello di Mazzarino. Nessuna leggenda, nessuna ambiguità della storia. Ma c’è un mistero più grande che avvolge questo luogo, e non alla sommità del suo maniero, ma nel paese stesso, fra i suoi vicoli, dileguando dentro case basse.
È un mistero che arriva fino a un’aula di tribunale, che ne risolve i fatti ma non ne districa le sfumature, ed è talmente profondo e stratificato da diventare il fatto stesso un pretesto, un’occasione di racconto, una metafora della vita sociale di un piccolo paese siciliano come tanti ce ne sono. È una storia di vendette, di estorsioni, di morti e di mafia: è la storia dei Frati di Mazzarino.
La portata della vicenda è scandalosa, per i personaggi che vi sono coinvolti e per il luogo in cui essa accade: un convento di frati francescani che hanno fatto voto di povertà, di castità e di obbedienza.
Una vicenda inammissibile, che inizia dalla sua fine. Corte d’Assise di Messina, 12 marzo 1962. Sul banco degli imputati, nello schiamazzo generale dell’aula, siedono quattro frati cappuccini: Vittorio, Venanzio, Agrippino e Carmelo. Barbe incolte, espressioni ieratiche, gesti sospesi. Si sono fatti due anni di carcere con accuse gravissime: associazione per delinquere, concorso in omicidio ed estorsione continuata.
Lasciamo da parte questo fotogramma giudiziario, fissato nella cronaca del tempo, e torniamo indietro fino al 5 novembre 1956. Mazzarino langue nel suo sonno, nell’entroterra di una Sicilia arcaica e sospettosa, e attorno al convento, che si affaccia su una bella vallata, c’è un silenzio irreale, esasperato, finto: un silenzio che fa paura. I frati sono nelle loro celle, quando si sente un urlo spaventoso, e, subito dopo, due colpi di fucile a pallettoni che tuonano lungo i corridoi.
Arrivano dalla stanzetta di Agrippino, e non appena gli altri si recano a verificare l’accaduto, trovano il frate per terra e i proiettili conficcati nel muro. I carabinieri aprono un fascicolo d’indagine; le piste sono scarse, le ipotesi assai vaghe, e dopo gli interrogatori, a sette mesi dalla vicenda, il caso è già archiviato. Tutto finito. E invece no, è solo l’inizio. Succede che qualche tempo dopo il paese è preda di una lunga serie di incendi, estorsioni, omicidi e ricatti.
Qualcuno mette in collegamento questi fatti con la vicenda del convento, sostenendo che l’attentato ai frati non era altro che una macchinazione per allontanare, prima del tempo, i sospetti che avrebbero potuto maturare in seguito. Un piano ben congegnato dai misteriosi frati che il giornalista Mauro De Mauro, sulle colonne del quotidiano L’Ora di Palermo, chiamerà «monaci-banditi, i don Abbondio dell’estorsione».
Altri non la pensano come lui, e difendono i religiosi, dicendo che veramente qualcuno ha sparato nel convento, ma solo per coprire misfatti compiuti da altri, per intimidire i frati e costringerli all’omertà. Ipotesi, al momento, e come sempre in questi casi speculari nella forma e manichee nel giudizio.
Mazzarino però vive per anni in un’angoscia sociale senza precedenti, in una paura senza requie, nel terrore di una serie di delitti che trasforma la vicenda da un giallo di provincia a un vero e proprio catalogo degli orrori.
Si contano i soldi, soprattutto, e le minacce di morte per ottenerli. Ne sono vittime designate due Padri Provinciali degli stessi Cappuccini, e il dottor Ernesto Colajanni, la cui farmacia prende fuoco per intimidazione. Con loro, anche il barone Alù e due agricoltori della zona che da un giorno all’altro si ritrovano senza bestiame.
Uno di loro riceve numerose lettere intimidatorie: bisogna pagare, e in fretta. E, dalle minacce, si passa ai fatti. È il 25 maggio 1958. Il cavaliere Angelo Cannada, un ricco possidente, viaggia insieme alla moglie Eleonora Sapio e al figlio su una Fiat 600. I tre vengono fermati, in contrada Prato, e accerchiati da quattro uomini in maschera, che trascinano l’uomo al ciglio della strada. Lo uccidono, senza pietà, e senza esitazioni. Una vera e propria esecuzione.
Le indagini «a carico d’ignoti» rimangono lettera morta: non ci sono testimoni, le congetture si fanno a denti stretti, dicendole con l’espressione di chi al contempo è come se non le dicesse, o non ne fosse certo, o lo avesse solo saputo, e quindi nel ruolo di un teste inammissibile. Passa un anno, e il 5 maggio 1959 due colpi di fucile raggiungono il vigile urbano Giovanni Stuppia, e per questo finiscono in caserma Giuseppe Salemi, Girolamo Azzolina e Filippo Nicoletti.
Sono loro i complici laici – per qualcuno solo dei dilettanti - che più tardi finiranno a processo con i frati di Mazzarino, il 6 febbraio 1960 a Caltanissetta. Ma in un primo colpo di scena, il processo si sposta a Messina, trasferito per legittima suspicione.
Una sola domanda attanaglia le coscienze: i frati, in questa vicenda, sono le vittime o i complici? La difesa ha le idee chiare. I delitti più gravi sono imputabili in via esclusiva ai laici, che hanno commesso l’omicidio del cavaliere Cannada, mentre i religiosi hanno agito solo per «stato di necessità», intimiditi dall’azione violenta di quegli uomini malvagi.
Sono vittime impaurite, e come scriveva Alessandro Manzoni per giustificare la figura di Don Abbondio, «il coraggio, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare».
Nel collegio difensivo compare anche il nome di uno dei più grandi avvocati e giuristi italiani, Francesco Carnelutti. Interrogati, i frati sostengono di avere agito a fin di bene e dietro minaccia del vero mandante di tutta la vicenda, Carmelo Lo Bartolo, giardiniere del convento, uomo dalla rude personalità magnetica, che viene poi arrestato a Genova, dove si era reso latitante, e condannato a 30 anni di galera.
A Caltanissetta, però, in carcere, Lo Bartolo si toglie la vita impiccandosi a una trave. Ed è proprio il suicidio uno dei tanti misteri di questa storia. I frati, dicono, non hanno preso mai denaro per loro, consegnando tutto a Lo Bartolo, ma al contempo non hanno nemmeno chiesto un trasferimento ad altro convento, che certamente gli sarebbe stato garantito se avessero, anche in via riservata e confidenziale, confidato la vicenda ai loro superiori.
In primo grado il tribunale assolve i frati, accettando la testi dello «stato di necessità». Storia chiusa. E invece no, ancora una volta, perché si chiude un processo e se ne apre un secondo, che si allarga all’opinione pubblica dopo la pubblicazione delle 193 pagine della sentenza, non mancando di momenti accesi di dibattito e di vere e proprie polemiche, come quella fra il Carnelutti e il Presidente della Camera, il penalista Giovanni Leone. La Corte d’Assise rivede le conclusioni del primo processo, e i frati vengono condannati a 13 anni di carcere.
La sentenza, per difetto di motivazione, è però annullata, e il processo si sposta a Perugia, con una pena ridotta a 8 anni, ma nessun dubbio sul ruolo dei frati, non già vittime ma carnefici, che secondo quanto emerso si assicuravano con scaltro rigore che le vittime delle estorsioni non annotassero i numeri di serie delle banconote e ancora, nelle forme di una malsana freddura, giustificando l’esiguità delle somme richieste.
Da possibili testimoni i frati diventano imputati, e, per citare una frase di Giovanni Falcone, le vere «menti raffinatissime» a capo di questa associazione a delinquere che usava come sgherri alcuni laici e un temuto giardiniere.
La tesi di Carnelutti sull’adempimento di una «missione» è respinta, ma i dubbi rimangono su eventuali altri complici e altri mandanti, e sul mistero del suicidio di Lo Bartolo, per il modo in cui è avvenuto e per le ragioni psicologiche che lo hanno presieduto.
Sono anni lontani, quelli dei Frati di Mazzarino, le cui malefatte si compivano all’ombra di quel castello bellissimo e sdegnoso che ha resistito ai colpi di fucile proteggendo il paese come un piccolo borgo prezioso nel paesaggio più caratteristico della Sicilia rurale.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
STORIA E TRADIZIONI
Le 10 suore morte in un monastero: quando Camilleri scoprì un segreto dei Gattopardi
282.747 di Maria Oliveri -
STORIA E TRADIZIONI
Avevano l'oro bianco, Franca Florio le rifiutò: donne e "matri" (senza nome) in Sicilia
83.445 di Susanna La Valle

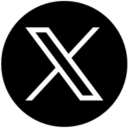



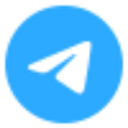


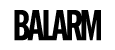





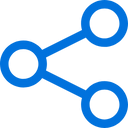
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram