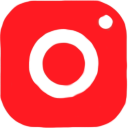STORIA E TRADIZIONI
Quei tuguri abitati dalla povera gente: cosa sono e come si vive nei "catoi" palermitani
Una buona parte di Palermo era costituita ancora dai catoi quando, nel 1885, venne approvato il "Piano regolatore di risanamento". Ecco come si viveva

Parola perdutasi nel tempo, catoio.
Luigi Natoli, l’autore del romanzo, non ce lo dice, se non in una laconica nota: “catoju” da "catagheou", stanza terrena, in siciliano catoju”.
Vincenzo Mortillaro nel "Nuovo dizionario siciliano-italiano" alla voce catòju, ci dice: «propriamente casa sotterranea, ma oggi comunemente chiamansi catoi, le abitazioni terragne, od anche vicine a terra. Stanza terragna, Tugurio».
Lo storico siciliano Giuseppe Pitrè ci ha dato una descrizione più ampia e dettagliata: «Il catojo è il tipo classico d'abitazione cittadina, dove, a lato o sopra l'uscio di entrata, una finestra da luce ed aria alla stanza allorché quello è chiuso. Letto, tavolo da mangiare, da lavorare, da riporvi ogni cosa che non abbia posto, con il suo cassetto contenente cucchiai di ferro, qualche volta di legno, forchette, coltelli, vi figurano insieme con un canterano (quale se ne abbia), alto, con cassettoni per la biancheria e qualche veste di famiglia, sul quale luccicano delle chicchere, coperte, da settembre in su per tutto l'autunno, da mele, o mele cotogne, o melograno, in attesa di maturità e con la prospettiva di un po' di odore. (...)
Dalle pareti pendono qualche volta quattro (non più né meno) cornici con pianci, immagini, stampe rappresentanti scene diverse. V’è il pozzo per l'acqua sorgiva, o la cannella (cannolu) per l'acqua corrente; e sotto una pila in muratura, o in ardesia, o in legno per il bucato o per altri usi; (...).
Un focolare di pietra, con relativa gradetta (gratella) per il carbone acceso o da accendere, guardato dalle stoviglie indispensabili (le famiglie meno disagiate hanno utensili di cucina in rame pulito e lucente), non di rado profumato dal jettitu, o nicissariu, o aciu sottostante.
Talvolta nel catojo il pianterreno ha il susu, cioè il piano superiore con un balcone a ringhiera. Quasi sempre vengono ospitati animali. L'angustia di spazio e la mancanza d'aria spiegano perché molti abitanti dei catoj vivano per gran parte della giornata all'aperto, anche per lavorare (la luce dentro casa è pure essa insufficiente)» (Giuseppe Pitrè, la famiglia, la casa, la vita del popolo siciliano, Palermo 1913).
I catoi erano e sono diffusi in tanti centri della Sicilia. Alcuni oggi sono diventati addirittura dei bed and breakfast.
Una parte rilevante di Palermo era costituita ancora dai catoi quando, nel 1885, venne approvato il "Piano regolatore di risanamento".
L'ingegne Felice Giarrusso, ideatore del piano, così descrisse i catoi palermitani: «Quivi (nei catoi n.d.r.) una sdrucita porta dà ingresso ad un tugurio, sovente senza altro vano che dia luce ed aria, il pavimento di rossi mattoni porosissimi, talvolta ad un livello al di sotto del suolo stradale, ovvero costituito dal solo terriccio calcato, senza massicciata né malta idraulica a garanzia dell’umidità, ed ove le cloache sono poste immediatamente al di sotto del pavimento, le pareti che grondano acqua ed umidità in tutte le stagioni, e coverto da solaio.
In un angolo trovasi il misero focolare, e sottostante un catino bucato che serve da cesso, da smaltitore delle acque luride ed altri usi, fomite perenne di tutte le infezioni. Se si aggiunge l’angustia dei vicoli e dei cortili, così che manca per nove mesi l’anno la luce e il sole, si avrà un’idea di quanto di putrido esiste nella città nostra».
Altre descrizioni dei catoi palermitani ci dicono che: “Il catoio era formato due parti, la stanza principale al piano terreno che serve per gli usi di tutta la famiglia e, dal soppalco in legno che occupava mezza area in elevazione.
Nel centro del solaio troneggia il letto a due piazze, col materasso poggiato su tavole di legno rette da cavalletti in ferro, per i più ricchi, o di legno (trispiti).
Il resto dell’arredamento è composto da un tavolo con tre o quattro sedie impagliate e qualche sgabello, una cassa di legno, qualche stampa devota o l’altarino dove non doveva mancare la presenza dell’immagine di Santa Rosalia da poco nuova patrona della città.
A volte un insieme di “catoi” era raccolto all’interno di un vicolo chiuso che di conseguenza diveniva il prolungamento dello spazio abitativo".
Ma Giarrusso, che abbiamo già citato, ci dice anche che a Palermo la situazione igienico-sanitaria all'interno del centro peggiorava sempre di più perché la maggior parte della popolazione infatti abitava i cosiddetti "catoi".
I dottori Paolo Vassallo e Caruso cinquanta anni prima dell’ingegnere Giarrusso, nella loro relazione sulle cause della epidemia di febbre epidemica petecchiale diffusasi ad Agrigento nell'anno 1833, scrissero che gli “abituri ristretti” favorivano la diffusione di casa in casa e di via e di via in via di epidemie, proprio perché le condizioni abitative in cui si svolgevano le misere esistenze di molti agrigentini erano davvero molto precarie.
I due medici arrivarono a queste conclusioni dopo una lunga permanenza ad Agrigento, andando di casa in casa.
I ristretti abituri di cui parlano i due medici erano i tristemente famosi catoj, presenti in buona parte del centro storico agrigentino e soprattutto nel quartiere del Rabato, antico quartiere arabo che sorge nel pendio estremo occidentale della collina su cui poggia la città.
Qui gli arabi nel nono secolo scavarono nella viva roccia molte abitazioni troglodite che dal XV secolo in poi (soprattutto nella zona settentrionale del Rabato) andarono modificandosi in più salde strutture murate, i cosiddetti casolini.
Nelle zone periferiche, alte e basse, lungo le mura e spesso attorno alle chiese di Agrigento, si drizzavano casupole, veri tuguri, per la povera gente, dove in un solo ambiente vivevano famiglie composte di molte persone. Capitava che parte del locale spesso venisse adoperato come posto di lavoro: ciabattino, maniscalco, barbiere o come bottega.
Le strade erano maltenute; in qualche tratto sconnesse, mentre in altri posti, anziché delle scalinate, esistevano rampe di accesso. Dei rigagnoli di liquido, di dubbia natura, scorrevano creando delle pozzanghere.
La pulizia e l’igiene erano molto carenti in tali località della città, sia per la mancanza di una rete fognante razionale, sia per la promiscuità con animali e la vicinanza di scuderie, stalle e fondaci, sia infine, per il transito frequente e lo stazionamento di bestie, i cui escrementi sporcavano la zona.
Ancora nel 1958 a Palermo, a due passi dalle vetrine dei negozi di via Maqueda, via Ruggero Settimo e via Roma, simboli esteriori della nuova società consumistica, il cuore vero della città batteva nei quartieri popolari.
Qui stando a quanto leggiamo nel rapporto del Prefetto «interi complessi familiari […] vivono in uno stato di abbrutimento morale e materiale indegno di una nazione civile», imprigionati nei cosiddetti “catoi” «composti da uno o due vani, privi dei più elementari servizi igienici, della cucina, dell’acqua e nei quali si affollano, in una insalubre ed immorale promiscuità donne, uomini e bambini quasi tutti affetti da tubercolosi o da altre serie malattie».
Per risolvere una situazione così drammatica – spiegava il Prefetto – era necessario e inderogabile un intervento dello Stato; ma nonostante la discussione di una legge speciale per Palermo e l’impegno assunto dal capo dello Stato Gronchi in visita nella città nel 1955, il governo nazionale non aveva ancora manifestato un concreto interessamento per la grave situazione palermitana, tanto da causare una reazione polemica da parte del sindaco e una diffusa impressione negativa da parte dell’opinione pubblica e delle forze politiche e sindacali, che, «senza distinzione di colore», avevano contestato a più riprese il mancato intervento dello Stato.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
SOCIAL E WEB
La cicogna prende "Il Volo": chi è il tenore (siciliano) che diventa presto papà
131.396 di Redazione -
CINEMA E TV
È palermitana e la vedi ancora su Rai 1: chi è la nuova attrice in "Mina Settembre"
101.591 di Redazione

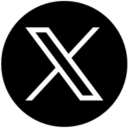



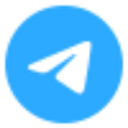


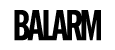





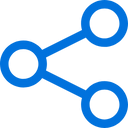
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram