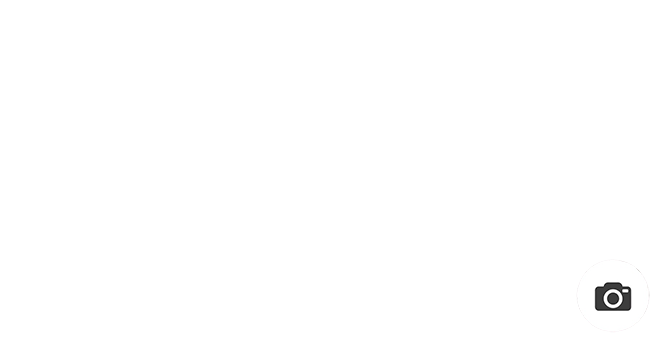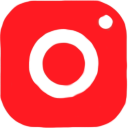ARTE E ARCHITETTURA
Mostrava la Palermo che non vuoi vedere: Andrea Di Marco, il "collezionista di scarti"
L'artista si occupava di particolari anonimi, “non luoghi" delle assolate periferie urbane di Palermo e di altri posti della Sicilia che gli capitava di frequentare
Sono pezzi di paesaggio modificato dall’uomo quelli che Andrea Di Marco (Palermo, 1970-2012), con un paziente e faticoso lavoro, fotografa, colleziona, seleziona e analizza.
Ombrelloni chiusi, barche capovolte, distributori di benzina, quadri elettrici, treppiedi topografici, trattori, idranti, camion, e ancora capannoni abbandonati, saracinesche abbassate, roulotte parcheggiate, ape car, stenditoi coperti e giostre di felliniana memoria.
“Mi piace pensarmi come un collezionista di scarti, tentando di circoscriverne il fenomeno”, scrive in una lettera inviata a Beatrice Buscaroli (Andrea Di Marco, Antropologia minima, 2007).
A dieci anni di distanza dalla fondazione dell’Archivio Andrea Di Marco https://www.archivioandreadimarco.org/ - fondato il 4 aprile 2013 - il fattore tempo che si frappone tra noi e l’artista, ci permette di comprenderne meglio alcuni aspetti legati alla sua fase più matura.
Quella fase, per intenderci, successiva alla mostra “Palermo Blues” (2001) in cui venne consacrata la Scuola di Palermo.
Da lì in poi Di Marco non rappresenta più le figure per concentrarsi solo sugli “scarti”, quei particolari defilati e anonimi che appartengono ai “non luoghi" delle assolate periferie urbane di Palermo e di altri luoghi della Sicilia che gli capitava di frequentare (Mondello, la casa di villeggiatura nella zona di Menfi, Catania, ecc.).
“Così partii fotografando l'inessenziale con l'impegno di tramutarlo in osservazione oggettiva, poeticizzandola. La pittura restituisce valore universale alle cose, così i soggetti estrapolati da una realtà territoriale e domestica, diventano essenza e voce del mondo.” (Andrea Di Marco, ibidem, op.cit.).
Nello scarto tra il dato tecnicamente ripreso dalla sua macchina fotografica e la successiva resa pittorica, vi è tutta la cifra poetica di Andrea Di Marco.
Egli punta lo sguardo su ciò che nessuno vuol vedere, dipinge il silenzio delle periferie assolate, dei quartieri dormitorio, dei capannoni abbandonati, delle saracinesche abbassate e dei muri scrostati. Il suo procedere non è intenzionale, è piuttosto un istinto innato per la verità.
Nelle sue tele vi sono oggetti e paesaggi quotidiani trovati per caso, privi d'estetica e, dunque, scartati. Egli li preleva dall’anonimato per nobilitarli attraverso la pittura che restituisce valore universale alle cose.
Di Marco non intende raccontarci una storia, il suo catalogo visivo ci descrive, piuttosto, una condizione esistenziale. Osservando le sue tele, si ha la costante sensazione che l’essere umano, se pur escluso per sempre, si sia appena allontanato, ci si accorge che questi scarti di vita vissuta sono portatori di una verità universale: la loro condizione di precarietà e di emarginazione è, soprattutto, umana.
“Sono figli nostri, intendo quegli oggetti-soggetti che si legano al paesaggio e che io fotografo, estraggo, dipingo e quindi non dimentico, sia per fare un dispetto alla globalizzazione sia per quel sentimento di riconoscenza, di aspettativa enigmatica, di quell'imperscrutabilità che si rivela a volte come una metafora dell'incertezza del vivere". (Andrea Di Marco, ibidem, op.cit.)
Questi oggetti-soggetti non sono mai definiti dalla loro funzione, vengono liberati persino dalla presenza dell’uomo e sembrano rimanere sospesi in uno spazio metafisico. È come se Di Marco, nel tentativo riconoscersi nell'esistente, assumesse il punto di vista degli oggetti sul mondo.
Poi, quasi a volergli rendere giustizia, con empatia, ma senza perdere il suo sguardo ironico e leggero sulle cose, gli restituisce un’identità con nomi ironici e abbreviati: "Sara" per saracinesca, “Condom” per condominio, “Sant’ Antonio” e “San Tommaso” per degli ombrelloni chiusi, “Ultimo Pirla” per descrivere una scena, purtroppo ancora consueta, in cui sacchi di spazzatura ricadono al di fuori dei cassonetti.
È nell’indeterminatezza di questi titoli che Di Marco, con intelligenza e ironia, riesce a non prendersi mai troppo sul serio. “(…) ho sempre cercato di educare la mia anima all’orrore per il pregiudizio, forse questo mi basta per definirmi un osservatore ma non mi aspetto niente di buono”. (Andrea Di Marco, ibidem op.cit.)
Di Marco non ha uno sguardo univoco sulle cose, egli ritaglia frammenti di quotidiana banalità per aprire porte su realtà molto più ampie, con una visione libera da preconcetti e da pregiudizi. Scorrendo le innumerevoli diapositive conservate nell’Archivio (per la precisione ben 3850) ci si accorge che le sue inquadrature sono volutamente casuali e sfuggenti, sempre al limite di qualcosa, mai definite nei contorni, ma piuttosto lasciate metafisicamente in sospeso come discorsi sempre aperti.
Con la sua attività artistica Di Marco riesce ad uscire fuori dai binari del significato e della funzione per varcare i limiti del razionale, sviluppando istintivamente una sorta di resistenza poetica. Egli sembra intuire, in anticipo sui tempi, che la tecnica permea la nostra visione del mondo, abituandoci a ragionare in termini di utile e di inutile e, dunque, di scarto. La casualità con cui egli trova e fotografa l'inessenziale diventa una strategia di salvezza necessaria per sfuggire a quell’agire in conformità ad uno scopo (Umberto Galimberti, Psiche e Tecne.
L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, XII ed. 2021). Non a caso Di Marco chiama “Sebastiano” l'opera in cui un povero albero subisce, inerme, la violenza della tecnica in un paesaggio fortemente modificato dall’uomo. Sebastiano è iconologicamente muto di fronte a tutto questo ed esprime la sua condizione esistenziale con una lenta e pacifica agonia, è l’espressione di una natura violentata e defraudata della propria essenza in quanto res extensa1.
Con quel mondo dimenticato, trascurato e marginalizzato dal main stream utilitaristico contemporaneo, Di Marco aveva instaurato, probabilmente, un rapporto intellettuale ed emotivo fin dai tempi di Mister Shell che chiede scusa agli abissi (1997).
A distanza di più di dieci anni dalle sue opere, in un mondo in cui gli effetti della “cultura dello scarto” (cfr. n. 22 Enciclica “Laudato si”, Papa Francesco, 2015) ci mostrano scenari sempre più catastrofici (dal surriscaldamento globale, passando per il consumo di suolo al fino alla perdita di biodiversità), le tele di Andrea Di Marco assumono una valenza quasi premonitrice.
C’è in esse una sorta di nostalgia, che coincide con la consapevolezza dell’impossibilità di ritrovare l'innocenza perduta dopo l’avvento della globalizzazione.
Se penso a quel fenomeno astrofisico secondo cui la luce delle stelle che arriva fino a noi appartiene a corpi celesti già scomparsi, non posso non pensare alla "luce pura e assoluta" che a distanza di molti anni le tele di Andrea di Marco continuano a trasmetterci, con uno sguardo al tempo stesso impegnato e leggero sul mondo. “L'attenzione per questi particolari defilati aveva bisogno di una luce pura e assoluta” (Andrea Di Marco, ibidem, op.cit.).
Ombrelloni chiusi, barche capovolte, distributori di benzina, quadri elettrici, treppiedi topografici, trattori, idranti, camion, e ancora capannoni abbandonati, saracinesche abbassate, roulotte parcheggiate, ape car, stenditoi coperti e giostre di felliniana memoria.
“Mi piace pensarmi come un collezionista di scarti, tentando di circoscriverne il fenomeno”, scrive in una lettera inviata a Beatrice Buscaroli (Andrea Di Marco, Antropologia minima, 2007).
A dieci anni di distanza dalla fondazione dell’Archivio Andrea Di Marco https://www.archivioandreadimarco.org/ - fondato il 4 aprile 2013 - il fattore tempo che si frappone tra noi e l’artista, ci permette di comprenderne meglio alcuni aspetti legati alla sua fase più matura.
Quella fase, per intenderci, successiva alla mostra “Palermo Blues” (2001) in cui venne consacrata la Scuola di Palermo.
Da lì in poi Di Marco non rappresenta più le figure per concentrarsi solo sugli “scarti”, quei particolari defilati e anonimi che appartengono ai “non luoghi" delle assolate periferie urbane di Palermo e di altri luoghi della Sicilia che gli capitava di frequentare (Mondello, la casa di villeggiatura nella zona di Menfi, Catania, ecc.).
“Così partii fotografando l'inessenziale con l'impegno di tramutarlo in osservazione oggettiva, poeticizzandola. La pittura restituisce valore universale alle cose, così i soggetti estrapolati da una realtà territoriale e domestica, diventano essenza e voce del mondo.” (Andrea Di Marco, ibidem, op.cit.).
Nello scarto tra il dato tecnicamente ripreso dalla sua macchina fotografica e la successiva resa pittorica, vi è tutta la cifra poetica di Andrea Di Marco.
Egli punta lo sguardo su ciò che nessuno vuol vedere, dipinge il silenzio delle periferie assolate, dei quartieri dormitorio, dei capannoni abbandonati, delle saracinesche abbassate e dei muri scrostati. Il suo procedere non è intenzionale, è piuttosto un istinto innato per la verità.
Nelle sue tele vi sono oggetti e paesaggi quotidiani trovati per caso, privi d'estetica e, dunque, scartati. Egli li preleva dall’anonimato per nobilitarli attraverso la pittura che restituisce valore universale alle cose.
Di Marco non intende raccontarci una storia, il suo catalogo visivo ci descrive, piuttosto, una condizione esistenziale. Osservando le sue tele, si ha la costante sensazione che l’essere umano, se pur escluso per sempre, si sia appena allontanato, ci si accorge che questi scarti di vita vissuta sono portatori di una verità universale: la loro condizione di precarietà e di emarginazione è, soprattutto, umana.
“Sono figli nostri, intendo quegli oggetti-soggetti che si legano al paesaggio e che io fotografo, estraggo, dipingo e quindi non dimentico, sia per fare un dispetto alla globalizzazione sia per quel sentimento di riconoscenza, di aspettativa enigmatica, di quell'imperscrutabilità che si rivela a volte come una metafora dell'incertezza del vivere". (Andrea Di Marco, ibidem, op.cit.)
Questi oggetti-soggetti non sono mai definiti dalla loro funzione, vengono liberati persino dalla presenza dell’uomo e sembrano rimanere sospesi in uno spazio metafisico. È come se Di Marco, nel tentativo riconoscersi nell'esistente, assumesse il punto di vista degli oggetti sul mondo.
Poi, quasi a volergli rendere giustizia, con empatia, ma senza perdere il suo sguardo ironico e leggero sulle cose, gli restituisce un’identità con nomi ironici e abbreviati: "Sara" per saracinesca, “Condom” per condominio, “Sant’ Antonio” e “San Tommaso” per degli ombrelloni chiusi, “Ultimo Pirla” per descrivere una scena, purtroppo ancora consueta, in cui sacchi di spazzatura ricadono al di fuori dei cassonetti.
È nell’indeterminatezza di questi titoli che Di Marco, con intelligenza e ironia, riesce a non prendersi mai troppo sul serio. “(…) ho sempre cercato di educare la mia anima all’orrore per il pregiudizio, forse questo mi basta per definirmi un osservatore ma non mi aspetto niente di buono”. (Andrea Di Marco, ibidem op.cit.)
Di Marco non ha uno sguardo univoco sulle cose, egli ritaglia frammenti di quotidiana banalità per aprire porte su realtà molto più ampie, con una visione libera da preconcetti e da pregiudizi. Scorrendo le innumerevoli diapositive conservate nell’Archivio (per la precisione ben 3850) ci si accorge che le sue inquadrature sono volutamente casuali e sfuggenti, sempre al limite di qualcosa, mai definite nei contorni, ma piuttosto lasciate metafisicamente in sospeso come discorsi sempre aperti.
Con la sua attività artistica Di Marco riesce ad uscire fuori dai binari del significato e della funzione per varcare i limiti del razionale, sviluppando istintivamente una sorta di resistenza poetica. Egli sembra intuire, in anticipo sui tempi, che la tecnica permea la nostra visione del mondo, abituandoci a ragionare in termini di utile e di inutile e, dunque, di scarto. La casualità con cui egli trova e fotografa l'inessenziale diventa una strategia di salvezza necessaria per sfuggire a quell’agire in conformità ad uno scopo (Umberto Galimberti, Psiche e Tecne.
L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, XII ed. 2021). Non a caso Di Marco chiama “Sebastiano” l'opera in cui un povero albero subisce, inerme, la violenza della tecnica in un paesaggio fortemente modificato dall’uomo. Sebastiano è iconologicamente muto di fronte a tutto questo ed esprime la sua condizione esistenziale con una lenta e pacifica agonia, è l’espressione di una natura violentata e defraudata della propria essenza in quanto res extensa1.
Con quel mondo dimenticato, trascurato e marginalizzato dal main stream utilitaristico contemporaneo, Di Marco aveva instaurato, probabilmente, un rapporto intellettuale ed emotivo fin dai tempi di Mister Shell che chiede scusa agli abissi (1997).
A distanza di più di dieci anni dalle sue opere, in un mondo in cui gli effetti della “cultura dello scarto” (cfr. n. 22 Enciclica “Laudato si”, Papa Francesco, 2015) ci mostrano scenari sempre più catastrofici (dal surriscaldamento globale, passando per il consumo di suolo al fino alla perdita di biodiversità), le tele di Andrea Di Marco assumono una valenza quasi premonitrice.
C’è in esse una sorta di nostalgia, che coincide con la consapevolezza dell’impossibilità di ritrovare l'innocenza perduta dopo l’avvento della globalizzazione.
Se penso a quel fenomeno astrofisico secondo cui la luce delle stelle che arriva fino a noi appartiene a corpi celesti già scomparsi, non posso non pensare alla "luce pura e assoluta" che a distanza di molti anni le tele di Andrea di Marco continuano a trasmetterci, con uno sguardo al tempo stesso impegnato e leggero sul mondo. “L'attenzione per questi particolari defilati aveva bisogno di una luce pura e assoluta” (Andrea Di Marco, ibidem, op.cit.).
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
LE FOTO PIÚ VISTE
-
DOVE MANGIARE
A Palermo (da 30 anni) se dici mignon dici "Savocherie": la storica rosticceria raddoppia
16.628 di Redazione -
ITINERARI E LUOGHI
Se ci vai fai un viaggio indietro nel tempo: il borgo fantasma a pochi passi da Palermo
6.400 di Salvatore Di Chiara

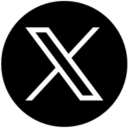



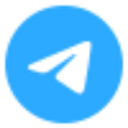


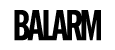





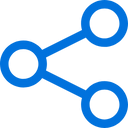
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram