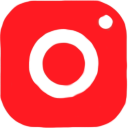In una piazza a Ballarò apparivano delle donne, una più bella dell'altra: Sette Fate
Un racconto dello scrittore Gioacchino Lonobile per andare alla scoperta della storia di una pizzetta nel quartiere Albergheria di Palermo dal nome evocativo: Sette Fate

Totuccio camminava con i piedi divaricati a segnare le dieci e dieci, per questo lo chiamavano Pìeriduci. In quel modo percorreva via Casa Professa verso piazza Ballarò. «Pìedidu' te lo bevi un bicchiere di birra?» chiese il Generale. Totuccio fece ruotare l'indice a intender dopo, con un cenno del capo salutò quanti stazionavano davanti il bar Messina e risalì via Scapparelli. A Santa Chiara, difronte l'oratorio, si trovò davanti la piazzetta con una colonna nel mezzo, accese una Marlboro e gli diede due tiri brevi senza staccarla dalle labbra. Una nuvola di fumo azzurro galleggiò davanti al suo viso e poi si disperse. Era cresciuto in uno di quei palazzi, ora disabitato e pericolante, dal grande portone color verderame.
«Qua apparivano donne di fora, tutte una cchiù bedda di n’autra, che portavano cu iddì i cristiani in posti lontani dove si potevano vedere cose meravigliose... poi appena spuntava il sole li riportavano a casa» gli disse una volta Rosa, sua madre, quando ancora nella piazza non c'era una targa con inciso “Piazzetta sette fate”. Mastro Geppino, il padre, era paesano, arrivò a Palermo da Villalba, una decina di anni prima di conoscere Rosa, senza soldi, senza lavoro e con due cugini - che poi fecero fortuna come “imprenditori” -. Trovò lavoro come apprendista, divenne manovale, promosso mastro e infine capomastro.
Era di bassa statura, con spalle robuste e mani callose, da contadino prima e muratore dopo. A differenza di Totuccio, era ritenuto gran travagliatore, persona saggia e poco dedita a dire minchiate, e di rado si vedeva in taverna. Come gli fosse nato un figlio tanto lagnuso e farfànte era un mistero per tutti, tranne che per lui, che lo sapeva invece: era colpa del nome, lo stesso di suo fratello, perdigiorno anche lui. Mastro Geppino raccontava spesso un'avventura che gli era capitata da giovane e giurava esser vera.
Una storia che con le sette fate qualcosa aveva a che fare, e se lui e la sua famiglia avevano trovato casa proprio lì, nella piazza che portava quel nome, non poteva essere una coincidenza, perché nostro Signore ci teneva a fare appattare tutte le cose, soprattutto quelle magiche. La storia cominciava sempre allo stesso modo: «Non puoi capire chi mi capitò in contrada Bunazzo...» Mastro Geppino aveva l'espressività di un blocco di Sabucina, sia se si trovasse davanti un piatto di anelletti al forno, che al funerale della madre, che se dovesse dare due boffe al figlio, ma quando iniziava raccontare quella storia, le rughe sul volto si distendevano e un lieve sorriso gli compariva sulla bocca, come se ogni volta dovesse rivivere quella piacevole esperienza.
Era giugno e il grano si mieteva ancora a mano. A quel tempo Geppino dormiva in campagna e, come ogni sera, era andato a letto presto. Un sonno profondo lo avvolse dopo due respiri, ancora parecchie ore dovevano passare prima che facesse giorno. Dita sottili gli sfiorarono il viso, labbra morbide gli si appoggiarono sulla pelle, lunghi capelli gli scivolarono sul collo. Geppino spalancò gli occhi e li mosse in maniera rapida per cercare di capire cosa stesse accadendo. Nessuno degli altri muscoli rispondeva ai suoi comandi, non riusciva a muoversi. Il terrore per quello stato d'immobilità però svanì dopo pochi secondi: gli bastò mettere a fuoco la causa del risveglio.
Sette donne bellissime gli stavano tutte attorno. Quando riuscì finalmente a muoversi tese le braccia a cercare di toccare quei corpi. Le donne lo fecero alzare e lo accompagnarono fuori. Attraversata la porta però, non c'era la campagna con il grano da mietere, ma il mare, nero come il petrolio. Lo condussero su quelle acque che lo rinfrescavano, ma non lo bagnavano. Quando la passeggiata ebbe termine, lo riportarono al suo giaciglio, lui si riaddormentò dopo due respiri. A coloro che gli dicevano che era stato solo un sogno, lui portava una prova inconfutabile che quei fatti fossero successi realmente.
La mattina successiva, quando si diresse verso la stalla per strigliare la cavalla, ebbe la certezza di non aver sognato. Il crine dell'animale, infatti, era acconciato con decine di piccole trecce: trizzi di donna, le chiamavano gli antichi, “trecciuole inestricabili” che le fate creavano ai capelli dei bambini accarezzandogli il capo, che ogni madre sapeva che non doveva tagliare, perché avrebbero protetto il sonno dei figli e con il tempo sarebbero cadute da sole. Da piccolo, a Totuccio piaceva ascoltare quella storia, vedeva le sette donne, una più bella dell'altra, e sarebbe voluto essere al posto di Geppino, tra le loro braccia.
Di quel racconto conosceva a memoria tutti i particolari, e correggeva ogni piccola variazione. Mastro Geppino diceva sempre che sarebbe morto come suo padre, che tornato a casa dai campi disse «Muoio» e morì, allo stesso modo tornò dal cantiere si sedette, e come se si fosse addormentato aspettando che la cena fosse pronta, spirò. Mastro Geppino non raccontava minchiate.
«Qua apparivano donne di fora, tutte una cchiù bedda di n’autra, che portavano cu iddì i cristiani in posti lontani dove si potevano vedere cose meravigliose... poi appena spuntava il sole li riportavano a casa» gli disse una volta Rosa, sua madre, quando ancora nella piazza non c'era una targa con inciso “Piazzetta sette fate”. Mastro Geppino, il padre, era paesano, arrivò a Palermo da Villalba, una decina di anni prima di conoscere Rosa, senza soldi, senza lavoro e con due cugini - che poi fecero fortuna come “imprenditori” -. Trovò lavoro come apprendista, divenne manovale, promosso mastro e infine capomastro.
Era di bassa statura, con spalle robuste e mani callose, da contadino prima e muratore dopo. A differenza di Totuccio, era ritenuto gran travagliatore, persona saggia e poco dedita a dire minchiate, e di rado si vedeva in taverna. Come gli fosse nato un figlio tanto lagnuso e farfànte era un mistero per tutti, tranne che per lui, che lo sapeva invece: era colpa del nome, lo stesso di suo fratello, perdigiorno anche lui. Mastro Geppino raccontava spesso un'avventura che gli era capitata da giovane e giurava esser vera.
Una storia che con le sette fate qualcosa aveva a che fare, e se lui e la sua famiglia avevano trovato casa proprio lì, nella piazza che portava quel nome, non poteva essere una coincidenza, perché nostro Signore ci teneva a fare appattare tutte le cose, soprattutto quelle magiche. La storia cominciava sempre allo stesso modo: «Non puoi capire chi mi capitò in contrada Bunazzo...» Mastro Geppino aveva l'espressività di un blocco di Sabucina, sia se si trovasse davanti un piatto di anelletti al forno, che al funerale della madre, che se dovesse dare due boffe al figlio, ma quando iniziava raccontare quella storia, le rughe sul volto si distendevano e un lieve sorriso gli compariva sulla bocca, come se ogni volta dovesse rivivere quella piacevole esperienza.
Era giugno e il grano si mieteva ancora a mano. A quel tempo Geppino dormiva in campagna e, come ogni sera, era andato a letto presto. Un sonno profondo lo avvolse dopo due respiri, ancora parecchie ore dovevano passare prima che facesse giorno. Dita sottili gli sfiorarono il viso, labbra morbide gli si appoggiarono sulla pelle, lunghi capelli gli scivolarono sul collo. Geppino spalancò gli occhi e li mosse in maniera rapida per cercare di capire cosa stesse accadendo. Nessuno degli altri muscoli rispondeva ai suoi comandi, non riusciva a muoversi. Il terrore per quello stato d'immobilità però svanì dopo pochi secondi: gli bastò mettere a fuoco la causa del risveglio.
Sette donne bellissime gli stavano tutte attorno. Quando riuscì finalmente a muoversi tese le braccia a cercare di toccare quei corpi. Le donne lo fecero alzare e lo accompagnarono fuori. Attraversata la porta però, non c'era la campagna con il grano da mietere, ma il mare, nero come il petrolio. Lo condussero su quelle acque che lo rinfrescavano, ma non lo bagnavano. Quando la passeggiata ebbe termine, lo riportarono al suo giaciglio, lui si riaddormentò dopo due respiri. A coloro che gli dicevano che era stato solo un sogno, lui portava una prova inconfutabile che quei fatti fossero successi realmente.
La mattina successiva, quando si diresse verso la stalla per strigliare la cavalla, ebbe la certezza di non aver sognato. Il crine dell'animale, infatti, era acconciato con decine di piccole trecce: trizzi di donna, le chiamavano gli antichi, “trecciuole inestricabili” che le fate creavano ai capelli dei bambini accarezzandogli il capo, che ogni madre sapeva che non doveva tagliare, perché avrebbero protetto il sonno dei figli e con il tempo sarebbero cadute da sole. Da piccolo, a Totuccio piaceva ascoltare quella storia, vedeva le sette donne, una più bella dell'altra, e sarebbe voluto essere al posto di Geppino, tra le loro braccia.
Di quel racconto conosceva a memoria tutti i particolari, e correggeva ogni piccola variazione. Mastro Geppino diceva sempre che sarebbe morto come suo padre, che tornato a casa dai campi disse «Muoio» e morì, allo stesso modo tornò dal cantiere si sedette, e come se si fosse addormentato aspettando che la cena fosse pronta, spirò. Mastro Geppino non raccontava minchiate.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
STORIA E TRADIZIONI
Stella, moglie del "Principone": a chi si ispira la principessa di Salina del Gattopardo
191.758 di Susanna La Valle -
STORIA E TRADIZIONI
Lasciò marito e figli, rischiò il carcere: una nobile siciliana fece follie per D'Annunzio
77.478 di Maria Oliveri

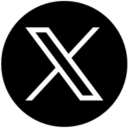



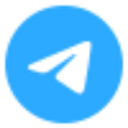


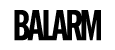





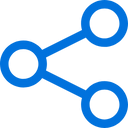
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram