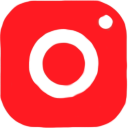STORIA E TRADIZIONI
Dove ora regna il silenzio: dentro uno dei simboli dell'archeologia industriale siciliana
Dai Florio ai giorni nostri l'archeologia industriale in Sicilia è ricca di storie incredibili e luoghi affascinanti e ormai in disuso: ecco uno dei più importanti

Ex Montedison di Casteltermini (foto di Andrea Furnari )
A definirla con il linguaggio impersonale delle enciclopedie, l’archeologia industriale è la scienza che studia i reperti e le testimonianze dell’epoca della rivoluzione industriale, in tutti i suoi aspetti e contenuti (macchine, edifici, tecnologie, infrastrutture) e le conseguenze economiche e sociali che ne derivano.
È dunque la scienza che studia le origini e lo sviluppo della civiltà delle macchine e i segni lasciati dal processo di industrializzazione nella vita quotidiana, nella cultura e nella società. Di questa affascinante e curiosa disciplina, nata intorno agli anni Cinquanta nel mondo anglosassone, ancora oggi se ne discutono, soprattutto nell’ambito delle scienze sociali, il contenuto e la denominazione stessa, che, facendo ricorso a un chiaro ossimoro, dà noia ai puristi della semantica.
L’archeologia industriale, in Sicilia come dappertutto, offre una compiuta radiografia dei processi culturali e dei rapporti sociali dell’isola, mostrando i riti di passaggio della storia dei luoghi e il condizionamento che essi hanno subito per effetto degli edifici e delle infrastrutture. Il caso più eclatante, per la sua maestosità scenografica, è quello della Fornace Penna a Sampieri, vicino Scicli.
Realizzata tra il 1909 e il 1912, andò distrutta nel 1924 in seguito a un incendio doloso, e più di recente, in attesa di un serio intervento di salvaguardia, utilizzata per alcune riprese cinematografiche. Giustamente, perché è un luogo incantevole e di fascino indiscutibile.
E però l’archeologia industriale è anche la storia dei tentativi di recupero falliti, o non pienamente soddisfatti, come per alcuni parchi minerari per l'estrazione dello zolfo nelle provincie di Caltanissetta ed Enna, ed è infine una storia di abbandono assoluto: non negoziabile, ossificato, potentemente desolante. Se volessimo trovare, per quest’ultima casistica, un luogo esemplare, una sorta di genius loci dell’archeologia industriale in Sicilia, dovremmo percorrere il territorio di Agrigento verso l’entroterra contadino.
Siamo a Casteltermini, paese fiero e arroccato, che vanta la tradizione della Sagra del Tataratà, che richiama una danza armata risalente, secondo le ipotesi di diversi studiosi, al periodo di dominazione islamica dell’isola. Il paese ebbe il suo periodo di massimo sviluppo nella seconda metà dell’ottocento grazie alla presenza di numerose miniere di zolfo (Cozzo Disi, Roveto, Scironello, Mandravecchia e diverse altre), convivendo il lavoro dei carusi – che nel frattempo si era fatto storia culturale nell’impronta dei luoghi – con l’attività agricola e terriera, di una campagna fertile e bellissima.
La tradizione industriale del paese, che pure era costellata dei gravi disastri delle miniere, solo a Cozzo Disi, una delle più grandi miniere di zolfo in Europa, dava lavoro a circa un migliaio fra operai e impiegati, e, con la crisi e la chiusura delle aree minerarie, l’aspetto industriale del paese si mantenne inalterato, anche nello spirito degli stessi abitanti.
Per tanti anni, a Casteltermini, è stato funzionante il pastificio San Giuseppe, i cui prodotti venivano esportati in varie parti della Sicilia, e che oggi rimane leggenda nello scheletro di uno stabilimento abbandonato e fatiscente, e soprattutto l’azienda su cui si fondava quasi per intero l’economia del territorio con più di duecento operai assunti: la Montedison, poi Italkali. Anzi, ad essere corretti, la ex Montedison, poi ex Italkali.
Siamo a valle di Casteltermini, nei pressi del bivio per Campofranco, e lo stabilimento è ben visibile dalla strada, la affianca per una lunga curva, ma in parte se ne nasconde. Se è quasi impossibile non vedere il luogo, credere che esso non esista così ben palesato, d’altra parte l’immagine visiva non riporta le dimensioni reali del posto.
Una specie di illusione ottica, favorita dall’estensione arretrata del vasto complesso, che non lascia intravedere la sua realtà che è quella di un complesso imponente e aggrovigliato. L’erba si è impossessata dell’asfalto, fiaccato dall’incuria e dal sole, e il cancello divelto – sottratto, sarebbe meglio dire – rende l’impensato possibile.
È tutto lì, senza alcun dissidio pirandelliano fra ciò che appare e ciò che è; sfrondata dagli echi del fascino decadente, l’immagine coincide con la più perfetta sostanza delle cose. Rifiuti industriali, un ammasso di ferraglia arrugginita, capannoni umidi con le pareti muschiate, depositi di lavoro con rottami d’attrezzature, uffici dati alle fiamme e vetri rotti, documenti abbandonati, laboratori di produzione chimica distrutti.
Se non fosse in Sicilia, sembrerebbe quella che gli ucraini chiamano «zona di alienazione», quel pezzo di territorio che isola ciò che resta della ex centrale nucleare di Černobyl. Nella frontalità piatta di questo scenario, sono possibili due stati d’animo: il ribrezzo del senso di desolazione, o la seduzione del tempo che si cristallizza in un vago senso di morte.
È un altro scenario cinematografico, in cui l’elemento di finzione è dato dalla accidentale conformazione del rapporto fra gli elementi dello spazio. Quel che è rimasto lì, è rimasto per puro caso: un cassetto aperto, una sedia sghemba, una provetta coricata, un calendario ingiallito. Il puro caso ha presieduto alla costituzione scenica di questo luogo, e l’idea del tempo ha reso l’abbandono come un’immagine ingegnosamente composta, pressoché perfetta, realizzata con dovizia di dettagli e sfumature, nel pericolo generale che tutto il complesso suscita.
In questo segmento significativo di archeologia industriale in Sicilia, irrecuperabile per i costi enormi che avrebbe la sua dismissione, il silenzio è in rapporto alle voci che devono esserci state lungo i corridoi, per le scale di sicurezza delle torrette, nei soffitti sui quali sventagliano pezzi di lamiera gracidante. Rapporti di lavoro, dunque rapporti prefabbricati: l’area dei laboratori di sperimentazione contro i capannoni della fabbrica, gli uffici contro i binari di una ferrovia abbandonata.
E, come sempre dalle nostre parti, l’effetto paradosso del sole che rende tutto non già più chiaro ma più sbavato e affascinante, dentro una crepuscolarità industriale che inquieta e pone domande, così come il precipitato emotivo che su ciascuno di noi provoca una simile visione. Del resto i termini della questione investono molto più dell’archeologia industriale, richiamando il mondo della storia dell’arte in cui le rovine e i rifiuti hanno espresso valori mitologici e destini
estetici, trasformando le cose – gli oggetti – in metafore di transito delle relazioni umane.
E se le ipotesi su questo luogo si sono distese fra immaginari utopici (recupero a fini turistici, trasformazione in padiglioni culturali), la realtà ha prevalso, così come la natura che lentamente si rimpossessa del luogo e lo fagocita sconfiggendolo. A noi, uscendo da questo luogo, è venuto in mente un libro la cui lettura dovrebbe essere resa obbligatoria nelle scuole di tutta la Sicilia.
Lo ha scritto nel 1960 Danilo Dolci, uno degli uomini più straordinari del secolo passato, che pubblicò presso Einaudi – mai più rieditato – il volume “Spreco. Documenti e inchieste su alcuni aspetti dello spreco nella Sicilia occidentale”. Spreco: un termine che declinato nel modo in cui fa Danilo Dolci nel 1960 appare senza dubbio rivoluzionario, e legge la storia di un pezzo di Sicilia secondo termini nuovi quanto nel nostro tempo ancora cogenti e attuali.
In fondo, è proprio lo straordinario libro di questo mite poeta che può ancora oggi darci conto delle ragioni del complesso industriale di Casteltermini, quando scrive in una pagina che «l’importante è rompere, da qualche parte, il cerchio contro lo spreco. [Come possono i cittadini] muoversi consapevoli, sicuri, se non possiedono gli strumenti per conoscere le linee della valorizzazione? Come possono distinguere nel groviglio delle situazioni, se non acquistano una struttura mentale analitica, una severa capacità di analisi?».
E la conclusione, lapidaria e tagliente, accompagna il passo d’uscita dai cancelli della ex Montedison ed ex Italkali, con Danilo Dolci che ci ricorda che «ogni cattiva organizzazione, ogni cattiva strutturazione significa spreco. Ogni ritardo tecnico-culturale significa spreco».
È dunque la scienza che studia le origini e lo sviluppo della civiltà delle macchine e i segni lasciati dal processo di industrializzazione nella vita quotidiana, nella cultura e nella società. Di questa affascinante e curiosa disciplina, nata intorno agli anni Cinquanta nel mondo anglosassone, ancora oggi se ne discutono, soprattutto nell’ambito delle scienze sociali, il contenuto e la denominazione stessa, che, facendo ricorso a un chiaro ossimoro, dà noia ai puristi della semantica.
L’archeologia industriale, in Sicilia come dappertutto, offre una compiuta radiografia dei processi culturali e dei rapporti sociali dell’isola, mostrando i riti di passaggio della storia dei luoghi e il condizionamento che essi hanno subito per effetto degli edifici e delle infrastrutture. Il caso più eclatante, per la sua maestosità scenografica, è quello della Fornace Penna a Sampieri, vicino Scicli.
Realizzata tra il 1909 e il 1912, andò distrutta nel 1924 in seguito a un incendio doloso, e più di recente, in attesa di un serio intervento di salvaguardia, utilizzata per alcune riprese cinematografiche. Giustamente, perché è un luogo incantevole e di fascino indiscutibile.
E però l’archeologia industriale è anche la storia dei tentativi di recupero falliti, o non pienamente soddisfatti, come per alcuni parchi minerari per l'estrazione dello zolfo nelle provincie di Caltanissetta ed Enna, ed è infine una storia di abbandono assoluto: non negoziabile, ossificato, potentemente desolante. Se volessimo trovare, per quest’ultima casistica, un luogo esemplare, una sorta di genius loci dell’archeologia industriale in Sicilia, dovremmo percorrere il territorio di Agrigento verso l’entroterra contadino.
Siamo a Casteltermini, paese fiero e arroccato, che vanta la tradizione della Sagra del Tataratà, che richiama una danza armata risalente, secondo le ipotesi di diversi studiosi, al periodo di dominazione islamica dell’isola. Il paese ebbe il suo periodo di massimo sviluppo nella seconda metà dell’ottocento grazie alla presenza di numerose miniere di zolfo (Cozzo Disi, Roveto, Scironello, Mandravecchia e diverse altre), convivendo il lavoro dei carusi – che nel frattempo si era fatto storia culturale nell’impronta dei luoghi – con l’attività agricola e terriera, di una campagna fertile e bellissima.
La tradizione industriale del paese, che pure era costellata dei gravi disastri delle miniere, solo a Cozzo Disi, una delle più grandi miniere di zolfo in Europa, dava lavoro a circa un migliaio fra operai e impiegati, e, con la crisi e la chiusura delle aree minerarie, l’aspetto industriale del paese si mantenne inalterato, anche nello spirito degli stessi abitanti.
Per tanti anni, a Casteltermini, è stato funzionante il pastificio San Giuseppe, i cui prodotti venivano esportati in varie parti della Sicilia, e che oggi rimane leggenda nello scheletro di uno stabilimento abbandonato e fatiscente, e soprattutto l’azienda su cui si fondava quasi per intero l’economia del territorio con più di duecento operai assunti: la Montedison, poi Italkali. Anzi, ad essere corretti, la ex Montedison, poi ex Italkali.
Siamo a valle di Casteltermini, nei pressi del bivio per Campofranco, e lo stabilimento è ben visibile dalla strada, la affianca per una lunga curva, ma in parte se ne nasconde. Se è quasi impossibile non vedere il luogo, credere che esso non esista così ben palesato, d’altra parte l’immagine visiva non riporta le dimensioni reali del posto.
Una specie di illusione ottica, favorita dall’estensione arretrata del vasto complesso, che non lascia intravedere la sua realtà che è quella di un complesso imponente e aggrovigliato. L’erba si è impossessata dell’asfalto, fiaccato dall’incuria e dal sole, e il cancello divelto – sottratto, sarebbe meglio dire – rende l’impensato possibile.
È tutto lì, senza alcun dissidio pirandelliano fra ciò che appare e ciò che è; sfrondata dagli echi del fascino decadente, l’immagine coincide con la più perfetta sostanza delle cose. Rifiuti industriali, un ammasso di ferraglia arrugginita, capannoni umidi con le pareti muschiate, depositi di lavoro con rottami d’attrezzature, uffici dati alle fiamme e vetri rotti, documenti abbandonati, laboratori di produzione chimica distrutti.
Se non fosse in Sicilia, sembrerebbe quella che gli ucraini chiamano «zona di alienazione», quel pezzo di territorio che isola ciò che resta della ex centrale nucleare di Černobyl. Nella frontalità piatta di questo scenario, sono possibili due stati d’animo: il ribrezzo del senso di desolazione, o la seduzione del tempo che si cristallizza in un vago senso di morte.
È un altro scenario cinematografico, in cui l’elemento di finzione è dato dalla accidentale conformazione del rapporto fra gli elementi dello spazio. Quel che è rimasto lì, è rimasto per puro caso: un cassetto aperto, una sedia sghemba, una provetta coricata, un calendario ingiallito. Il puro caso ha presieduto alla costituzione scenica di questo luogo, e l’idea del tempo ha reso l’abbandono come un’immagine ingegnosamente composta, pressoché perfetta, realizzata con dovizia di dettagli e sfumature, nel pericolo generale che tutto il complesso suscita.
In questo segmento significativo di archeologia industriale in Sicilia, irrecuperabile per i costi enormi che avrebbe la sua dismissione, il silenzio è in rapporto alle voci che devono esserci state lungo i corridoi, per le scale di sicurezza delle torrette, nei soffitti sui quali sventagliano pezzi di lamiera gracidante. Rapporti di lavoro, dunque rapporti prefabbricati: l’area dei laboratori di sperimentazione contro i capannoni della fabbrica, gli uffici contro i binari di una ferrovia abbandonata.
E, come sempre dalle nostre parti, l’effetto paradosso del sole che rende tutto non già più chiaro ma più sbavato e affascinante, dentro una crepuscolarità industriale che inquieta e pone domande, così come il precipitato emotivo che su ciascuno di noi provoca una simile visione. Del resto i termini della questione investono molto più dell’archeologia industriale, richiamando il mondo della storia dell’arte in cui le rovine e i rifiuti hanno espresso valori mitologici e destini
estetici, trasformando le cose – gli oggetti – in metafore di transito delle relazioni umane.
E se le ipotesi su questo luogo si sono distese fra immaginari utopici (recupero a fini turistici, trasformazione in padiglioni culturali), la realtà ha prevalso, così come la natura che lentamente si rimpossessa del luogo e lo fagocita sconfiggendolo. A noi, uscendo da questo luogo, è venuto in mente un libro la cui lettura dovrebbe essere resa obbligatoria nelle scuole di tutta la Sicilia.
Lo ha scritto nel 1960 Danilo Dolci, uno degli uomini più straordinari del secolo passato, che pubblicò presso Einaudi – mai più rieditato – il volume “Spreco. Documenti e inchieste su alcuni aspetti dello spreco nella Sicilia occidentale”. Spreco: un termine che declinato nel modo in cui fa Danilo Dolci nel 1960 appare senza dubbio rivoluzionario, e legge la storia di un pezzo di Sicilia secondo termini nuovi quanto nel nostro tempo ancora cogenti e attuali.
In fondo, è proprio lo straordinario libro di questo mite poeta che può ancora oggi darci conto delle ragioni del complesso industriale di Casteltermini, quando scrive in una pagina che «l’importante è rompere, da qualche parte, il cerchio contro lo spreco. [Come possono i cittadini] muoversi consapevoli, sicuri, se non possiedono gli strumenti per conoscere le linee della valorizzazione? Come possono distinguere nel groviglio delle situazioni, se non acquistano una struttura mentale analitica, una severa capacità di analisi?».
E la conclusione, lapidaria e tagliente, accompagna il passo d’uscita dai cancelli della ex Montedison ed ex Italkali, con Danilo Dolci che ci ricorda che «ogni cattiva organizzazione, ogni cattiva strutturazione significa spreco. Ogni ritardo tecnico-culturale significa spreco».
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
STORIA E TRADIZIONI
Per i cugini era un "mostro", per la madre una figlia: la storia del (vero) "Gattopardo"
181.055 di Maria Oliveri -
SOCIAL E WEB
La cicogna prende "Il Volo": chi è il tenore (siciliano) che diventa presto papà
130.605 di Redazione -
STORIA E TRADIZIONI
Lasciò marito e figli, rischiò il carcere: una nobile siciliana fece follie per D'Annunzio
77.102 di Maria Oliveri

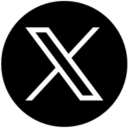



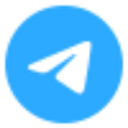


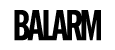





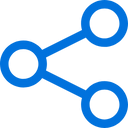
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram