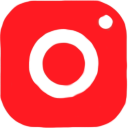STORIA E TRADIZIONI
Che cosa succede se rompi i giuramenti (in Sicilia): le 4 sventure che ti possono colpire
Per i siciliani, da sempre sospesi tra fede e fatalismo, la parola è un’arma, una preghiera e uno specchio dell’anima. Le sanzioni per chi tradisce sono iperboliche

Ciò che li rende unici è la sanzione che li conclude: una formula di autodemònio, un’invocazione di sventura su sé stessi in caso di spergiuro. Questa pratica, radicata in secoli di storia isolana, riflette una visione del mondo in cui la parola data ha peso concreto, e romperla significa sfidare non solo gli uomini, ma il destino stesso.
Le sanzioni per chi tradisce un giuramento sono spesso iperboliche e teatrali, costruite per impressionare e dimostrare la massima serietà.
Esempi classici
«Privu di la vista di l’occhi!» (Che io perda la vista degli occhi!)
«Mancari mi tagghìanu a lingua!» (Che mi taglino la lingua!)
«Si mentu, lu sangu mi si sicca!» (Se mento, che il mio sangue si secchi!)
«Ca mi scoppia lu cori!» (Che mi scoppi il cuore!). «Privu di lu pani!» (Che io resti senza pane!).
Queste formule attingono a un repertorio di simboli ancestrali: gli occhi (la percezione della realtà), il cuore (la vita e l’onore), il sangue (i legami familiari).
Colpiscono ciò che è più sacro all’individuo, trasformando il giuramento in un patto col destino. Alcuni studiosi riconducono queste sanzioni a rituali pagani di auto-maledizione, simili a quelli attestati nel Mediterraneo antico come le defixiones romane, tavolette di piombo, bronzo o terracotta su cui gli antichi Romani incidevano maledizioni, invocazioni a divinità infernali o formule magiche per danneggiare nemici, rivali o persone ritenute colpevoli.
Con l’avvento del Cristianesimo, le sanzioni si sono fuse con la pratica dei giuramenti su santi o reliquie. Tuttavia, mantengono una componente "magica", quasi una sfida al fato. Fino al XIX secolo, era comune giurare su santi locali con formule come: «Sant’Agata mi squagghi lu cori si nun dico lu veru!» (Sant’Agata mi sciolga il cuore se non dico la verità!).
Sant’Agata, patrona di Catania, è invocata per punire lo spergiuro, ma la metafora dello "scioglimento del cuore" richiama antiche maledizioni legate al corpo. In una società storicamente segnata da povertà e dominazioni straniere, la parola era l’unico "contratto" accessibile a molti. La sanzione fungeva da garanzia in assenza di leggi scritte.
La paura della "maledizione autoinflitta" dissuade dal mentire, soprattutto in contesti pubblici e pronunciare una sanzione è un atto performativo che dimostra coraggio e convinzione, rafforzando la credibilità presso la comunità. In dispute o riconciliazioni, la sanzione chiude simbolicamente il conflitto, come un giudizio divino in miniatura.
Ad esempio, veniva usato giurare in litigi tra vicini dicendo: «Ti giuru ca nun fuiju, ca mi si stacca stu picciulu!» – Ti giuro che non sono stato io, altrimenti mi si stacchi questo dito!. In alcune zone, gli innamorati giuravano fedeltà con formule come questa: «Si ti tradisciu, mi mangia la terra!» (Se ti tradisco, che la terra mi inghiotta).
Autori come Giovanni Verga e Luigi Pirandello hanno immortalato questi giuramenti nelle loro opere, sottolineandone il dramma e la poeticità crudele.
Nel Mastro don Gesualdo (Verga), i personaggi giurano «per l’anima dei morti» e quando Gesualdo giura di proteggere la figlia Isabella («Per questa croce!»), la sanzione implicita è la dannazione eterna se fallisce.
La sua ascesa e caduta sono segnate da promesse che diventano catene, riflettendo l’ineluttabilità del fato tipica del Verismo. In Liolà (1916) il protagonista giura di essere il padre del figlio di Mita, sfidando le ipocrisie del matrimonio, dicendo «Lo giuro sul capo di mio figlio!».
La sanzione (il male al figlio) è una provocazione alla società patriarcale. Pirandello mostra come i giuramenti siano maschere vuote, usate per ribaltare le convenzioni, non per onorarle. Mentre nelle novelle pirandelliane le sanzioni rivelano l’assurdità delle convenzioni sociali.
Per i siciliani, da sempre sospesi tra fede e fatalismo, la parola è un’arma, una preghiera e uno specchio dell’anima.
Questi giuramenti, nella loro drammaticità, restano una testimonianza unica di come una cultura abbia trasformato la paura della sventura in un codice etico, scolpito non su tavole di legge, ma nella carne viva delle parole.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
STORIA E TRADIZIONI
Stella, moglie del "Principone": a chi si ispira la principessa di Salina del Gattopardo
190.601 di Susanna La Valle -
STORIA E TRADIZIONI
Avevano l'oro bianco, Franca Florio le rifiutò: donne e "matri" (senza nome) in Sicilia
81.523 di Susanna La Valle





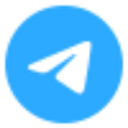


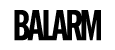

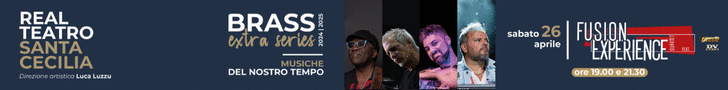


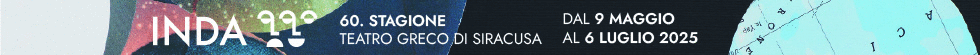
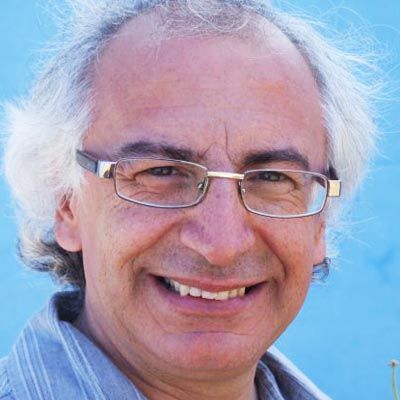
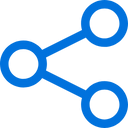
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram