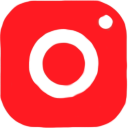STORIA E TRADIZIONI
Quando in Sicilia non si buttava via niente: l'antico (e curioso) mestiere del "capiddaru"
Un tuffo nel passato: vi portiamo in una Sicilia d'altri tempi, quella più povera, dove anche i beni più semplici avevano grande valore e non esistevano sprechi

(Foto di Federico Patellani)
Anche il capiddaru (detto pure capillaru, capillaro o compratore di capelli) occupa un posto di rilievo nel grande elenco dei mestieri tradizionali.
Questa antica professione, strettamente legata alla vita rurale e alla cultura popolare, affonda le sue radici in un'epoca in cui l'economia domestica e l'artigianato rappresentavano i pilastri della vita quotidiana.
Il termine “capillaro” si riferisce a un artigiano specializzato nella raccolta, lavorazione e commercio dei capelli umani. Sebbene oggi possa sembrare un'occupazione insolita o addirittura bizzarra, questo lavoro ha avuto per secoli un ruolo fondamentale nelle comunità meridionali, soprattutto in regioni come la Sicilia, la Calabria e la Campania.
L’antico mestiere nasce in un contesto di grande povertà, dove anche i beni più semplici, come i capelli, potevano avere un valore economico significativo. Le ciocche, infatti, venivano utilizzate per creare parrucche e altri accessori di moda, probabilmente destinati alla nobiltà e alla borghesia.
Inoltre, il materiale lavorato dall’artigiano serviva per la produzione di reti per pescatori e altri strumenti di uso quotidiano.
Il capillaro girava per la città con il suo carretto colmo di scatoline e si occupava di acquistare i capelli dalle donne del paese, spesso in cambio di denaro, piccoli oggetti o beni di prima necessità.
Le cittadine, spinte da esigenze di natura economica, accettavano di tagliare i loro lunghi capelli, che rappresentavano una delle poche risorse vendibili. Ma non tutte le ciocche avevano lo stesso valore.
Le chiome lunghe e setose delle ragazze erano maggiormente apprezzate, rispetto ai ciuffi bianchi delle signore più anziane. Spesso lo scambio avveniva dopo lunghe trattative; di conseguenza, più alto era il valore delle ciocche, più cresceva l’orgoglio delle proprietarie che riuscivano a concludere un buon affare.
Una volta raccolti, i capelli venivano accuratamente selezionati, lavati e trattati per essere venduti ai produttori di parrucche o ad altri acquirenti.
La lavorazione richiedeva grande abilità e attenzione, poiché i capelli dovevano essere districati, ordinati per lunghezza e colore, e intrecciati o tessuti meticolosamente. Questo processo poteva richiedere diverse settimane e spesso coinvolgeva più membri della famiglia del capillaro.
In alcuni casi, questa figura si sovrapponeva a quella del parrucchiere o della pilucchiera che, oltre a tagliare e acconciare i capelli, si occupavano della loro vendita e lavorazione.
Con il passare del tempo, però, il mestiere del compratore di capelli ha iniziato a scomparire, soprattutto a partire dalla seconda metà del XX secolo. L'industrializzazione, l'introduzione di materiali sintetici e la crescente disponibilità di prodotti commerciali hanno gradualmente ridotto la domanda di capelli naturali e, di conseguenza, l'importanza di questa antica occupazione.
In aggiunta, il cambiamento delle condizioni economiche ha portato a un aumento del benessere generale, riducendo la necessità di vendere i propri capelli per far fronte a difficoltà economiche. Nonostante questo, il mestiere del compratore di capelli rimane un simbolo di un'epoca passata, in cui ogni risorsa, per quanto semplice o apparentemente insignificante, aveva un valore concreto.
Oggi la memoria di questo antico lavoro sopravvive soprattutto nelle testimonianze orali, nei racconti popolari e in alcuni musei etnografici che ne conservano gli strumenti e le tecniche.
Il capiddaru è una finestra su un mondo lontano, fatto di sacrifici, ingegno e resilienza, una forma di partecipazione a un'economia circolare che non conosceva sprechi.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
STORIA E TRADIZIONI
Stella, moglie del "Principone": a chi si ispira la principessa di Salina del Gattopardo
192.309 di Susanna La Valle -
ITINERARI E LUOGHI
Quando arrivi ti senti in un’altra epoca: in Sicilia si trova la stazione più bella d'Italia
112.743 di Salvo Caruso





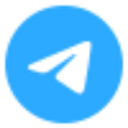


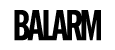




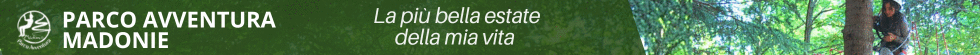

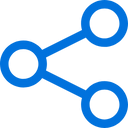
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram