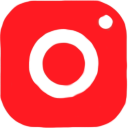Quando a fine estate si correva tra i palazzi: cos'era il Mondialito tra le strade di Palermo
Il racconto del tradizionale torneo che negli anni '90 coinvolgeva i ragazzini delle periferie palermitane, subito dopo il rientro in città dalle villeggiature estive

Il torneo giocato tra i palazzi palermitani
Era quel periodo tra fine estate e l’inizio delle scuole, quello in cui chi poteva s’arricampava dalla villeggiatura, chi non poteva s’attaccava al tram e vedeva gli altri arricamparsi dalla villeggiatura.
Eppure, in quella sorta di limbo dantesco fatto di compiti per le vacanze e ascelle sudate, nelle periferie palermitane prendeva vita il Mondialito tra palazzi dello stesso quartiere. Non era solo calcio, non poteva esserlo, non per noi italiani.
Perfino Wiston Churchill quando parlava di noi diceva: «Gli italiani perdono le partite di calcio come fossero guerre e perdono le guerre come fossero partite di calcio». Beh, come dargli torto?
Chi è nato in periferia d’altronde lo sa: sotto la pelle di quel grigio e inanimato asfalto i palloni di plastica rotolavano e a volte ci lasciavano impresse le poesie. Carollo e Randazzo erano i capitani, titolo che perlopiù si guadagnava per questioni anagrafiche, per numero di sciarre fatte, per numero di bocciature a scuola.
Erano loro che decidevano chi veniva convocato e chi no, questo solo dopo un anno di partite interne al palazzo. E per l’appunto, erano sempre loro che decidevano quando finiva il riscaldamento e ci si portava a centro di campo per fare le squadre.
Uno teneva il pallone sotto il braccio, l’altro solitamente si spremeva la pompetta inguinale perché l’aveva per vizio. La sorte aveva un ruolo determinante in tutto questo e solitamente si optava per il classico pari&dispari; poi c’era anche un sistema di conta più misterioso, «tocco io, tocchi tu», che però generava quasi sempre mali discorsi e andava a finire a tirate di capelli e sputazzate.
I membri delle squadre venivano tassativamente scelti dal più forte al più scarso, e quindi io e Amato rimanevamo inevitabilmente gli ultimi a guardaci negli occhi, in quanto insigniti del titolo di “pacchi del palazzo”, senza sapere ogni volta dove saremmo andati a finire.
In pratica venivamo selezionati per “non scelta” e destinati a difendere i pali di una porta fantomatica che il più delle volte partiva dalla macchina del signor Pace e arrivava al paletto dove si inseriva la chiave per aprire il cancello automatico. La traversa invece non aveva un’altezza definita, per convenzione s’avvicinava al record mondiale di Thierry Vignerol di salto con l’asta del 1984.
«Palla o campo?» chiedeva a quel punto uno dei due capitani all’altro, per decretare chi giocasse sotto la curva dei gatti randagi e chi sotto il balcone del capo condominio, poi si cominciava.
Comunque, alla fine del detto apprendistato, in base alle prestazioni stagionali, si sceglievano finalmente i convocati per il Mondialito. Quell’anno però i fratelli Ammirata si erano andati a rompere le corna con la bicicletta e inaspettatamente io e Amato, che di solito facevamo i tifosi, fummo convocati in extremis.
Otto palazzi si sarebbero sfidati in un torneo ad eliminazione, andata e ritorno nei rispettivi stadi di appartenenza, con finale secca nel campetto sempre in asfalto della scuola ma senza porte.
Magliettina blu bidello “Fruit of the Loom” comprata in blocco al mercatino, pantaloncini a comegghiè, scarpe di tela che ai tempi arregalavano con il detersivo: questo era il nostro completino.
Direttori di gara manco ammazzati perché ci stavano già maestri e professori nelle nostre vite, in compenso però la gara veniva diretta da una sorta di forza misteriosa a metà tra l’occidentale libero arbitrio e l’orientale Karma.
Il sorteggio delle squadre ci venne a favore perché nella partita di esordio incontrammo i palazzi bianchi. Erano i fighetti della via Oreto, tant’è che si permettevano pure il lusso di fare altri sport a pagamento, chi tennis, chi piscina, chi karatè. Nonostante fossero gli unici a possedere un campetto di calcio, sempre in asfalto, erano però i più scarsi.
Randazzo quel campo lo conosceva bene perché un anno aveva giocato in prestito ai palazzi bianchi e fu questo l’elemento determinante. Sfruttando proprio il muretto laterale che recintava il campetto e sfruttando la famosa tecnica della carambola - in cui si superava l’avversario facendo una specie di 1-2 col muretto - riuscì a scardinare la difesa e portarsi a casa ben sei gol (le partite tipo finivano con i punteggi del tennis) assicurandoci il passaggio del turno.
A partita vinta ci aspettava il signor Benito del bar San Francesco con una bella arancina a’ccarne e freschissimo bicchiere d’acqua, che ancora erano di vetro e che con grande orgoglio hanno contribuito alla diffusione dell’herpes in tutto il quartiere. In semifinale ci capitò il derby con i palazzi gialli.
Essendo che entrambi i complessi erano stati edificati dal medesimo costruttore accusato di favoreggiamento, e in quel periodo si trovava pure lui in villeggiatura (quella al fresco però…), sentivamo questa sorta di rivalità naturale.
Beh, la partita fu combattuta soprattutto a centro campo, anche perché proprio in quel punto ci stava l’aiuola di gerani con il palo della luce alla quale stava sempre attaccata la vespa del professore Terranova che abitava lì.
Nonostante la partita rognosa galleggiasse sul pareggio, un tiro da fuori di Carollo si andò a stampare contro la parte interna del palo immaginario. In questi casi critici, la squadra che reclamava il gol, andava incontro al capitano avversario avvalendosi di un’antica consuetudine di origine sconosciuta: «gol o rigore?»
Ovvio che gli avversari optavano per il rigore, e noi per fortuna proprio in Carollo avevamo lo specialista del dischetto, poiché tirava di puntazza arraggiata non lasciando scampo ai portieri. Non avemmo nemmeno il tempo di festeggiare la finale conquistata perché il nostro occhio era timorosamente puntato dall’altra parte del tabellone, dove le case popolari avevano sbaragliato tutti con 30 gol a partita.
Minchia che erano forti le case popolari! Erano il Brasile della via Oreto. Sa’ che mangiavano, ma erano tutto un altro pianeta.
Entrati in campo ci tremavano le gambe, cioè agli altri perché io ero in panchina. In men che non si dica ci stamparono tre gol facendoci uscire il pallone pure dalle orecchie. Poi un gol noi, altri due loro. Arrivammo a fine primo tempo stremati con la lingua di fuori, loro ridevano e scherzavano.
Randazzo a quel punto ci convocò dietro la scuola. «Mangiatevi queste e vedete come volate!» Erano delle pillole rotonde di nome Zigulì che sapevano di banana.
Forse fu l’effetto placebo, forse fu l’effetto banana, dopo circa altre due ore di gioco (anche le partite non avevano un tempo definito), che ci trovavamo due gol sotto, Randazzo scattò sulla fascia e lasciò partire un destro in corsa che si infilò sotto l’incrocio a circa tre metri di altezza.
Pur di compiere il gesto eroico però cadde a pancia in giù strisciando, facendo la fine del cacio cavallo contro la grattugia, e fu costretto a uscire. Non ci potevo credere ma mi buttarono in mezzo al campo. Quelli furono i miei 45 interminabili secondi di gloria.
Erano già quasi ora cena come a San Siro giocavamo illuminati dai lampioni della scuola. Il nostro portiere fece un rinvio lanciando il pallone verso la luna che sembrava avere tutte le intenzioni di riatterrare dalle mie parti. Un calcione al volo di sinistro e dove finisce finisce, ma lisciai clamorosamente.
La dea del calcio però quel giorno aveva altri programmi, e sbattendomi sul piede malato (così chiamavo il destro) il pallone rimbalzò trasformandosi in un assist per Carollo che era sottoporta. Il loro portiere però vendeva le angurie al mercatino e abituato a maneggiare queste, era praticamente insuperabili.
Carollo si spremette come un tubetto di maionese per arrivare al pallone ma la sua puntazza arraggiata questa volta non riuscì ad imprimere potenza.
Ancora una volta la dea del calcio ci mise lo zampino: per nostra fortuna il signor Giordano in quel momento stava facendo intrallazzo collegando la sua corrente di casa al palo pubblico. Di solito era un chirurgo, ma quella volta commise un errore facendo saltare la luce di tutto l’isolato.
In un istante il buio assoluto e il silenzio assoluto, interrotto solo dal rumore della lattina posta dietro la linea di porta a confermare che il pallone era entrato.
Questa è la storia di come ci laureammo campioni a parimerito delle case popolari. Altri tempi, altre vite, dove a parte il signor Giordano che murritiava con i fili elettrici, i bambini non stavano con i telefoni in mano.
Neanche questo lo dico io, lo diceva Antonio Gramsci: «Il calcio è regno della lealtà umana esercitata all’aria aperta».
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
STORIA E TRADIZIONI
Stella, moglie del "Principone": a chi si ispira la principessa di Salina del Gattopardo
190.348 di Susanna La Valle -
STORIA E TRADIZIONI
Lo schiavo (ribelle) che divenne re di Sicilia: chi conosce la storia di Euno
44.578 di Aurelio Sanguinetti

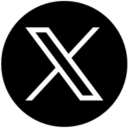



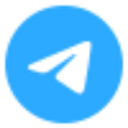


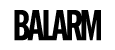

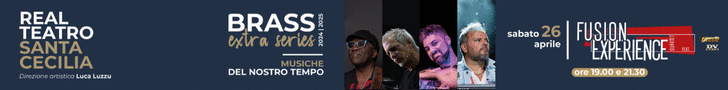




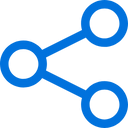
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram