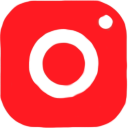STORIA E TRADIZIONI
"Pizzintuni", "sciampagnuni" o "poviru": le (tre) sfumature dell'essere avidi in Sicilia
Vi raccontiamo tre storie che si intrecciano sull'"ubbidizia", legate al potere e alla campagna nella Sicilia rurale ma che per certi versi ci appartengono anche oggi

D’inverno le giornate limpide erano rare, brevi intervalli fra i lunghi periodi di pioggia che iniziavano a novembre e finivano a marzo avanzato, il cielo restava ingombro di nubi ferrigne che come un coperchio lanoso e cupo, soffocavano la valle. "A cutra niura" la chiamava la gente. Con grandi sacrifici era riuscito a comprare, un pezzetto alla volta uno spicchio del colle e una striscia della valle sottostante fino al fiume.
Ancora prima di esserne proprietario, quando sognava di diventarlo, saliva lassù per stabilire dove mettere la vigna, gli ulivi, l’orto, la casa. I suoi desideri concretizzati erano lì: un insieme di figure geometriche, diverse fra loro per grandezza, forma, e che cambiavano colore secondo le stagioni.
Adesso possedeva la terra e per tutti era "Don Alfonso" e non più "Alfonsino u figghiu du zappunaru du baruni Cannitu". Il Barone Alfredo Cannito, sempre incazzato e sempre pronto ad umiliare tutti, chiamava i suoi lavoranti "bestie", "gnuranti", "animali di saja", pretendeva molto e pagava poco e in ritardo.
Ogni giorno si lamentava della magra, a suo dire, resa della masseria:
- mancu pi tassi mi bastunu! Ripeteva querulo, mancu pi tassi!
Nessuno mai si ribellava alle sue inique e quotidiane sfuriate, tutti rispondevano sempre e solo ”sissignuri Baruni”, con gli occhi bassi e con la coppola in mano.
Spesso accampava pretesti per lavori mal fatti, per non pagare intere giornate di lavoro. Aveva cacciato coloro che avevano osato appropriarsi di qualche frutto mezzo marcio e di qualche pezzo di legno per scaldarsi.
Da ragazzo Alfonso aveva avuto tanta soggezione di quell’uomo alto e scarno, dal viso grifagno, brusco e che da sempre indossava lo stesso frusto vestito, in qualunque stagione. Visto così in mezzo ai contadini, sembrava il più pezzente.
Passava tutto il giorno appresso ai contadini, non aveva mai voluto un massaru controllava tutto personalmente, controllava ed annotava su un libricino, contava le uova, le galline, pesava la frutta, gli ortaggi, contava e controllava ossessionato dalla certezza di essere derubato dai suoi operai. Contava annotava e si lamentava… .
-mancu pi tassi mi bastunu!
La frutta e gli ortaggi migliori venivano venduti e per sé lasciava solo gli scarti che divideva con maiali e galline, recuperava ogni chicco di frumento caduto fuori dai sacchi bagnando l’indice nella saliva.
Sempre appresso ai lavoranti, incitandoli al lavoro e quando questi si accingevano a mangiare, con la scusa che era troppo occupato e preoccupato per pensare a portarsi la colazione, ogni giorno finiva per scroccare un pezzo di pane, qualche oliva. La spilorceria del barone era nota a tutti, e i pettegoli sostenevano che quello fosse l’unico suo pasto quotidiano.
La sera quando tornava a palazzo Cannito era troppo stanco per prepararsi la cena, da quando era morta la moglie e poi la fedele serva che lo aveva visto nascere, non aveva più voluto servitù per casa, anche se aveva il figlio ancora adolescente da crescere e che, non per vocazione ma per comodità mandò in seminario dove non doveva pagare retta.
A poco a poco smise di frequentare i suoi "pari", anche con i parenti più prossimi troncò ogni rapporto. Figlio unico, era stato educato al risparmio e alla diffidenza, si era sposato per obbedire al padre, e il già solido patrimonio fu accresciuto dalla dote della moglie.
L’antico splendore di palazzo Cannito era vivo solo nei racconti dei più anziani, come una leggenda che narrava di grandi saloni, sontuosamente arredati, di feste, musica, balli e cibi così buoni come possono essere buoni solo i cibi dei ricchi. Il barone sembrava non accorgersi dei balconi che crollavano un pezzo alla volta, delle finestre sgangherate, dell’acqua piovana che ad ogni pioggia diventava sempre più invadente.
Le stanze erano pregne di tanfo, topi e muffa gareggiavano nella distruzione di ogni cosa. Ogni oggetto, ogni mobile, era stato lasciato lì, indifeso. Alfonso crebbe con la convinzione che più terra si possiede, più rispetto e soggezione si incute negli altri, e a dismisura crebbe in lui la smania di possedere terra.
In cima al suo colle si sentiva come un re sul trono, guardava il campo del grano bruno in autunno, verde in primavera, dorato prima della mietitura e sbiadito dalle stoppie cotte dal sole dopo. Guardava le linee verdi ed ordinate della vigna, le chiome argentate degli ulivi che si lasciavano scuotere pazienti dalla tramontana.
Era una vera benedizione la tramontana! Riusciva a disfare quelle nubi di piombo che buttavano acqua fina fina, lenta e silenziosa, e che restavano come incastrate per giorni e giorni nella valle. Quelle nubi, come brandelli di stoppa grigia, arrivavano basse, lente, spinte dal vento di jusu ed andavano ad adagiarsi mollemente sulle pendici dei monti, ammassandosi una sull’altra, finché tutto perdeva colore e i monti intorno venivano cancellati.
- “Malanova mi avi stu tempu!” .
Tutti imprecavano contro quel cielo, che cielo non era, contro quell’ammasso cinereo grondante acqua, capace di ammuffire la biancheria nei cassetti e di reumatizzare le ossa della gente, fino a scollargli le giunture. Anche il padre di Alfonso era morto così, con le carni tarlate dalle piaghe, dopo anni di assoluta immobilità e di precoce putredine.
I giorni di cutra niura, non preoccupavano più Alfonso come quando era ragazzo, adesso i suoi magazzini erano pieni di grano, olio, vino, noci, salami, formaggi e legna, tanta legna per riscaldarsi.
Ogni sera, prima di coricarsi, aveva bisogno di andare a vedere, per rassicurarsi che gli stenti, la fame e il freddo della sua infanzia , ormai fossero solo un brutto ricordo, come quando la madre accendeva il fuoco solo il tempo necessario per preparare da mangiare, perché la legna e il carbone scarseggiavano sempre.
Le lunghe notti d’inverno passate a rabbrividire nel freddo umidore del letto. Questo "rassicurarsi" era la ricompensa. Il suo modo di vivere, sempre modesto come le sue origini, non lasciava trasparire alcuna agiatezza.
Tutto quello che riusciva a guadagnare, serviva solo per comprare altra terra e così quello che aumentava era solo il lavoro, che non dava tregua, mai, nemmeno nei giorni di festa.
Non pensava nemmeno di abbellire la sua casa, di vestire meglio, o pagare qualche aiutante, per concedersi qualche momento di riposo, anzi continuava a lavorare con l’accanimento disperato di chi ogni giorno deve procurarsi da vivere.
Non ostentava nessun atteggiamento di pidocchiu rifinutu, normale per chi raggiunge un certo benessere, e che dopo tanti sacrifici e stenti, è propenso a concedersi tutto quello che gli era stato negato, magari esagerando un po'.
Le malelingue dicevano che Don Alfonso, le sue terre le aveva comprate imbrogliando il barone Cannito.
Quando il padre di Alfonso, gravemente malato non poté più lavorare , dopo più di quaranta anni di servitù fedele, mal pagata e senza alcuna assistenza, Alfonso prese il suo posto deciso a prendersi quello che gli spettava per assicurare al padre le cure necessarie.
Cominciò sottraendo o "rubando" quello che riteneva gli spettasse per pareggiare i conti con il padrone. Non approfittò mai oltre quello che aveva stabilito come giusta quota. Tutto questo Alfonso lo potè fare perché il barone Alfredo Cannito intanto era morto e suo figlio "u baruneddu Luigi", invece di controllare la masseria, preferiva stare in città, fra gli amici, per giocare a carte e per, come diceva lui - assaggiari sempri fimmini novi .
Alfredo Cannito quando era vivo, non aveva mai permesso al figlio di interessarsi dell’amministrazione delle proprietà. Anzi lo scoraggiava dicendogli:
- “non su cosi pi tia, tu si troppu bonu! Pi scummattiri cu sti sagnetti di lauranti”
- "u sangu ni stanu sucannu!".
Era morto di novembre, sotto un’acquerugiola quasi nebulizzata, mentre urlava contro le donne che raccoglievano le olive :
-“troppu lenti siti ! troppu lenti….”.
E rimase riverso sui sacchi pieni di olive, stringendo fra le mani il libricino dove annotava tutto. Quando i contadini lo portarono a Palazzo Cannito per comporre la salma, non trovarono nemmeno un vestito nell’intero guardaroba ammuffito e rosicchiato dai topi, alla fine dovettero mettergliene uno della buon’anima dell’avvocato Timpa, generosamente donato dalla vedova.
Il suo viso reso ancora più rapace dalla livida immobilità della morte, spuntava da quel vestito troppo largo e lungo per lui, come da sotto un cumulo di stoffa morbidamente gualcita. Era morto povero così come era vissuto, aveva recitato bene la sua parte, e suo figlio lo aveva sempre creduto:
-“mancu pi tassi mi bastunu!”.
Quando il notaio comunicò a Luigi Cannito, la ricca consistenza delle sue sostanze, egli non provò alcuna gioia, ma rabbia, rabbia per quel padre che da sempre lo aveva tradito condannandolo alla miseria e alle rinunce solo per ammassare denaro, tantissimo denaro! Per giorni e giorni fu ossessionato non da ciò che ora aveva, ma da ciò che aveva perso.
Anni in seminario, penosi perchè senza alcuna vocazione, solo perché non doveva pagare rette! Aveva rinunciato alla vita sociale, perché sapeva di non poter stare al passo con gli altri nobili.
Ripensò agli anni in seminario come ad una prigione. Ripensò a quando sfuggiva gli amici, i loro inviti a far bisboccia, le serate a teatro, l’inconfessato amore per Matilde così ricca e così inavvicinabile per lui.
-I soddi picca sunnu!
-Appena appena putemu campari!”
Lo aveva creduto! Per tutta la vita lo aveva creduto! Non ritornò in seminario, creando imbarazzo nel clero locale, che comunque cercò di giustificarlo:
- “U dispiaciri fu troppu forti….Vuleva troppu beni a so patri… .
E la sua rabbia ora esplodeva fracassando tutto quello che capitava a tiro, fino a crollare privo di forze. Molti cominciarono a pensare che il barone Luigi Cannito fosse impazzito, non riuscivano a capire la sua rabbia:
- “ma comu? Truvau i beddi dinari sabbati, e si siddiò?”.
Una sera invece di fracassare le ultimi suppellettili rimaste, indossò il suo migliore vestito, camminò nel gelo che precede il Natale, fino al cimitero, scavalcò il muro e giunto davanti alla tomba del padre, sputò più volte.
L’indomani senza preoccuparsi di osservare un minimo periodo di lutto, andò a vivere in città in un lussuoso albergo, circondandosi di servitù, di agi e di belle donne.
Per il barone Cannito, spendere freneticamente, non era solo un disperato tentativo di recuperare il tempo perduto, ma anche una vendetta nei confronti del padre. Godeva nell’immaginare il suo tormento, mentre dall’altro mondo assisteva a quello scialo.
-“ Appena appena, putemu campari…".
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
STORIA E TRADIZIONI
Stella, moglie del "Principone": a chi si ispira la principessa di Salina del Gattopardo
190.912 di Susanna La Valle -
STORIA E TRADIZIONI
In Sicilia solo un'altra parola vale quanto questa: perché un "suca" è per sempre
100.983 di Alessandro Panno -
CINEMA E TV
È palermitana e la vedi ancora su Rai 1: chi è la nuova attrice in "Mina Settembre"
100.899 di Redazione

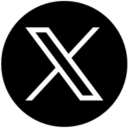



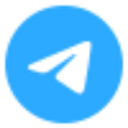


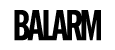

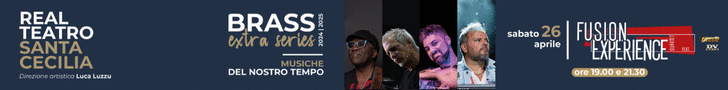



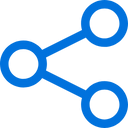
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram