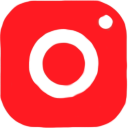STORIA E TRADIZIONI
Pagate per piangere e disperarsi ai funerali: chi erano le "prefiche" della Sicilia contadina
La spettacolarizzazione della morte nell’Isola e il pianto rituale delle antiche "reputatrici", donne del popolo assoldate per disperarsi sui defunti e narrarne le gesta

Pianto rituale funebre del Sud Italia, documentato dall'antropologo Ernesto de Martino negli anni Cinquanta del Novecento
Persino il Barocco ha trovato terreno fertile per prosperare in tutte le nostre città, riflettendo nelle sue opere la fisicità e la platealità dell’indole siciliana e più genericamente mediterranea. E neppure la morte è rimasta esente dalla nostra tendenza alla spettacolarizzazione.
Alle Catacombe dei Cappuccini di Palermo i morti, sin dal Cinquecento, sono stati cunzati nelle nicchie alle pareti o nelle bare scoperchiate per stupire e incuriosire, prima ancora che per consentire ai propri cari di prendersi cura di quei corpi mineralizzati dal tempo.
A Napoli il Cimitero delle Fontanelle accoglie più di 40 mila capuzzelle, crani e ossa di vittime della peste e del colera, considerati appartenenti ad anime derelitte, le pezzentelle, che infondono protezione a chi si prenda cura dei loro resti.
Tra di esse vi è la capa che suda di Concetta, un cranio sempre bagnato e lucido, forse per l’umidità, che i fedeli interpretano come sudore dell’anima affaticata dalle sofferenze del Purgatorio e a cui chiedono grazia e misericordia.
Alle capuzzelle, che vengono scelte annusandole e palpandole e che diventano a tutti gli effetti membri della famiglia, si confidano segreti e dolori, si chiedono benedizioni e intercessioni e in cambio si illuminano con i ceri e si spolverano e lucidano i loro resti (persino con i detergenti usati sui mobili di casa).
In Sicilia i morti sono ovunque, nell’aria, nelle case, per le strade e le campagne: tornano dall’aldilà a molestare i vivi come spettri vaganti o in sospetto di magia. Le persone appena defunte sono inoltre sottoposte a un lungo rituale che coinvolge tutta la comunità, non soltanto i parenti stretti.
Sicuramente nel vecchio mondo contadino, questo rituale, come ci raccontano anche Pitrè e Salomone Marino, era più articolato e scrupoloso, ma in qualche modo usanze e credenze storiche sono ancora praticate e vissute nella cultura borghese odierna.
Una per tutte l’esposizione pubblica del caro estinto, ben vestito, ornato e dotato di oggetti affettivi (fotografie, doni, memorie), nella bara al centro della principale stanza di rappresentanza della casa, possibilmente con i piedi rivolti in augurio verso la porta d’uscita e senza specchi alle pareti oppure con gli specchi coperti o capovolti per scongiurare che l’anima ne possa rimanere imprigionata.
Anticamente il rituale contadino aveva inizio con il viatico (l’ultima Eucarestia) del moribondo, «contento che Trasi lu Signuri e trasi pri grazia», cui seguivano mille rosari e gloria fino all’Estrema Unzione, mentre le «comari […]», racconta Pitrè, «per tenerezza, fan mille smorfie e versacci per non dar a capire al moribondo ciò che egli spesso ha benissimo capito (per tutta quell’insolita ed affettata pietà), che le sue ore di vita son contate».
Se la morte però non sopraggiungeva entro il mezzogiorno successivo all’inizio dell’agonia, si sospettava l’influenza di forze sovrannaturali contro cui si prendevano subito provvedimenti (sbattendo con vigore, per esempio, i vestiti del moribondo fuori di casa); se invece si verificava presto, ci si rammaricava di essersi affidati alle inutili cure mediche invece che alla pietà dei Santi.
Il corpo veniva quindi pulito, ben vestito e agghindato (alle donne si faceva spesso indossare l’abito nuziale appositamente conservato per l’occasione) e in certi casi truccato così pesantemente che nel Seicento, ci dice sempre Pitrè, dovette intervenire il Vescovo per interdire questa pratica «stomachevole».
Aveva allora inizio lo psicodramma collettivo: prima ci si guardava meravigliati e confusi per l’accaduto, come fosse inaspettato, e poi, come nell’antica tragedia greca, seguivano pianti, urla e lamenti delle donne di casa, che, sciogliendo i capelli sul petto e le spalle, caricavano lo stato bestiale, selvaggio, causato dal dolore.
Un motto popolare non a caso recita che dui sunnu l’amuri pruvati: matri cu figghiu e soru cu frati! Piangeva quindi la madre: Figghiu mio, e comu muristi! / Figghiu mio, e comu m’abbannunasti? / Figghiu mio, e come ‘un mi senti? / Figghiu mio, come ‘un ti viju cumpariri cchiui? […] / Figghiu mio, ch’eri beddu quannu ridivi! […] / ‘Un ti calavi ‘na pàssula senza tò matri… / Figghiu di l’arma mia!
E se al Nord Italia i cortei funebri erano seguiti dagli orfanelli, ingaggiati appositamente, dietro compenso (in favore degli Istituti religiosi di riferimento), per piangere il defunto, in tutto il Meridione e in Sardegna, c’erano invece le lamentatrici, chiamate in Sicilia reputatrici, donne di basso ceto sociale e molto povere, che, almeno fino agli anni Cinquanta del Secolo scorso (oggi raramente), con lo scopo di sfamare se stesse e i propri figli, si facevano assoldare per piangere i morti degli altri e per intonare nenie funebri che inneggiassero alle gesta e alle virtù dei cari estinti.
Come le antiche prefiche del mondo egizio e greco-romano, vestite e velate rigorosamente di nero, a lutto, le reputatrici si lanciavano in performances estreme, gridando, disperandosi, percuotendosi il petto e la testa, battendo i piedi per terra, lacerandosi le vesti, strappandosi i capelli e graffiandosi il volto.
La loro presenza si diffuse talmente tanto da costringere le autorità ecclesiastiche e municipali a emanare scomuniche e decreti contro di loro, ritenendole destabilizzanti per la serenità collettiva: con le loro nenie parlavano non solo del morto ma indirettamente anche delle vicissitudini della sua famiglia, rivangando magari quelle faide intestine sopite da tempo e che spesso sfociavano in nuove liti quando non in omicidi e addirittura in stragi.
Vi riporto un breve esempio di nenia, documentato da Pitrè nel palermitano (Camporeale): Chianciti, patri! Ripitati (‘lagnatevi’) figghi! / Vistitivi di nìuri gramagghiazzi (‘a lutto’)! / Fineru, ohimé, li gioj e li sgattigghi (‘divertimenti’), / E fineru li spranzi e li sullazzi.
Il piagnisteo s’intensificava nel momento in cui la bara veniva portata fuori di casa per il corteo verso il cimitero, come a voler sottolineare la terribile sofferenza del distacco, e ricominciava durante lu cunsulatu, il banchetto di ristoro per i parenti e i partecipanti, e durante le visite di condoglianze, che arrivavano a durare fino a nove giorni, tra finestre sbarrate e semichiuse o nella penombra delle candele.
Si ricordavano con strazio le disgrazie della malattia e le conseguenze inconsolabili della perdita, cui seguiva un’esplosione di urla e pianti per esorcizzare la morte, per creare un contro altare al rischio incombente della follia a causa della sofferenza provata e per rievocare catarticamente la vita.
Oggi la morte è invece un tabù, un argomento di cui non si deve neanche parlare, un evento privato da vivere con freddo distacco nella vita reale ma spesso con platealità in quella virtuale dei social, almeno fin quando non colpisca la propria sfera personale. Prima che la bara del familiare venisse chiusa, si recidevano infine ciocche di capelli o brani di stoffe dagli abiti, inseriti in medaglioni-reliquia da custodire per ricevere protezione e sostegno nei momenti bui della vita.
Pitrè documenta anche un insolito e macabro uso consistente nel far strofinare la pelle soggetta a un’infezione di un bambino sulla gelida mano del morto, che si credeva dotata di potere magico, lenitivo e curativo. Il silenzio più assoluto invece calava alla morte di un bambino, annunciata dall’espressione Gloria e paradisu!
Il bimbo defunto non si piangeva mai, nessuno sapeva cosa fare o dire e nessuno osava parlare. Il bambino era considerato un angelo puro richiamato in Cielo da Dio.
E se durante il corteo funebre di un defunto adulto la banda – protagonista delle celebrazioni sacre – presenziava, per rispetto e conferimento di autorità, senza suonare, per quello del bambino intonava invece brani allegri e gioiosi che festeggiavano la sua rapida ascesa al Paradiso.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
SOCIAL E WEB
La cicogna prende "Il Volo": chi è il tenore (siciliano) che diventa presto papà
131.219 di Redazione -
ITINERARI E LUOGHI
Quando arrivi ti senti in un’altra epoca: in Sicilia si trova la stazione più bella d'Italia
111.570 di Salvo Caruso

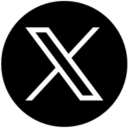



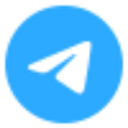


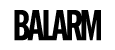





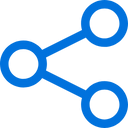
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram