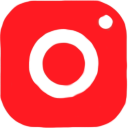STORIA E TRADIZIONI
La schiavitù di Rosa: la giovane palermitana che sapeva leggere solo la parola "libertà"
Rosa stava lì curva sulla schiena piegata dal lavoro e claudicante nella sua andatura segnata. La brezza a ricordarle che sentirsi leggeri non era cosa per tutti, figuriamoci per lei

E quel sangue per le città altro non è che la gente, le loro vite, le tante storie di lotta, di sofferenza, di sogni realizzati e svaniti, di storie così eroiche che finiscono nei libri e di quelle che non hanno nemmeno la forza di uscire dai cortili perché tanto non gliene fregherebbe niente a nessuno.
“E che viene a dire questa brezza?” si chiede Rosa mentre discende il Cassaro alle prime luci del mattino coprendosi il viso stanco e consumato ma pur sempre delicato perché prima che una schiava era pur sempre una donna.
“Che viene a dire? Si crede forse meglio di me?” Poi la brezza lascia Rosa lì, curva sulla schiena piegata dal lavoro e claudicante nella sua andatura segnata, quasi a ricordargli che sentirsi leggeri non è cosa per tutti, figuriamoci per lei.
Una volta sola c’era salita Rosa sul monte Grifone, a tempo di melograni, quel frutto che pareva un gioiello per ricchi ma aveva il colore del sangue dei poveri e del sangue di Palermo: vista da lì sopra pareva un mosaico della Cappella Palatina. Più bella dall’alto che da dentro, perché si vedeva tutto ma si vedeva niente, perché si sentiva niente ma si immaginava tutto; e lei aveva molto più bisogno di immaginarla che di vederla la realtà.
Le abbianniate dei mercanti, le ruote affaticate del carretto, il fruscio dell’acqua del Kemonia, e che era diverso da quello del Papireto, il suo stesso lamento quando le si spaccavano le mani dal freddo e i gabbiani, questa era l’unica musica che Rosa si era potuta permettere, questa era l’unica musica che Rosa conosceva e che si annidava lì: fra le catapecchie dei poveri che avevano orecchie ma non lo spartito e i lussuosi palazzi dei nobili che tenevano lo spartito ma che erano volutamente sordi.
E nonostante lo aveva desiderato per anni, in tutte quelle notti che mordeva la coperta per soffocare il pianto, alla fine, dopo averlo visto con i piedi in avanti, pallido, imbruttito fuori come lo era sempre stato dentro, alla fine di tutto, non era nemmeno riuscita ad odiarlo, meno che mai a gustare il sapore dolce della vendetta. Niente. Mentre discendeva il Cassaro quel 13 agosto non aveva provato niente se non il retrogusto ferroso dell’accettazione.
Tutto se n’era andato così, come la sua giovinezza ormai sprecata, come una cosa che non era sicura fosse esistita veramente, esattamente come la brezza. Eppure Jacopo de Vivaldis, il suo ormai trapassato padrone, aveva la mano pesante che era difficile da dimenticare. Pure nella morte l’aveva beffata, avrebbe dovuta liberarla dalla schiavitù come aveva promesso... in fondo lo aveva fatto, ma a modo suo. In quel testamento, che le aveva pure fatto schifo tenere tra le mani, c’era scritto “Libertà”.
No, non sapeva leggere Rosa, una schiava non sapeva leggere mai perché era meglio cosi; tuttavia, la parola libertà aveva imparato a leggerla o se l’era fatta insegnare nell’evenienza che se quel giorno si fosse presentato lei l’avrebbe riconosciuta subito. La clausola l’aveva fregata. La vita è sempre una questione di clausole, non fosse fosse per il fatto che le radici latine “clausula, clausa, claudere” vogliono significare sempre “chiudere”. Rosa infatti era libera con la morte di Jacopo de Vivaldis, ma solo a patto che c’erano altri quattro anni di schiavitù post mortem da scontare.
“Ha lasciato tutto a figli e parenti”, gli dice la vedova del mercante di origini pisane, “portati stu testamento, se non è un buon ricordo, è quantomeno l’assicurazione che fra quattro anni sarai una donna libera.” Un testamento con data 13 agosto 1400 che le dava la libertà a parole ma la teneva schiava della sua stessa schiavitù. Non li finirà nemmeno quei quattro anni, la moglie del mercante non vuole donne in mezzo ai piedi: le schiave, si sa, vanno cercando rampolli di ricchi mercanti da abbindolare.
Rosa viene venduta a Tommaso Spinola, un altro mercante di Genova che non può finire di ringraziare la vedova per il modico prezzo perché una schiava era proprio quello di cui aveva bisogno. Due anni, tre anni, quattro, a che serve più contare il tempo? Poi non si sa cosa succede anche perché le notizie sono poche. Forse, così mi piace immaginarmelo, un giorno di scirocco Rosa decide di lasciarsi andare nel mare di Sant’Erasmo e scopre che le lacrime sono della stessa sostanza del regno di Nettuno.
Magari Nettuno non c’entra proprio niente e invece c’entra un piccolo prete dei poveri che vede la ragazza tutta sola in quel mare, prima le grida “Ma chiffai? Esci dall’acqua, pazza!” e poi si butta con tutto l’abito talare che alza sopra le caviglie per tuffarsi più velocemente. Se vogliamo pensare che la speranza è esistita sempre, e vi piace questa immagine che vi ho dato, magari ci aggiungiamo pure che il prete le trova il testamento tra la veste, tutto bagnato ma ancora leggibile. E magari e proprio lui a darle coraggio. Perdonate le divagazioni che ho fatto per allungare il sugo, o forse perché mi piace sognare.
Ad ogni modo, per tornare alle notizie certe, quello che sappiamo è che Rosa si prenderà veramente di coraggio, si rivolgerà alla Curia Arcivescovile, e proprio grazie a quel testamento, a quel foglio imbrattato di vergogna firmato Jacopo de Vivaldis, che al processo le verrà data ragione e le verrà restituita la libertà.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
STORIA E TRADIZIONI
In Sicilia solo un'altra parola vale quanto questa: perché un "suca" è per sempre
96.542 di Alessandro Panno

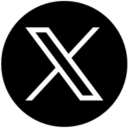



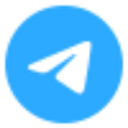


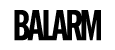

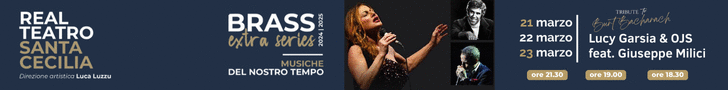




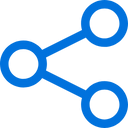
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram