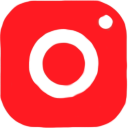STORIA E TRADIZIONI
La Donaudi, i (tanti) bar e l'S7: quel "viale" di Palermo nascosto dal caos della città
Un ecosistema imperfetto, perfettamente connesso con una vita che scorreva lenta: tutti si conoscevano e tutti si volevano un gran bene

Viale Santissima Mediatrice a Palermo
Ci sono luoghi, posti, quartieri che si legano indissolubilmente a delle persone, anche quando esse se ne vanno per sempre.
In realtà non vanno da nessuna parte, rimangono lì, impigliate tra le maglie dei ricordi più belli, sovrapponendosi a un'infanzia vissuta tra strade trasudanti di vita quotidiana, che pure diventa storia.
Una piccola grande storia, d'una gran persona perbene, che ha vissuto in un piccolissimo pezzo di mondo, lasciandovi un'impronta da gigante.
Suonava la campanella, erano le 8, eravamo tutti in fila pronti a entrare a scuola. Scuola elementare Donaudi (succursale dell'Arculeo), quella era la scuola del viale. Noi lo chiamavamo così, il nostro quartiere.
Per gli altri era via Maria Santissima Mediatrice, nome della chiesa che campeggiava, e campeggia, sull'omonima lunghissima strada: una strada a due sensi, divisa da un lungo marciapiede alberato, maculato di chewing-gum e solchi senza età, adornato da panchine marmoree su cui sedevano generazioni di sogni e rimpianti; e cabine telefoniche qua e là, su cui street writers ante litteram sciupavano fiumi di Uniposca.
Ai due lati di quella lunga via alberata, ancora marciapiedi grigiognoli, dominati da negozi storici, di cui non v'é più traccia, e storiche putìe che hanno resistito alla calata dei centri commerciali e ancora resistono alla massificazione consumistica Amazon style.
Le macellerie, che si contendevano la clientela al ritmo serrato delle lame che affondavano su carne di prima scelta.
Il panificio Sutera, dove andavamo a comprare le pizzette col salame o le treccine calde calde. Il supermercato S7, fratello minore della lontana "Standa" di corso Calatafimi.
Le salumerie dove: «Sono due etti ... che fa, li lascio?» non era una barzelletta.era condivisione, reciprocità, complicità; era l'idioma d'un commercio fatto di sguardi e parole (anziché click e cartelli espositivi), con cui il signor a Napoli o i fratelli D'amico non vendevano e basta, comunicavano, empatizzavano, fraternizzavano.
C'era Davide "l'uccellaio", nciuria cacofonica che gli derivava dallo splendido negozietto di mangimi, dove c'imbucavamo per giochicchiare col mitico pappagallo Loreto o per ammirare qualche esemplare animalesco.
La grande pescheria e la piccola lambretta all'angolo, da cui, pare, si abbanniasse più forte e si vendesse più pesce. I quattro fruttivendoli, tra i quali quello di «Nicola Casamento si pigghió», urlava il signor Lombardo, l'arriffatore.
E poi i bar, quanti bar! Quante charlotte al cioccolato! Quanti bicchieri d'acqua dal borbottante «Giacomino Premier»!
E poi la merceria e le gioiellerie, gli articoli sportivi e quelli da regalo, gli abbigliamenti a buon mercato, il calzolaio di via Michelangelo Falvetto (viuzza alle spalle del viale), di cui sento ancora l'odor di cuoio. L'immancabile corniciaio e il gettonato fotografo, oracolo mai puntuale del rullino da sviluppare.
Le parruccherie delle belle signore da sbirciare con la scusa di chiamare la mamma; e i capelli tagliati alla buona da Andrea "il baffone", ché poi giravi largo per non farti vedere dal rivale, "Pinuzzu u vaibbieri", almeno fino a quando i segni della tosatura non lasciavano il posto a una chioma nuovamente scarmigliata.
C'era "Il tabacchino delle scale", detto così per via di una scalinata che dovevi scendere per entrarci e giocarci la schedina il sabato pomeriggio. L'edicola che si stagliava com'un tempio profano di figurine e Topolino dirimpetto alla chiesa.
E in fondo al viale, dove gli ultimi alberi segnavano l'obbligatorio giro di boa delle prime pedalate in bici, sorgeva l'avamposto di confine tra il nostro microcosmo e il marasma cittadino.
Affossato su una specie di piano cantinato, ricavato sotto il livello della strada, il negozietto più iconico e ibrido di quel nostro mondo e del mondo intero, U' Scaipparicchiu. Non chiedetemi perché lo chiamavamo così e non chiedetemi cosa vendevano in quei pochi ammatassati metri quadri di semibuio e chincaglierie, so soltanto che quando ci serviva qualcosa, che non trovavamo altrove, ci recavamo lì e cavoli se la trovavamo!
Quello era il viale, il cuore pulsante di Villa Tasca. E sì, lì la quotidianità era in qualche modo scandita dai negozi, perché al loro interno, in fin dei conti, si consumavano respiri e sospiri, si articolavano pensieri, parole, opere e opinioni, si riempivano sacchetti e ore altrimenti "vuote come uova di cioccolato".
E comunque un microcosmo per esistere, deve avere tutto al suo interno e, grazie a quelle botteghe, non ci mancava proprio niente.
Il viale era una specie di centro commerciale a cielo aperto (e a cuore ancor più aperto), un parco- avventura a tutti gli effetti (c'era sempre un muro da scavalcare, un recinto su cui saltare, qualche buco su cui infilarsi), un mercato del contadino permanente, il mercatino il giovedì e un laboratorio di vita e sport senza rette da pagare.
Solo il tributo di una qualche sgridata per il troppo tempo speso su quelle strade, tra quegli anfratti, dentro quei negozi o su quell'innumerevoli muretti.
Solo un obolo alla Madonna Mediatrice che accompagnasse le nostre imprese, sportive e non, tutte compiute dentro il perimetro rassicurante del centro ricreativo parrocchiale. "Il campo della chiesa" (noi lo chiamavamo così), polveroso e senza reti, che per le grandi occasioni segnavamo con del gesso in polvere, che lasciavamo cadere dalle mani fatte a cucchiaio, generando linee sghimbesce che per noi erano rette più rette degli avveniristici binari giapponesi.
L'arioso salone col tavolo da ping-pong e le sciarre per chi dovesse giocare; le stanze smaltate della danza, dove Marinella insegnò, forse, i primi rudimenti al figlio, Mattia Tuzzolino (oggi affermato ballerino); le aule fresche del catechismo, mai preso troppo sul serio.
Il campo di bocce, regno incontrastato degli anziani, ma pure estemporanea oasi di ristoro per noi che, assetati dopo le terza/quarta ora di pallone, ci affidavamo a un tubo, da cui sgorgava acqua che non era Lete e non era oligominerale, ma che a nessuno ha mai fatto altro effetto se non quello di dissetarci e predisporci ad altre ore di pallone.
E poi il teatro, sul cui palcoscenico andava in scena lo slancio della periferia più genuina, però nulla poteva iniziare senza il viatico del parroco, un padre nostro e un Ave Maria.
Il viale era tutto questo. Una specie d'ecosistema imperfetto, perfettamente connesso con una vita che scorreva lenta e zuccherosa: tutti si conoscevano, tutti sparlavano di tutti, tutti si volevano un gran bene.
Pallone e politica erano le uniche metà campo su cui ci si schierava, nei weekend e durante le campagne elettorali.
Non mancavano le rivalità, certo, per esempio, tra due commercianti oppure tra le due-tre aspiranti "Miss Viale" (un concorso vero e proprio non c'è mai stato, ma la giuria ru passiu non mancava mai ed era attentissima); per il resto, quel microcosmo trasudava di umanità e armonia.
Un microcosmo chiuso tra palazzi verdognoli, che nelle mattine assolate s’ingiallivano, maculandosi di ombre.
E dai quali si dipanava un dedalo di viuzze interne e slarghi e box misteriosi a cui accedevamo da cancelli mai troppo alti e mai troppo chiusi per le nostre adolescenziali scorribande.
E piazzole pavimentate a scacchi rossi e bianchi, sistematicamente trasformate in campi da calcio (con buona pace del signor Tartaro e dei sui balconi dal frontalino in vetro), quando non eravamo abbastanza numerosi per giocare al campo della chiesa (sempre quello) o quand'esso c'era interdetto perché don Paolo, il sagrestano, non voleva: «C'è a missa, sdisanurati!».
Era il viale. Ovattato, quasi nascosto al mondo, al riparo dal caos della città, che pure scorreva lì a un tiro di schioppo.
In quel microcosmo crescevamo e imparavamo. Imparavamo la strada, per fortuna mai troppo strada per il gusto dei nostri genitori. Imparavamo a studiare. E io ho imparato a scrivere storie come questa.
Che adesso torna al punto di partenza, alla scuola elementare Donaudi. Ricordo tutto di quella scuola. La mia maestra dal cognome improbabile (Partexano, sic!) e dalle mani lunghe, che oggi partirebbero denunce e filippiche in chat, ma che allora erano innocui scappellotti da cui nessuno ha mai subito danni permanenti, semmai un permanente senso di disciplina.
I bidelli, sentinelle riguardose di discoli scapestrati, ma non bulli, quello mai; il grembiule blu e la cartella; e le ricreazioni, scandite dagli avidi morsi alla merendina, che la mamma si sforzava di variare, solo che poi si finiva sempre con l'optare per la girella o per la mafaldina della sera prima con la Nutella.
E ricordo lui, il professore Manzella, il direttore. Ne serbo un ricordo vivido, perché, quando entrava in classe e noi scattavamo in piedi, per me era un misto di timore e riverenza.
Ma era giusto un attimo, il suo sguardo severo subito si scioglieva nella bontà d'animo d'un uomo perbene. Torreggiava, senza sovrastarti. Incuteva reverenza, non paura. Era autorevole, non autoritario.
Era il direttore, una di quelle figure che ti porti dietro per tutta la vita, che inconsapevolmente conservi nel cantuccio più recondito della tua memoria e che altrettanto inconsapevolmente ti accompagna per sempre, con l'esempio silenzioso ch'egli era.
Una di quelle figure talmente riconosciute dalla comunità che ne diventano simboli. Lui, Filippo Errera e la squadra della Mediatrice, padre Sapienza e le sue amorevoli omelie. Erano i totem in carne e ossa di quel quartiere. Un po' come i negozi di cui sopra, solo che loro non vendevano nulla, donavano. Donavano tanto.
Il professore Calogero Manzella se n'è andato, qualche giorno fa ha lasciato questo mondo e lasciato in molti di noi un'impronta indelebile di garbo, eleganza e spessore umano. Inutile dirgli di riposare in pace, lui la pace ce l'aveva dentro.
Post scriptum: avrò dimenticato un'infinità di nomi, cose e città (a proposito d'infanzia), avrò probabilmente commesso inesattezze ed errori di narrazione. E sì, mi sarò dilungato oltremodo, ma tant'è. Queste righe non hanno la presunzione d'essere un racconto, bensì un viaggio, personalissimo e lungo, sì.
Per questo mi sono volutamente documentato attingendo al solo archivio della mia esistenza. In fondo, è del mio viale che scrivo. Ed è proprio questa la magia di certi luoghi: non sono mai univoci, bensì unici.
In realtà non vanno da nessuna parte, rimangono lì, impigliate tra le maglie dei ricordi più belli, sovrapponendosi a un'infanzia vissuta tra strade trasudanti di vita quotidiana, che pure diventa storia.
Una piccola grande storia, d'una gran persona perbene, che ha vissuto in un piccolissimo pezzo di mondo, lasciandovi un'impronta da gigante.
Suonava la campanella, erano le 8, eravamo tutti in fila pronti a entrare a scuola. Scuola elementare Donaudi (succursale dell'Arculeo), quella era la scuola del viale. Noi lo chiamavamo così, il nostro quartiere.
Per gli altri era via Maria Santissima Mediatrice, nome della chiesa che campeggiava, e campeggia, sull'omonima lunghissima strada: una strada a due sensi, divisa da un lungo marciapiede alberato, maculato di chewing-gum e solchi senza età, adornato da panchine marmoree su cui sedevano generazioni di sogni e rimpianti; e cabine telefoniche qua e là, su cui street writers ante litteram sciupavano fiumi di Uniposca.
Ai due lati di quella lunga via alberata, ancora marciapiedi grigiognoli, dominati da negozi storici, di cui non v'é più traccia, e storiche putìe che hanno resistito alla calata dei centri commerciali e ancora resistono alla massificazione consumistica Amazon style.
Le macellerie, che si contendevano la clientela al ritmo serrato delle lame che affondavano su carne di prima scelta.
Il panificio Sutera, dove andavamo a comprare le pizzette col salame o le treccine calde calde. Il supermercato S7, fratello minore della lontana "Standa" di corso Calatafimi.
Le salumerie dove: «Sono due etti ... che fa, li lascio?» non era una barzelletta.era condivisione, reciprocità, complicità; era l'idioma d'un commercio fatto di sguardi e parole (anziché click e cartelli espositivi), con cui il signor a Napoli o i fratelli D'amico non vendevano e basta, comunicavano, empatizzavano, fraternizzavano.
C'era Davide "l'uccellaio", nciuria cacofonica che gli derivava dallo splendido negozietto di mangimi, dove c'imbucavamo per giochicchiare col mitico pappagallo Loreto o per ammirare qualche esemplare animalesco.
La grande pescheria e la piccola lambretta all'angolo, da cui, pare, si abbanniasse più forte e si vendesse più pesce. I quattro fruttivendoli, tra i quali quello di «Nicola Casamento si pigghió», urlava il signor Lombardo, l'arriffatore.
E poi i bar, quanti bar! Quante charlotte al cioccolato! Quanti bicchieri d'acqua dal borbottante «Giacomino Premier»!
E poi la merceria e le gioiellerie, gli articoli sportivi e quelli da regalo, gli abbigliamenti a buon mercato, il calzolaio di via Michelangelo Falvetto (viuzza alle spalle del viale), di cui sento ancora l'odor di cuoio. L'immancabile corniciaio e il gettonato fotografo, oracolo mai puntuale del rullino da sviluppare.
Le parruccherie delle belle signore da sbirciare con la scusa di chiamare la mamma; e i capelli tagliati alla buona da Andrea "il baffone", ché poi giravi largo per non farti vedere dal rivale, "Pinuzzu u vaibbieri", almeno fino a quando i segni della tosatura non lasciavano il posto a una chioma nuovamente scarmigliata.
C'era "Il tabacchino delle scale", detto così per via di una scalinata che dovevi scendere per entrarci e giocarci la schedina il sabato pomeriggio. L'edicola che si stagliava com'un tempio profano di figurine e Topolino dirimpetto alla chiesa.
E in fondo al viale, dove gli ultimi alberi segnavano l'obbligatorio giro di boa delle prime pedalate in bici, sorgeva l'avamposto di confine tra il nostro microcosmo e il marasma cittadino.
Affossato su una specie di piano cantinato, ricavato sotto il livello della strada, il negozietto più iconico e ibrido di quel nostro mondo e del mondo intero, U' Scaipparicchiu. Non chiedetemi perché lo chiamavamo così e non chiedetemi cosa vendevano in quei pochi ammatassati metri quadri di semibuio e chincaglierie, so soltanto che quando ci serviva qualcosa, che non trovavamo altrove, ci recavamo lì e cavoli se la trovavamo!
Quello era il viale, il cuore pulsante di Villa Tasca. E sì, lì la quotidianità era in qualche modo scandita dai negozi, perché al loro interno, in fin dei conti, si consumavano respiri e sospiri, si articolavano pensieri, parole, opere e opinioni, si riempivano sacchetti e ore altrimenti "vuote come uova di cioccolato".
E comunque un microcosmo per esistere, deve avere tutto al suo interno e, grazie a quelle botteghe, non ci mancava proprio niente.
Il viale era una specie di centro commerciale a cielo aperto (e a cuore ancor più aperto), un parco- avventura a tutti gli effetti (c'era sempre un muro da scavalcare, un recinto su cui saltare, qualche buco su cui infilarsi), un mercato del contadino permanente, il mercatino il giovedì e un laboratorio di vita e sport senza rette da pagare.
Solo il tributo di una qualche sgridata per il troppo tempo speso su quelle strade, tra quegli anfratti, dentro quei negozi o su quell'innumerevoli muretti.
Solo un obolo alla Madonna Mediatrice che accompagnasse le nostre imprese, sportive e non, tutte compiute dentro il perimetro rassicurante del centro ricreativo parrocchiale. "Il campo della chiesa" (noi lo chiamavamo così), polveroso e senza reti, che per le grandi occasioni segnavamo con del gesso in polvere, che lasciavamo cadere dalle mani fatte a cucchiaio, generando linee sghimbesce che per noi erano rette più rette degli avveniristici binari giapponesi.
L'arioso salone col tavolo da ping-pong e le sciarre per chi dovesse giocare; le stanze smaltate della danza, dove Marinella insegnò, forse, i primi rudimenti al figlio, Mattia Tuzzolino (oggi affermato ballerino); le aule fresche del catechismo, mai preso troppo sul serio.
Il campo di bocce, regno incontrastato degli anziani, ma pure estemporanea oasi di ristoro per noi che, assetati dopo le terza/quarta ora di pallone, ci affidavamo a un tubo, da cui sgorgava acqua che non era Lete e non era oligominerale, ma che a nessuno ha mai fatto altro effetto se non quello di dissetarci e predisporci ad altre ore di pallone.
E poi il teatro, sul cui palcoscenico andava in scena lo slancio della periferia più genuina, però nulla poteva iniziare senza il viatico del parroco, un padre nostro e un Ave Maria.
Il viale era tutto questo. Una specie d'ecosistema imperfetto, perfettamente connesso con una vita che scorreva lenta e zuccherosa: tutti si conoscevano, tutti sparlavano di tutti, tutti si volevano un gran bene.
Pallone e politica erano le uniche metà campo su cui ci si schierava, nei weekend e durante le campagne elettorali.
Non mancavano le rivalità, certo, per esempio, tra due commercianti oppure tra le due-tre aspiranti "Miss Viale" (un concorso vero e proprio non c'è mai stato, ma la giuria ru passiu non mancava mai ed era attentissima); per il resto, quel microcosmo trasudava di umanità e armonia.
Un microcosmo chiuso tra palazzi verdognoli, che nelle mattine assolate s’ingiallivano, maculandosi di ombre.
E dai quali si dipanava un dedalo di viuzze interne e slarghi e box misteriosi a cui accedevamo da cancelli mai troppo alti e mai troppo chiusi per le nostre adolescenziali scorribande.
E piazzole pavimentate a scacchi rossi e bianchi, sistematicamente trasformate in campi da calcio (con buona pace del signor Tartaro e dei sui balconi dal frontalino in vetro), quando non eravamo abbastanza numerosi per giocare al campo della chiesa (sempre quello) o quand'esso c'era interdetto perché don Paolo, il sagrestano, non voleva: «C'è a missa, sdisanurati!».
Era il viale. Ovattato, quasi nascosto al mondo, al riparo dal caos della città, che pure scorreva lì a un tiro di schioppo.
In quel microcosmo crescevamo e imparavamo. Imparavamo la strada, per fortuna mai troppo strada per il gusto dei nostri genitori. Imparavamo a studiare. E io ho imparato a scrivere storie come questa.
Che adesso torna al punto di partenza, alla scuola elementare Donaudi. Ricordo tutto di quella scuola. La mia maestra dal cognome improbabile (Partexano, sic!) e dalle mani lunghe, che oggi partirebbero denunce e filippiche in chat, ma che allora erano innocui scappellotti da cui nessuno ha mai subito danni permanenti, semmai un permanente senso di disciplina.
I bidelli, sentinelle riguardose di discoli scapestrati, ma non bulli, quello mai; il grembiule blu e la cartella; e le ricreazioni, scandite dagli avidi morsi alla merendina, che la mamma si sforzava di variare, solo che poi si finiva sempre con l'optare per la girella o per la mafaldina della sera prima con la Nutella.
E ricordo lui, il professore Manzella, il direttore. Ne serbo un ricordo vivido, perché, quando entrava in classe e noi scattavamo in piedi, per me era un misto di timore e riverenza.
Ma era giusto un attimo, il suo sguardo severo subito si scioglieva nella bontà d'animo d'un uomo perbene. Torreggiava, senza sovrastarti. Incuteva reverenza, non paura. Era autorevole, non autoritario.
Era il direttore, una di quelle figure che ti porti dietro per tutta la vita, che inconsapevolmente conservi nel cantuccio più recondito della tua memoria e che altrettanto inconsapevolmente ti accompagna per sempre, con l'esempio silenzioso ch'egli era.
Una di quelle figure talmente riconosciute dalla comunità che ne diventano simboli. Lui, Filippo Errera e la squadra della Mediatrice, padre Sapienza e le sue amorevoli omelie. Erano i totem in carne e ossa di quel quartiere. Un po' come i negozi di cui sopra, solo che loro non vendevano nulla, donavano. Donavano tanto.
Il professore Calogero Manzella se n'è andato, qualche giorno fa ha lasciato questo mondo e lasciato in molti di noi un'impronta indelebile di garbo, eleganza e spessore umano. Inutile dirgli di riposare in pace, lui la pace ce l'aveva dentro.
Post scriptum: avrò dimenticato un'infinità di nomi, cose e città (a proposito d'infanzia), avrò probabilmente commesso inesattezze ed errori di narrazione. E sì, mi sarò dilungato oltremodo, ma tant'è. Queste righe non hanno la presunzione d'essere un racconto, bensì un viaggio, personalissimo e lungo, sì.
Per questo mi sono volutamente documentato attingendo al solo archivio della mia esistenza. In fondo, è del mio viale che scrivo. Ed è proprio questa la magia di certi luoghi: non sono mai univoci, bensì unici.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
ARTE E ARCHITETTURA
Il nome è innocuo ma ha un passato oscuro: il Mercato di Palermo dove trovi tesori
71.067 di Susanna La Valle

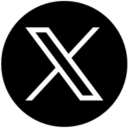



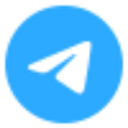


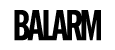

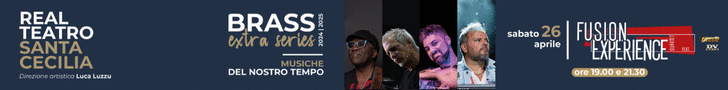



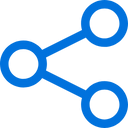
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram