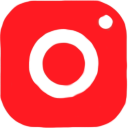Il Covid negli occhi di una rianimatrice del Civico di Palermo: "Non ci si abitua mai"
Maria Teresa è un’anestesista rianimatrice di trentasette anni che lavora da sei anni nel reparto di Seconda Rianimazione dell’Arnas Civico. Ecco come è cambiata la sua vita

Maria Teresa Strano
È una sera di novembre come la altre nel reparto di Seconda Rianimazione dell’Arnas Civico di Palermo: il passaggio di consegne fra un turno e l’altro, il silenzio interrotto dai monitor e dagli allarmi, qualche battuta fra colleghi, il saluto di rito ai degenti.
Pochi metri più in là, però, si respira un’aria completamente diversa. Una situazione «devastante». In pronto soccorso ci sono 45 pazienti Covid, molti dei quali assistiti da ventilazione artificiale: «Sembra quasi di essere in un reparto di terapia semi-intensiva», con i medici e gli infermieri che corrono da un paziente all’altro senza sosta e un ritmo che si fa sempre più incessante.
Non ce la possono fare da soli e, senza indugi, si rivolgono ai colleghi della Seconda Rianimazione. «Presto, un ragazzo!». Sono queste le parole che risuonano nella testa di Maria Teresa Strano da quel novembre ormai lontano. Parole che le hanno cambiato la vita per sempre, perché da quel giorno niente è stato più come prima.
Maria Teresa è un’anestesista rianimatrice di trentasette anni che lavora da sei anni nel reparto diretto dal dottor Vincenzo Mazzarese. Un reparto dove, per definizione, «si lavora ogni giorno fianco a fianco con la morte», dove si dovrebbe essere abituati alla malattia, alla sofferenza, alla disperazione.
La verità, però, è che non ci si abitua mai. Perché dietro ogni dolore c’è una biografia da ascoltare, una persona di cui prendersi cura e una famiglia da consolare. Una storia ogni volta unica che diventa propria e che, in un modo o nell’altro, non ti lascia più.
Quando poi quella storia è la vita (o la morte) di un tuo coetaneo, di un giovane con ancora tutti i suoi desideri davanti, è ancora più dura. Correre in pronto soccorso, vestirsi per la prima volta non lasciando neanche uno spiraglio scoperto, trovarsi di fronte a una patologia sconosciuta che ti fa sentire impotente: un’emozione nuova che oggi «purtroppo è routine» per Maria Teresa, ma che quella sera di novembre le ha «aperto un mondo».
«Anche se in linea d'aria la Seconda Rianimazione si trova a 50 metri dal reparto Covid, fin quando non lo vedi è diverso», non ti rendi conto per davvero come è cambiato tutto da un momento all’altro. Come perfino il rapporto con la morte non è più lo stesso.
Perché il Covid porta alla distanza, alla «solitudine», all’esclusione di quel mondo che fino a pochi istanti prima era parte di te. Non solo per chi è ricoverato, ma anche per chi a casa attende notizie, con l’ansia perenne di sentire squillare il telefono.
«Si è passati dalle rianimazioni aperte, con un contatto diretto con i familiari nel percorso di cura del parente, alle comunicazioni telefoniche con parenti che non conoscono neanche i nostri visi - racconta Maria Teresa con una voce che fa intendere quanto sia doloroso anche per loro -. Ci assistono degli psicologi nel dare le notizie giornaliere, perché a livello umano è un’esperienza toccante anche per noi. Viviamo per questo, per il rapporto con la famiglia, come è mancato ai parenti è mancato anche a noi. Era la nostra forza».
La forza che solo chi sta dietro quella porta, che divide la rianimazione dal resto, può dare. Perché mentre fai di tutto per far rimanere qualcuno in vita, sai che lì fuori c’è qualcun altro che si è affidato totalmente, e ineluttabilmente, a te.
Sai che sei «il filo» che unisce quei due mondi divisi dalla malattia. In genere nei viali e fuori dal reparto, chi ha avuto qualcuno ricoverato lo sa, «ci si riunisce per ricevere notizie tutti insieme, con gli amici che danno supporto ai familiari. Tutto questo purtroppo non c’è più. Anche perché spesso pure i parenti sono positivi e in lacrime, dall’altra parte della cornetta, chiedono “Che cosa devo fare, dottoressa? Devo contattare l’agenzia funebre?”».
Morire lontani dai propri affetti, vederli un’ultima volta tramite lo schermo di un tablet, in videochiamata, riconoscere i medici da quelle voci che ormai sono famiglia, capire che probabilmente non ce la farai. Sì, è questo il Covid: «una malattia subdola che ti fa rimanere lucido fino alla fine».
E Maria Teresa lo sa bene. Troppe volte, infatti, si ritrova a leggere «valori incompatibili con la vita ma con una persona lucida davanti», con una persona che magari continua a raccontare dei suoi figli, dei suoi nipoti o dei suoi genitori e alla quale deve mentire: «Devo intubarla, la sveglierò quanto prima, sapendo però che quel "quanto prima" probabilmente non ci sarà mai».
Stringe il cuore ad ascoltare i racconti di una rianimatrice che convive ogni giorno con un peso del genere: sapere che, mentre ci si lamenta di non poter fare questo o quello, c’è chi come lei ha deciso di trasferirsi di reparto e di lottare per tutti noi, sacrificando parte della sua vita.
«Te la senti?», le ha chiesto il primario a novembre con la dolcezza che solo «una guida che si prende cura della propria squadra» può avere, sapendo che Maria Teresa, oltre a essere un medico, è anche madre di una bimba piccola.
A quella domanda ha risposto di sì, senza esitare neanche per un momento, nonostante la sua quotidianità sia ormai stravolta: «Soprattutto all’inizio non ho visto i miei genitori neanche con la mascherina, quando alcuni colleghi si sono scoperti positivi sono tornata a casa con la paura e per alcune notti ho dormito chiusa nella stanza senza vedere mia figlia. Ogni volta che torno da un turno mi spoglio in un’anticamera allestita all’ingresso, faccio subito la doccia e solo dopo abbraccio la mia bimba».
Fortunatamente non è sola, ha accanto un marito che la sostiene e dei colleghi con cui il legame è sempre più intenso. Perché nelle tragedie c’è anche un risvolto positivo: «Non ci sono più baci, abbracci, strette di mano, così come non c’è più la pausa caffè o la distrazione, ma i rapporti umani sono molto più profondi.
L’aiuto prezioso degli specializzandi e la collaborazione fra tutto il personale sanitario dello stesso reparto, ma anche di altri reparti o perfino di altri ospedali, è davvero incredibile. Ci siamo riscoperti perché sappiamo che uniti possiamo vincere».
Oggi Maria Teresa è più serena, convinta che il vaccino farà la sua parte nella lotta a un virus che ha già tolto la vita a troppe persone, «anche giovani e senza patologie pregresse».
E a chi, all’inizio della campagna di vaccinazione ha parlato di privilegio, risponde ferita che per lei l’unico privilegio è fare il lavoro che ama: «Hanno somministrato il vaccino per primi a noi perché siamo in guerra e il vaccino è un’arma e l’arma la devi dare a chi sta combattendo sul campo di battaglia, non per salvare noi, ma per salvare tutti».
Una battaglia contro un nemico che non vede l’ora di sconfiggere, per tornare dai suoi pazienti non Covid e riabbracciare i suoi familiari. Per questo ci raccomanda di stare attenti, di ridurre i contatti con gli altri e di usare le mascherine correttamente perché «l’unico modo per sopravvivere non è il ricovero in ospedale, ma non prendersi il virus».
Ricordiamocelo sempre.
Pochi metri più in là, però, si respira un’aria completamente diversa. Una situazione «devastante». In pronto soccorso ci sono 45 pazienti Covid, molti dei quali assistiti da ventilazione artificiale: «Sembra quasi di essere in un reparto di terapia semi-intensiva», con i medici e gli infermieri che corrono da un paziente all’altro senza sosta e un ritmo che si fa sempre più incessante.
Non ce la possono fare da soli e, senza indugi, si rivolgono ai colleghi della Seconda Rianimazione. «Presto, un ragazzo!». Sono queste le parole che risuonano nella testa di Maria Teresa Strano da quel novembre ormai lontano. Parole che le hanno cambiato la vita per sempre, perché da quel giorno niente è stato più come prima.
Maria Teresa è un’anestesista rianimatrice di trentasette anni che lavora da sei anni nel reparto diretto dal dottor Vincenzo Mazzarese. Un reparto dove, per definizione, «si lavora ogni giorno fianco a fianco con la morte», dove si dovrebbe essere abituati alla malattia, alla sofferenza, alla disperazione.
La verità, però, è che non ci si abitua mai. Perché dietro ogni dolore c’è una biografia da ascoltare, una persona di cui prendersi cura e una famiglia da consolare. Una storia ogni volta unica che diventa propria e che, in un modo o nell’altro, non ti lascia più.
Quando poi quella storia è la vita (o la morte) di un tuo coetaneo, di un giovane con ancora tutti i suoi desideri davanti, è ancora più dura. Correre in pronto soccorso, vestirsi per la prima volta non lasciando neanche uno spiraglio scoperto, trovarsi di fronte a una patologia sconosciuta che ti fa sentire impotente: un’emozione nuova che oggi «purtroppo è routine» per Maria Teresa, ma che quella sera di novembre le ha «aperto un mondo».
«Anche se in linea d'aria la Seconda Rianimazione si trova a 50 metri dal reparto Covid, fin quando non lo vedi è diverso», non ti rendi conto per davvero come è cambiato tutto da un momento all’altro. Come perfino il rapporto con la morte non è più lo stesso.
Perché il Covid porta alla distanza, alla «solitudine», all’esclusione di quel mondo che fino a pochi istanti prima era parte di te. Non solo per chi è ricoverato, ma anche per chi a casa attende notizie, con l’ansia perenne di sentire squillare il telefono.
«Si è passati dalle rianimazioni aperte, con un contatto diretto con i familiari nel percorso di cura del parente, alle comunicazioni telefoniche con parenti che non conoscono neanche i nostri visi - racconta Maria Teresa con una voce che fa intendere quanto sia doloroso anche per loro -. Ci assistono degli psicologi nel dare le notizie giornaliere, perché a livello umano è un’esperienza toccante anche per noi. Viviamo per questo, per il rapporto con la famiglia, come è mancato ai parenti è mancato anche a noi. Era la nostra forza».
La forza che solo chi sta dietro quella porta, che divide la rianimazione dal resto, può dare. Perché mentre fai di tutto per far rimanere qualcuno in vita, sai che lì fuori c’è qualcun altro che si è affidato totalmente, e ineluttabilmente, a te.
Sai che sei «il filo» che unisce quei due mondi divisi dalla malattia. In genere nei viali e fuori dal reparto, chi ha avuto qualcuno ricoverato lo sa, «ci si riunisce per ricevere notizie tutti insieme, con gli amici che danno supporto ai familiari. Tutto questo purtroppo non c’è più. Anche perché spesso pure i parenti sono positivi e in lacrime, dall’altra parte della cornetta, chiedono “Che cosa devo fare, dottoressa? Devo contattare l’agenzia funebre?”».
Morire lontani dai propri affetti, vederli un’ultima volta tramite lo schermo di un tablet, in videochiamata, riconoscere i medici da quelle voci che ormai sono famiglia, capire che probabilmente non ce la farai. Sì, è questo il Covid: «una malattia subdola che ti fa rimanere lucido fino alla fine».
E Maria Teresa lo sa bene. Troppe volte, infatti, si ritrova a leggere «valori incompatibili con la vita ma con una persona lucida davanti», con una persona che magari continua a raccontare dei suoi figli, dei suoi nipoti o dei suoi genitori e alla quale deve mentire: «Devo intubarla, la sveglierò quanto prima, sapendo però che quel "quanto prima" probabilmente non ci sarà mai».
Stringe il cuore ad ascoltare i racconti di una rianimatrice che convive ogni giorno con un peso del genere: sapere che, mentre ci si lamenta di non poter fare questo o quello, c’è chi come lei ha deciso di trasferirsi di reparto e di lottare per tutti noi, sacrificando parte della sua vita.
«Te la senti?», le ha chiesto il primario a novembre con la dolcezza che solo «una guida che si prende cura della propria squadra» può avere, sapendo che Maria Teresa, oltre a essere un medico, è anche madre di una bimba piccola.
A quella domanda ha risposto di sì, senza esitare neanche per un momento, nonostante la sua quotidianità sia ormai stravolta: «Soprattutto all’inizio non ho visto i miei genitori neanche con la mascherina, quando alcuni colleghi si sono scoperti positivi sono tornata a casa con la paura e per alcune notti ho dormito chiusa nella stanza senza vedere mia figlia. Ogni volta che torno da un turno mi spoglio in un’anticamera allestita all’ingresso, faccio subito la doccia e solo dopo abbraccio la mia bimba».
Fortunatamente non è sola, ha accanto un marito che la sostiene e dei colleghi con cui il legame è sempre più intenso. Perché nelle tragedie c’è anche un risvolto positivo: «Non ci sono più baci, abbracci, strette di mano, così come non c’è più la pausa caffè o la distrazione, ma i rapporti umani sono molto più profondi.
L’aiuto prezioso degli specializzandi e la collaborazione fra tutto il personale sanitario dello stesso reparto, ma anche di altri reparti o perfino di altri ospedali, è davvero incredibile. Ci siamo riscoperti perché sappiamo che uniti possiamo vincere».
Oggi Maria Teresa è più serena, convinta che il vaccino farà la sua parte nella lotta a un virus che ha già tolto la vita a troppe persone, «anche giovani e senza patologie pregresse».
E a chi, all’inizio della campagna di vaccinazione ha parlato di privilegio, risponde ferita che per lei l’unico privilegio è fare il lavoro che ama: «Hanno somministrato il vaccino per primi a noi perché siamo in guerra e il vaccino è un’arma e l’arma la devi dare a chi sta combattendo sul campo di battaglia, non per salvare noi, ma per salvare tutti».
Una battaglia contro un nemico che non vede l’ora di sconfiggere, per tornare dai suoi pazienti non Covid e riabbracciare i suoi familiari. Per questo ci raccomanda di stare attenti, di ridurre i contatti con gli altri e di usare le mascherine correttamente perché «l’unico modo per sopravvivere non è il ricovero in ospedale, ma non prendersi il virus».
Ricordiamocelo sempre.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
STORIA E TRADIZIONI
Stella, moglie del "Principone": a chi si ispira la principessa di Salina del Gattopardo
191.773 di Susanna La Valle -
CINEMA E TV
È palermitana e la vedi ancora su Rai 1: chi è la nuova attrice in "Mina Settembre"
101.585 di Redazione -
STORIA E TRADIZIONI
Avevano l'oro bianco, Franca Florio le rifiutò: donne e "matri" (senza nome) in Sicilia
83.309 di Susanna La Valle

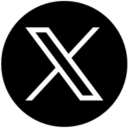



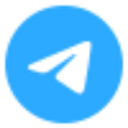


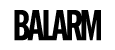






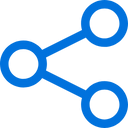
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram