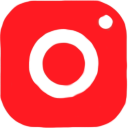Bellu, giornalismo d'inchiesta tra testimonianza e narrazione
Nel 2004 una sua inchiesta giornalistica ha riportato alla luce un tragico avvenimento, l'affondamento di una nave di clandestini - al largo delle coste siciliane - la notte del Natale ‘96. Un fatto messo in dubbio, perché taciuto dalle autorità, e passato sotto silenzio stampa. Da quella drammatica vicenda, quasi trecento le vittime, è nata una amicizia, tra Giovanni Maria Bellu, giornalista de "La Repubblica", e Anpalagan Ganeshu, un ragazzo Tamil, vittima sconosciuta in quel disastro. Da questa storia un libro, “I fantasmi di Portopalo”, pubblicato da Mondadori, e, in seguito, con il titolo "La nave fantasma", un riadattamento teatrale, insieme al regista Renato Sarti e all'attore Bebo Storti. E ci sono storie e storie, ma quando il giornalista si imbatte in qualcosa che è più, nasce l’approfondimento, la testimonianza. Camus affermava che "il giornalista è lo storico dell'istante". Un pratico modo per rappresentare l’estrema importanza di una professione al servizio della memoria critica di un popolo. Dall’incontro di Balarm con l’inviato speciale de "La Repubblica", nel giorno della “Shoah”, e in occasione di un ciclo dedicato al tema dei migranti – “Lettere dall’Oltremare” –, è nata questa intervista su «le verità della memoria».
Giovanni Maria Bellu, sei nato a Cagliari e oggi sei romano d’adozione. Come giornalista investigativo ti sei occupato dei “misteri d'Italia”, dalla strage di piazza Fontana fino a Padre Pio. Nel giorno della Shoah un tuo corsivo, su “Repubblica”, è stato titolato : “La lezione di oggi ad una società smemorata”. Secondo te basta ricordare per avere una memoria?
«E’ necessario ricordare e mi vengono in mente due modi, di cui uno prevalente in Italia. Partendo da questo, c’è il modo “celebrativo”, che per la mia esperienza generazionale – anche se ho poco meno di cinquant’anni – si traduce nel rito, come ad esempio avviene per le celebrazioni della Resistenza. La ritualità ha però in sé una grande controindicazione: tende alla meccanicità, cioè al commemorare più che ricordare. In questo c’è una bella differenza, che ci fa passare all’altro modo. Ricordare vuol dire, infatti, applicare la lezione del passato al presente; individuare cioè, nel presente, il segnale di fatti che si sono verificati nel passato. La memoria così diviene attività e non passività, in pratica è un continuo elaborare. Questa è il tipo di memoria, a mio avviso, che anche se presente purtroppo non prevale».
Quali sono i modi per ampliare la memoria – che definisci “corta”, sempre nel tuo corsivo – e andare al di là del passato prossimo nel ricordo?
«Credo sia molto difficile convincere una persona della necessità di ricordare con argomenti esclusivamente moralistici o con richiami ai principi fondamentali. Bisogna avere, piuttosto, l’ambizione di trovare argomenti così forti da poter mettere in difficoltà anche le persone che teorizzano il dimenticare. A tale proposito penso che tra le ragioni forti del ricordo ce ne sia uno così banale da passare quasi in secondo piano, quello della sopravvivenza dell’uomo. Se noi guardiamo alle esperienze terrificanti, come ai genocidi di massa – il più grande di questi, per milioni di vittime, ricordato nel giorno della Shoah –, l’idea era che non si potesse più tornare indietro, cioè regredire; specie per quelli della mia generazione, nata a guerra finita, senza una memoria diretta dei fatti, ma anche cresciuti durante il boom economico e con l’uomo sulla luna. Genocidi, questi di cui parlo, che come fatti sono accaduti appena ieri l’altro rispetto ai tempi della storia. Ecco l’argomento fondamentale. Dire che si può invece tornare indietro e che tutto quello conquistato non è affatto acquisito per sempre. Dobbiamo individuare, quindi, nella nostra vita quotidiana, i segnali del possibile ripetersi di tragici errori e fondare su questo comportamento la necessità del ricordo».
In considerazione di queste tue parole, quale dovrebbe essere il ruolo del giornalista affinché la memoria divenga un “mai più” definitivo?
«Credo, intanto, che il giornalista, a parte informare, abbia un ruolo che si determina storicamente e, pertanto, debba ritrovare e ricostruire il contesto per spiegare un fatto storico e renderlo assoluto, cioè irripetibile quanto esso più riprovevole. Mi spiego meglio. L’obiettività assoluta per me non esiste, credo sia una balla, un feroce inganno. Se io vedo un uomo bianco, alto due metri, che bastona un bambino di colore di dieci anni, non posso dare asetticamente la notizia e dire soltanto “ieri è avvenuto questo fatto”. Chiunque darà la notizia farà capire che è stata una carognata. L’esempio mi è utile per confermare che l’obiettività assoluta non esiste, ma allo stesso modo l’agire deve essere ricondotto ad alcuni principi di riferimento da rispettare. Un giornalista che vive in Italia oggi, così come ogni altro nel mondo delle Costituzioni, non può non tenerne conto. Ma detto questo, qual è la maggiore difficoltà che nella “professione” si incontra nel raccontare un fatto? Il problema è sempre lo stesso: sapere a chi stai dando la notizia; e questo vale dal più piccolo giornale al New York Times. Se io racconto di un banale incidente d’auto, avvenuto a Palermo, ai palermitani, basta un accenno al quartiere e i lettori capiranno tutto quanto, ma se lo racconto agli svedesi devo aggiungere molti altri particolari. Lo stesso ragionamento vale anche nel racconto dei grandi fatti. Oggi in Italia, a mio parere, abbiamo questo problema, quello cioè di non avere più chiaro chi è il lettore, perché non c’è più chiarezza nei valori di riferimento che, intanto, credevamo acquisiti, ma che in realtà non lo sono affatto, e pertanto non abbiamo neanche chiaro il contesto».
Quindi l’importanza di ricostruire un contesto. Un esempio più concreto?
«Altro esempio, l’immigrazione. Pensavamo, noi della generazione dei Kunta Kinte (coloro cioè che hanno considerato il razzismo solo un fenomeno americano; leggendo “Radici” di Alex Haley, ovvero la storia di una comunità afro degli States), che il nostro patrimonio di solidarietà e ospitalità, non potesse essere attaccato da sentimenti razzisti o xenofobi, ma alla prova dei fatti ne siamo stati smentiti. Pertanto, da giornalista, ho una grossa difficoltà oggi a raccontarlo un fatto, se non ho chiaro i “valori” del mio interlocutore. Da qui il ruolo del giornalista è cercare di ritrovarlo e ricostruirlo il contesto, in questo assume corpo il passaggio dal giornalismo alla narrativa; nel senso che nel momento in cui il giornalista non ha chiaro il contesto di riferimento, con la narrativa la crea, costruisce lo sfondo. Solo in questo suo ruolo il giornalista può dare un contributo affinché la memoria sia un “mai più” definitivo. Poi ognuno lo svolgerà come vuole, rifacendosi alla narrativa o all’impegno politico, ma in ogni caso riconducendo quel medesimo ruolo a un sistema di valori».
Dalla solidarietà all’amicizia. Tu parli di una amicizia postuma ne “I fantasmi di Portopalo”, quella con Anpalagan Ganeshu, un ragazzo tamil che ha concluso il suo viaggio in mare, non raggiungendo l’Europa e le sue ambizioni di studio. Cito testualmente dal Prologo: «Non si può essere veramente amici se non si hanno nemici comuni». Ancora oggi, secondo te, chi sono i nemici di Anpalagan?
«E’ ovvio che quella è stata una scelta narrativa che mi è servita a rendere più chiari alcuni concetti; da quello di parlare ad un personaggio che è una vittima - senza mai, tra l’altro, dire che è morto -, a quello di mantenere in evidenza il fatto dubbio, anche per rispettare i dubbi dei familiari circa la realtà funesta di quel ragazzo. La ragione, poi, per cui uso questo “linguaggio crudo”, è la stessa ragione per cui ad un certo punto applico alcune norme del codice barbaricino. Il senso è quello di fare leva su un aspetto emotivo, che mi porta ad esprimere l’insopportabilità nei confronti di chi ha certe posizioni politiche e le sostiene, ma che vengono fatte passare per buoniste. Proprio per questo si ritorna alla domanda di prima: “qual è l’argomento per convincere una persona disinteressata?”. Ebbene: proprio dirgli “guarda che se non stai attento, ti ricapita”, e questo non è un argomento buonista, ma una vera e propria minaccia. Per riferirci ai nemici, invece, questi sono di due specie: quelli, per così dire, espliciti - cioè individuati, che sparano col fucile su di te -, e quelli, al contrario, ben più difficili da individuare, perché ti sembrano pure amici, oppure, ed è ancora peggio, hanno una visione superficiale e non vedono l’urgenza di certi problemi o trattano con sufficienza chi ne avverte l’urgenza. In quest’ultimo caso anche commettendo gravi errori, come ad esempio non facendo una legge di riforma del sistema di asilo quando sono al governo del Paese. Pertanto, per restare all’immigrazione, a parte i nemici evidenti dei tanti Anpalagan, come i leghisti e Borghezio, che lo dichiarano apertamente, ci sono anche quelli che impediscono alle persone di maturare delle convinzioni, a partire da alcuni principi fondamentali, che cioè distraggono dal problema».
Fermandoci a queste “distrazioni dai problemi”, come tu dici. Sullo stesso corsivo che abbiamo richiamato, tu scrivi «formidabile l’intuizione di Leonardo Sciascia, che quando parlava dell’Italia come un “paese senza”, si riferiva non solo alla memoria ma anche alla verità». Cosa ti senti di aggiungere a questo pensiero?
«Credo ci sia poco da aggiungere. Questo del carattere nazionale è un problema che è stato individuato sin dal momento in cui ci si è cominciato a ragionare sopra. Già il gene lo si può ritrovare nel "particulare" di Guicciardini. Quando Sciascia ha denunciato l’inesistenza in Italia di una opinione pubblica in grado di controllare e condizionare il potere, stava in altra forma dicendo sempre questo. Ma anche negli anni cinquanta, uno studio sul carattere nazionale italiano, condotto da una studiosa straniera, forse un’inglese, ha evidenziato l’assenza di un riferimento pubblico, cioè di valori condivisi, del senso dello Stato, e questo porta in parte a non avere una memoria comune e quindi a confermare l’analisi dei “senza” di Sciascia».
Per tornare ancora ai migranti. Secondo lo scrittore Erri De Luca, intervistato da Balarm sullo stesso tema, non si può associare il fenomeno della immigrazione odierna a quello dei nostri nonni, perché a suo dire i nostri partivano portandosi dietro qualcosa, mentre oggi questi “disperati del mare” si lasciano alle spalle tutto. Tu cosa pensi?
«Credo in realtà che l’immigrazione sia un fenomeno composito. Sicuramente è vero che crea maggiori problemi, anche di coscienza oltre che ricettivi, ed in questo è molto diverso da quello dei nostri nonni. Oggi chi fugge con le “carrette del mare” lascia tutto dietro, ma quello che però somiglia abbastanza all’emigrazione dei nostri nonni è l’altro aspetto, quello di chi va via per migliorare la propria condizione e mandare i soldi alle famiglie. Il fenomeno di oggi è composito perché c’è chi arriva da noi senza essere stato chiamato, senza rientrare in qualche quota, per cercare lavoro, ma c’è anche l’altra immigrazione, quella di chi abbandona tutto, dell’esule. Ed è abbastanza spaventoso che le due cose vengano confuse. La questione degli esuli, rientra nel campo di alcune norme sacrosante, riconosciute da tutti gli stati di diritto, e non può essere sottovalutata. Noi abbiamo il dovere di ospitarli. Quando arriva una di queste barche sulle nostre spiagge, possiamo decidere di non ospitare gli esuli, ma dobbiamo uscire dalla Convenzione di Ginevra del ’51, dobbiamo cambiare alcune norme fondamentali della nostra Costituzione, anche la Carta delle Nazioni Unite e allora poi possiamo dire che non accogliamo i rifugiati. Adesso non possiamo dirlo, tant’è vero che li espelliamo ”illegalmente”. Vengono fatte delle istruttorie in modo così sommario che possiamo asserire, senza i dovuti accertamenti, che un sudanese non lo sia e deciderne l’espulsione. Fatti di persone che non sono state sostenute durante la Shoah ci fanno inorridire, ma alcune di queste cose vengono fatte regolarmente ancora oggi a Lampedusa, quando vengono rimandate indietro più di mille persone in ventiquattrore».
Restando a De Luca. «Lo scrittore non incide sulle coscienze. E’ un semplice testimone», questo è ciò che ci ha detto, limitatamente alla sua esperienza. Tu cosa ti senti di dire a chi si appresta a svolgere un lavoro come il tuo?
«Mi spiace che uno scrittore come Erri De Luca sia così pessimista, invece credo che con le cose da lui scritte incida sulle coscienze. Penso che ci sia una grande differenza tra lo scrivere in modo narrativo e lo scrivere in modo giornalistico. Anzi, specie all’inizio, molti arrivano al giornalismo perché amano scrivere, ma altri ci arrivano per motivazioni diverse, anche se poi questo gruppo ad un certo punto si rende conto che non è così. In pratica è come consigliare a un ragazzo che ama camminare di fare il postino, perché continuerà a camminare molto e lo pagano pure. Cosicché in principio il ragazzo lo fa volentieri il postino, ma poi si rende conto che non è come fare le passeggiate in montagna. Ecco, fare il giornalista è come fare il postino, fare il narratore è fare le passeggiate. Per questo motivo, pertanto, quando uno si avvicina al giornalismo deve essere consapevole di questa scelta, anche perché poi è sempre più complicato. Nel giornalismo ci sono ormai mansioni che sono sempre più tecniche e meno creative. Chi vuole avvicinarsi alla “professione”, ma pensa attraverso questa di volere intervenire nella società, ne deve tenere conto, anche se non so se questo sia il modo giusto per incidere».
Quanto ha inciso in te la vicenda di Anpalagn Ganeshu dal punto di vista umano?
«Dal lato umano la vicenda mi ha toccato molto, soprattutto il contatto con la famiglia. Mi ha colpito principalmente come l’assenza di un corpo su cui piangere porti all’impossibilità di elaborare il lutto. La famiglia Ganeshu continua a pensare che il figlio sia ancora vivo. Anche perché continuamente la vicenda ritorna nello Sri Lanka, dove diverse famiglie sostengono di avere sentito notizie dalle radio o telefonate di terze persone che affermano il contrario di ciò che è avvenuto. Qualche tempo fa lo zio di Anpalagan, che vive e lavora a Milano, mi ha detto che aveva sentito la sorella, cioè la madre del ragazzo, che gli raccontava dallo Sri Lanka che alla radio avevano annunciato che le persone di quella imbarcazione non erano morte, ma erano state arrestate. L’altra vicenda, quella interna (tra i pescatori di Portopalo), è che Salvatore Lupo, il pescatore che mi ha permesso di svolgere la mia indagine giornalistica, ha cambiato la sua vita in peggio. La comunità del suo paese lo ha isolato. Lui ha denunciato il fatto (cioè che i pescatori una volta trovato i cadaveri nelle reti li rigettavano in mare, per timore che la pesca venisse bloccata) per coscienza, ma è stato diffamato. In paese hanno messo in giro la voce che aveva preso soldi da Repubblica, il mio giornale, dai 200 ai 500 mila euro. Una grande falsità, un grave modo di dimenticare più che ricordare».
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
CINEMA E TV
È palermitana e la vedi ancora su Rai 1: chi è la nuova attrice in "Mina Settembre"
101.591 di Redazione -
STORIA E TRADIZIONI
Lasciò marito e figli, rischiò il carcere: una nobile siciliana fece follie per D'Annunzio
77.496 di Maria Oliveri

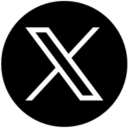



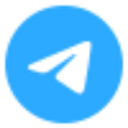


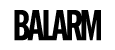





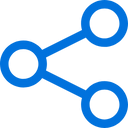
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram