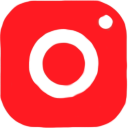TRADIZIONI
Il principe di Butera e i raffinati monsù: quanto è "francese" lo sfincione di Bagheria
Una storia antica su vizi e virtù delle famiglie siciliane. Tutto iniziò nelle cucine del palazzo del principe quando si ritirò a Bagheria. E continua ancora oggi

Lo sfincione bianco di Bagheria
Va da sè però, che la "nostra" storia in ciò che riguarda la cucina, come per l’arte, la cultura e la formazione del pensiero stessa, sia frutto di una stratificazione di dominazioni varie che hanno iniziato a caratterizzarci e consolidarsi nel tempo.
Nulla o quasi di autoctono si potrebbe dire. C’è anche chi formula pensieri con stratificazioni di "scimunitaggine", ma quella è un’altra storia... .
Siamo figli di una miriade di contaminazioni e influenze, per questo così variegati e predisposti al prossimo, con ognuna delle sue sfaccetature. Parlando di arte culinaria poi, siamo influenzati dai cugini francesi più di quanto ci piacerebbe ammettere.
Fu proprio durante il regno borbonico che si diffuse tra le famiglie nobili la consuetudine di avere in cucina i cuochi francesi, un modo in più per darsi delle arie!
Si tratta dei famosi “messieurs les chefs”, ma com’è nella consuetudine meridionale di semplificare e velocizzare tutte le parole d’importazione con il proprio dialetto, fu in seguito trasformato e ridotto in “monsù” sulla nostra bella isola, mentre a Napoli e dintorni, erano invece detti Monzù.
Molti dei piatti che mangiamo ancora oggi affondano le radici in un passato lontano lontano, letteralmente. Pare che tutto sia iniziato con Maria Carolina d’Austria, sorella di Maria Antonietta, bel tipino anche lei...quando sposò Ferdinando I di Borbone, sovrano del Regno delle Due Sicilie, volle che la sorella le inviasse i suoi amati cuochi francesi.
Ovviamente si campava d’invidia anche all’epoca e tra le nobili famiglie la presenza di “un francisi” in cucina divenne d’obbligo, e così ad ognuno il suo monsù.
C’erano vere e proprie dispute per accaparrarsi il monsù più famoso e celebrato che, come un parente, una volta assunto dalla nobile stirpe di turno, alle volte veniva chiamato con il proprio nome di battesimo e il cognome della famiglia in cui era a servizio.
Avere un monsù era ragione di orgoglio e vanto, anche perchè consentiva di offrire cene elaborate a base di pa- sti in cui si fondevano culture gastronomiche diverse e nuove tecniche, in cui mettere soprattutto in mostra, con sfarzo, le proprie possibilità economiche e il rango sociale.
Ai monsù si riconosceva un ruolo importante, non dei semplici domestici ma raffinati cuochi ai quali si offriva un’abitazione oltre che un compenso economico. Per i monsù siciliani l’influenza francese non fu traumatica, anzi, si trattò di una vera e propria integrazione di gusto e di sapori.
Poteva persino succedere che qualche nobildonna obbligasse il proprio monsù a recarsi nella capitale francese per acquisire nuove conoscenze.
In parallelo alla vita nelle nobili cucine si sviluppò, attraverso una sorta di fuga di notizie favorita dagli aiutanti, un tipo di cucina reinventata, derivata proprio da quella dei monsù, che diffuse le nuove ricette in tutto il regno, anche tra i non nobili.
I monsù furono di tre tipi: a stipendio fisso, pagati sia per cucinare che per provvedere all’acquisto dei più pregiati ingredienti per le loro preparazioni; a forfait, pagati in base alla quantità delle portate e ai coperti preparati in occasione delle cene; a partito, cuochi quasi "liberi professionisti" che potevano cucinare anche per altri, utilizzando la cucina nella quale erano stati assunti.
La figura del monsù acquisì via via sempre più rilievo, tanto che venne celebrata anche nella letteratura, basti pensare al “Gattopardo” o a “I Vicerè”.
Del resto, dal canto loro ebbero il merito di influenzare la cucina popolare con piatti che ritroviamo ancora oggi sulle nostre tavole.
Che vi verrebbe in mente se vi parlassi di ragù o gatò di patate? Oltre a leccarvi i baffi sia chiaro. Questi due esempi mi fanno vincere facile però, perchè già dal nome tradiscono la loro origine d’oltralpe...se vi dicessi invece “sfincione”? Tra le tante reazioni dubito ci sarebbe quella di collegarlo ai monsù.
Tutto iniziò quando nel 1650 il principe Giuseppe Branciforte di Butera, quello che fece costruire u stratuni, si ritirò a Bagheria. Non è chiaro, e mai lo sarà, se sia stato per la morte del figlio o perchè era fallito il suo complotto contro la corona per separare Sicilia e Spagna.
Nella nuova residenza si trasferì con lui l’intera corte, compresi i monsù...del resto non poteva restare digiuno a vita! Pare che fu lì che i servitori iniziarono a preparare per il principe e la sua famiglia una versione rivisitata dello sfincione delle monache del monastero palermitano di San Vito.
La sostanziale differenza risiedeva nel pomodoro, che caratterizza ancora oggi lo sfincione palermitano rispetto a quello baarioto, e che fu comunque introdotto dopo la scoperta dell’America. Direi che a questo punto non c’è bisogno di sottolinearvi che lo sfincione di Bagheria sia più aderente alla versione tradizionale.
A dirla tutta però l’origine dello sfincione è ben più antica e pare affondi le sue radici nella tradizione araba o addirittura greca, con ingredienti molto diversi come il pollo e i piselli.
Chiaramente i cuochi del principe preferirono utilizzare materie prime del territorio che lo caratterizzano ancora oggi, e non possiamo che essergliene grati, tra queste ovviamente le sarde di Aspra.
Immaginate cosa doveva essere la versione originale? Benedetti monsù e principe di Butera! Ancora oggi, origine legata ai monsù o meno, lo sfincione è la delizia tipicamente baariota per eccellenza e ormai, lo diciamo non senza un filino di orgoglio, ce lo riconoscono proprio tutti.
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
STORIA E TRADIZIONI
Stella, moglie del "Principone": a chi si ispira la principessa di Salina del Gattopardo
191.288 di Susanna La Valle -
ARTE E ARCHITETTURA
Il nome è innocuo ma ha un passato oscuro: il Mercato di Palermo dove trovi tesori
70.807 di Susanna La Valle

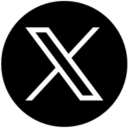



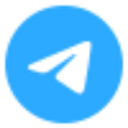


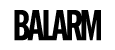






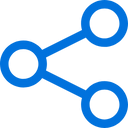
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram