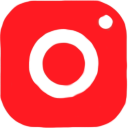Il canto delle donne: Beatrice Monroy racconta le protagoniste della Lirica in Sicilia
Il desiderio di sublimare la vita delle donne dell’Opera nasce in Beatrice dall’infinito amore per il racconto che si fa testimone delle ipocrisie e delle perversioni della società

Beatrice Monroy durante "Vi racconto l'opera" al Teatro Massimo di Palermo (foto di Fausto Brigantino)
Si definisce così Beatrice Monroy, scrittrice e drammaturga palermitana, autrice per RAI-Radio3 e docente di drammaturgia alla Scuola dei mestieri dello spettacolo di Emma Dante al Teatro Biondo di Palermo.
La Editoria & Spettacolo di Spoleto, con il suo illuminato direttore Maximilian La Monica, ha appena pubblicato il suo ultimo libro, Custodi del silenzio, dedicato alle storie, per l’appunto, delle celebri protagoniste della Lirica.
«Non sono mai stata una melomane. Lo era mia sorella Gabriella che mi portava con lei a teatro. Poi un giorno, anzi una mattinata, di cinque anni fa, all’alba – erano appena le sei – il Sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo, Francesco Giambrone, che ben conosce la mia passione per il racconto, mi ha chiesto su Messenger di raccontare le opere al pubblico, progetto che è poi diventato “Vi racconto l’opera”».
Con il prezioso sostegno di attori e attrici, Stefania Blandeburgo, Rinaldo Clementi, Ester e Maria Cucinotti, Giuseppe Cutino, Nunzia Lo Presti e Sabrina Petyx, Beatrice, prima di ogni Prima, racconta in modo avvincente la storia, la trama dell’opera che andrà in scena al Massimo, per aiutare gli spettatori a meglio comprendere il percorso di vita dei personaggi.
Lo stesso Giambrone dice che il teatro è anzitutto un luogo di narrazione, uno «spazio che racconta», un laboratorio di emozioni e formazione, che serve a fare comunità, che aiuta a essere concittadini, persone. Non è solo divertimento, intrattenimento, come ci fa credere l’attuale classe politica.
Le opere, inoltre, non sono creature lontane e polverose, siamo noi che abbiamo fatto l’errore di considerarle così. Esse raccontano di noi, attraversano lo spazio e il tempo e si fanno portavoce di idee e suggerimenti preziosi».
Nei libretti, spesso snobbati quali modeste prove letterarie, continua Giambrone, si celano autori notevoli come Lorenzo da Ponte, Salvatore Cammarano o Arrigo Boito e si palesano «storie vere che raccontano molto di più di ciò che sembra all’apparenza».
La storia, del resto, è etimologicamente una ricerca, una narrazione che (si) arricchisce aprendosi a mondi altri di cui si fa interprete e tramite: in questa prospettiva, conclude, «le opere liriche narrano anche di noi, dell’Italia perbenista e ipocrita dell’Ottocento come di quella d’oggi, blindata nelle sue regole esclusive, di personaggi che, avendo osato sfidarle, si trovano a combattere per sopravvivere, per un ideale, per un amore.
Beatrice è riuscita in questo: la sua narrazione svela la ritualità perversa della società e prova a ridare voce a quelle donne che, seppur “raccontate dagli uomini”, appaiono ancora “coraggiose e consapevoli” del loro ruolo».
Coinvolgere le nuove generazioni attraverso il ricorso a tutte le armi della modernità tecnologica è infine per Giambrone l’unica possibile soluzione affinché il teatro italiano continui a vivere e a sublimare la sua comunità. Beatrice si è formata con maestri del calibro di Eugenio Barba, Michele Perriera e Giuliana Saladino, ha “veleggiato”, direbbe Melville, “per oceani e biblioteche”, frequentando i teatri del mondo e lasciandosi sedurre da autrici energiche come Emily Dickinson o delicate come Aki Shimazaki, ama Antonio Gramsci e Salman Rushdie, la logica del mutamento della filosofia cinese e le suggestioni della fisica quantistica, Elsa Morante e l’apocalittica Margaret Atwood del famoso Racconto dell’ancella, da cui è stata tratta una splendida serie tv.
Considera il teatro una «forma spirituale, un percorso di crescita intima e collettiva. Chi crea ha sempre una grossa responsabilità nei confronti degli altri». L’amore per il racconto affonda le sue origini nell’infanzia, quando i suoi genitori, biologo il padre e chimica la madre, in giro per il mondo, lasciavano lei e le sue sorelle dalla nonna Cornelia, raffinata donna bergamasca che, ogni sera, incantava le nipoti con le sue storie narrate al buio della camera e alla luce dei sogni.
Beatrice scrive le sue storie anche per gli attori, per vedere i suoi personaggi animare quello spazio alternativo di vita che è il teatro, lo stesso spazio abitato dalle donne della Lirica, dalla Violetta di Verdi, «un uomo sicuramente avanti per i suoi tempi, ma indissolubilmente ancora legato ai codici dell’epoca che in fondo non sono tanto diversi da quelli di oggi».
Le donne della Lirica finiscono sempre per soccombere agli schemi e agli schermi della società, si fanno testimoni di un sacrificio, il loro, che serva da monito per tutti, da modello educativo e culturale: accettano e scelgono sempre quella morte che si fa salvezza, redenzione per aver osato vivere se stesse. Il loro sacrificio insegna a comportarsi e ristabilisce l’ordine dopo la trasgressione, tragico sinonimo di vita autentica.
Così «si assesta una società: alzando muri, rendendo i propri confini invalicabili e definendo colpevole colui che è diverso». Esse sposano l’idea di un intimo silenzio, tornano all’ovile, vengono santificate ed eroizzate per il loro sacrificio e diventano a loro volta sentinelle, custodi, «kapò» di altre donne invitate al silenzio, «donne contro donne», prigioniere-custodi di altre prigioniere affinché nessuna si permetta di volare troppo in alto.
Come poteva essere altrimenti Violetta Valery, la raffinata e ricca prostituta della Parigi della Belle Époque? Non sarà la tisi a condurla alla morte ma il dolore di aver negato se stessa, il suo sacrificio, l’aver osato pretendere di uscire dal suo ruolo, non per essere semplicemente amata da Alfredo, ma per essere finalmente notata, riconosciuta, apprezzata.
Violetta è la traviata, la donna che non può più tornare indietro, la perdutamente marchiata, l’anti- vergine per antonomasia, specialmente in quel periodo in cui Papa Pio IX sancisce il dogma- modello dell’Immacolata Concezione, della Vergine Maria, della donna-Madre, che, “utero- contenitore”, esiste per concepire passivamente il Figlio di Dio, senza quel desiderio che è sempre peccato: «la Madre non desidera, contiene, […] è bellezza in quanto castità, ogni altra bellezza è marginale, sporca e sacrificabile».
Alfredo è solo «il ragazzo di buona famiglia [che] si è innamorato di una puttana» e lei non si può permettere di vivere un incanto. È Germont, il padre di Alfredo, a riportarla coi piedi per terra, investendola del ruolo di custode responsabile di un’altra donna, la figlia: se Alfredo sposerà una puttana anche l’altra figlia di Germont, “pura siccome un angelo”, avrà la reputazione irrimediabilmente rovinata.
Violetta si deve fare da parte, accetta il sacrificio, il «patto infernale» col mancato suocero, finge di amare un altro davanti al caro Alfredo, «si copre la testa con il manto azzurro», diventa santa, eroina.
Nonostante il contentino finale, in cui Alfredo scopre tutta la verità e si pente, disperato, di averla rigettata nel suo ruolo di prostituta, è ormai troppo tardi: Violetta muore in un ultimo sussulto di gioia per quell’amore ritrovato che è anche e soprattutto amore per se stessa, libera dalla calunnia, dai pettegolezzi della società, della folla.
Quella stessa folla, il pubblico, che come accadeva per l’antica Tragedia greca, uscirà dalla sala del teatro con gli occhi lucidi, “purificata, soddisfatta”, indossando cappotti e pellicce e fischiettando magari qualche aria ascoltata, mentre sul freddo tavolato del palcoscenico rimarrà il fantasma dell’eroina morta: «io sono una santa morta», canta di lei Beatrice, «abito qui nella tomba che li rassicura».
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
GLI ARTICOLI PIÚ LETTI
-
STORIA E TRADIZIONI
Stella, moglie del "Principone": a chi si ispira la principessa di Salina del Gattopardo
191.926 di Susanna La Valle -
ARTE E ARCHITETTURA
Il nome è innocuo ma ha un passato oscuro: il Mercato di Palermo dove trovi tesori
71.515 di Susanna La Valle

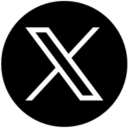



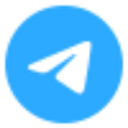


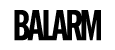





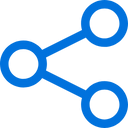
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram