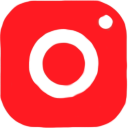Un cantastorie al tempo di Spotify: la storia di Nonò dai vicoli siciliani alla Rai e ritorno
A nominarlo cantastorie sono stati giornalisti e pubblico: ascoltare un cantastorie come Nonò (sempre che lo si trovi) impone di ripopolare la piazza, la via, i piccoli borghi
Nato a Sutera (Cl) nel 1945 – quando ancora questi artisti si esibivano per le strade – dal poeta dialettale Salvatore. La sua attività inizia quasi per investitura, a quanto lui stesso racconta, perché diviene cantastorie «a furor di popolo».
Giacché, racconta Nonò, «a nominarmi cantastorie sono stati i giornalisti e il pubblico. […] Iniziai a cantare da bambino e partecipai a un concorso di voci nuove indetto dalla Rai e fui uno dei premiati. In quella occasione un regista di Torino stava preparando uno spettacolo sulla poesia di Ignazio Buttitta (era il 1970) e mi propose, dopo avermi fatto il provino, di musicarne le poesie e di cantarle nello spettacolo, tutto rigorosamente in dialetto o meglio in lingua siciliana…». Continua Nonò a raccontare la sua carriera: «Così continuai a fare teatro riscuotendo sempre successo e tornando in Rai in diverse trasmissioni, la più bella Blitz di Giovanni Minoli con Gianni Minà».
Emigra giovane il cantautore, neanche ventenne, andando a Milano e a seguire verso la Germania e di nuovo verso Sutera; quindi Torino, perché la Sicilia è terra di tradizioni ma non di promesse.
Tanti mestieri, a partire dal lavoro di operaio edile a quattordici anni. Legato a Rosa Balistreri (leggi di più sulla cantante) da una carissima amicizia e attraverso intense tournée, a Torino conosce Ignazio Buttitta del quale musicherà diverse poesie (tra le altre U lamentu pi la morti di Salvatore Carnevale e Lu Trenu di lu Suli). Ha inciso numerosi dischi (V’aiu a lassari, L’uomo e la natura, Ventimila picciriddi, Focu ardenti tra i tanti), si è esibito in diversi spettacoli teatrali, e un libro sulle storie paterne in versi è in corso di pubblicazione col patrocinio del Comune di Sutera.
Negli Usi e costumi credenze e pregiudizi del popolo siciliano (1870), Giuseppe Pitrè offre una descrizione vivida, finanche prossemica e scenografica dei cantastorie.
A quelle poche e pregne pagine non manca che il supporto sonoro: "…il contastorie coi movimenti degli occhi, della bocca, delle braccia, de’ piedi conduce i suoi personaggi, li presenta, li fa parlare come ragione vuole; ne ripete per punto e per virgola i discorsi, ne declama le aringhe; fa schierare in battaglia i soldati, li fa venire a zuffa agitanto violentemente le mani e pestando coi piedi, come se si trattasse di una zuffa vera e reale. […] Il bollore cresce: gli occhi dell’oratore si spalancano, le nari si dilatano per la frequenza del respiro, che sempre più concitata fa la parola".
Il poeta-rapsodo trasformava una via o piazza – di volta in volta – in un campo di battaglia, in un quadro intimo e antico, in un frangente storico. E tutto partecipava alla narrazione, la quale durava per due ore: bocca, occhi, braccia, postura, respiro, l’aria tutta féssa nel suo impeto, e l’architettura urbana intorno che trasfigura nel mondo cavalleresco, rurale, passato e presente.
A quale sorte sono destinati i cantastorie? «Io penso che come tante cose – spiega Nonò – anche il cantastorie ci sarà sempre; col tempo si trasformerà, del resto, e noto che tanti cantautori si definiscono cantastorie, pensiamo a De Andrè, De Gregori; persino Baglioni e tanti altri… […] Allora andava bene, non c’era la televisione, le forme di spettacolo erano scarse; pochi sapevano leggere, le notizie erano solo quelle del paese o al massimo quelle dei paesi vicini, di conseguenza quando arrivava un cantastorie e si raccontavano e cantavano quelle storie con tradimenti e tanti morti, la gente si entusiasmava, era suggestionata e incantata da quell’artista affabulatore e bravo. Oggi non basta più! […] Anche il cantastorie deve cambiare modo di rapportarsi con il pubblico…».
Nella trasposizione musicale del sentimento popolare resiste caparbiamente un contenuto spicciolo, non complicato dai grovigli intellettuali, una lingua che rifiuta e demistifica la complessità.
Ma c’è opposizione fra il popolare di allora e quello di oggi, i cui araldi sono i vari Mambo Salentino, Fabio Rovazzi, Baby Key. Lo spolpamento semantico passa dal lessico, shakerato ritmicamente alla fuffa, versato dentro motivi annoiati e spersonalizzanti ma commerciabili.
La musica trap come esempio – Myss Keta, Achille Lauro, Massimo Pericolo – che mortifica il vocabolario italiano al massimo grado immaginabile, involvendo le parole in gemiti e grugniti semivolontari, voluttuosi e pateticamente provocatori.
Qualche scalino più in basso rispetto lo sviluppo dell’apparato fonatorio. Il genere “organizza” testi privati che gli ascoltatori ricevono e riassociano al proprio vissuto, cercando una catarsi per le vicende della propria giovanissima biografia che adesso non è più isolata, divenendo le emozioni in essa contenute condivise, e non solo postate e violate nel loro pudore.
Il cuntastorie no, egli compie un procedimento inverso: attinge a un patrimonio collettivo, alle memorie storiche e fantastiche, antropologicamente e letterariamente sedimentate, offrendo e chiedendone la condivisione come avveniva decine d’anni fa. Un bagaglio sfortunatamente scollegato dalla rete, isolato, quindi segreto e intimo.
La moda-tendenza contro il patrimonio: la prima la si subisce supinamente, è per suo statuto e capriccio effimera, trova valore nella sua autoreferenzialità e non implica emozione che non sia quella (dubbia) d’identità solitaria nella sua omologazione; il secondo è una costruzione corale e resistente, attorno a esso ci si raccoglie (raccoglieva) attivamente garantendo il tramandamento, riattivando un repertorio diffuso, come individui dotati di propri sentimenti riconoscibili e immersi in una comunità affine.
Ascoltare un cantastorie come Nonò (sempre che lo si trovi) impone di ripopolare la piazza, la viuzza, i borghi del proprio paese; richiede di disinserire il jack e ridestare tutti i sensi, osservare il contesto urbano e le sue armonie offese, rioccupare gli anfratti del pensiero una volta dediti alla fantasia e oggi muffiti, nel tentativo di rievocare quei personaggi – i paladini di Francia, i contadini residui, lu scarparu (calzolaio) e lu firraru (chi lavora il ferro) e gli altri mestieri dimenticati – e far loro rivivere tali spazi. I cuntastorie sono portatori di una cultura innocente e oramai quasi mitica, di un vitalismo incontaminato.
Offrono (offrirebbero) un servizio pubblico in sostituzione all’aridità narcisistica ed egemone. Per riprendere quanto scriveva il Pitrè: «Questa si chiama, popolarmente parlando, arte vera: e questa comprende, sente e vuole il popolo adulto».
Un tramonto, questo, che varrebbe la pena mirare un’ultima volta, fotografare. Pio Rajna, nella Nuova Antologia del 1878, in merito ai brani di letteratura popolare da lui raccolti, scriveva: «La nave del Medio Evo è affondata da un pezzo, eppure qua e là si vede ancora galleggiare in mezzo ai flutti qualche tavola, qualche frammento d’albero.
Conviene affrettarsi a raccoglierli e metterli in salvo, prima che il mare li abbia inghiottiti per sempre. È un’opera meritoria, della quale coloro che verranno dopo di noi ci saranno grati non poco».
|
Ti è piaciuto questo articolo?
Seguici anche sui social
Iscriviti alla newsletter
|
I VIDEO PIÚ VISTI
-
CINEMA E TV
Masterchef "s'asciucò Gianni": il siciliano in doppiopetto lascia il programma
7.517 di Redazione -
ITINERARI E LUOGHI
In Sicilia dove il tramonto diventa magia: tutti i luoghi (nascosti) da dove ammirarlo
4.136 di Redazione -
ITINERARI E LUOGHI
Il gioiello delle Madonie rinasce d'inverno: anche in bianco è il paradiso in Sicilia
3.003 di Redazione

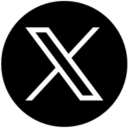



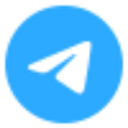


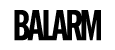

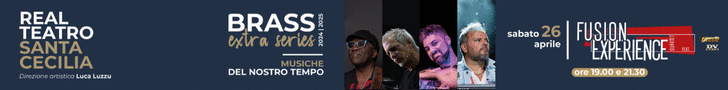



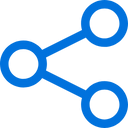
 Seguici su Facebook
Seguici su Facebook Seguici su Instagram
Seguici su Instagram Iscriviti al canale TikTok
Iscriviti al canale TikTok Iscriviti al canale Whatsapp
Iscriviti al canale Whatsapp Iscriviti al canale Telegram
Iscriviti al canale Telegram